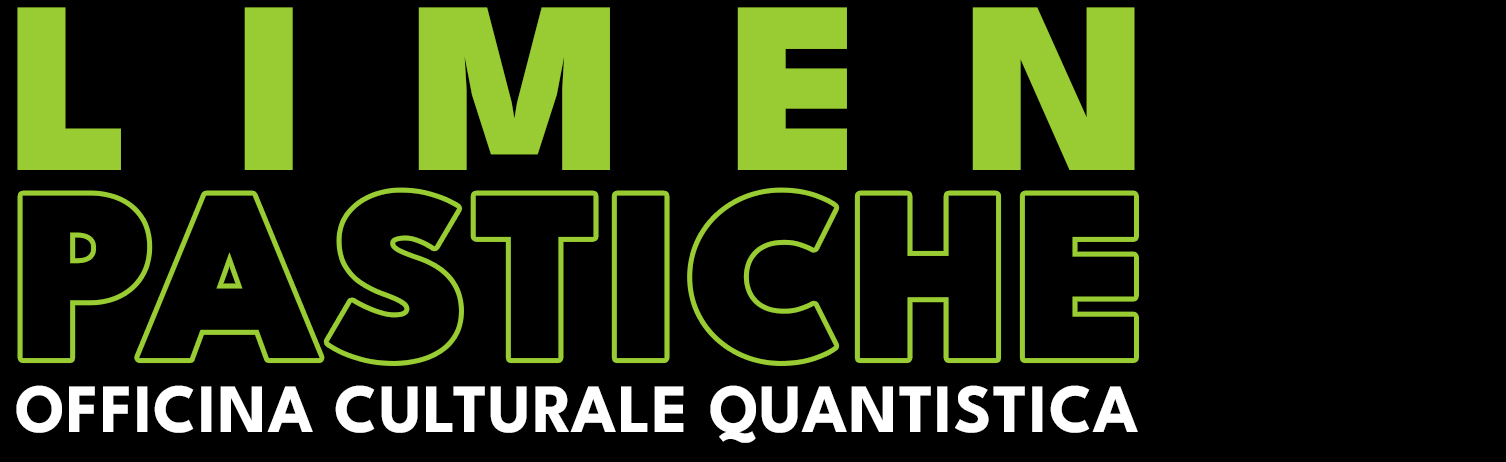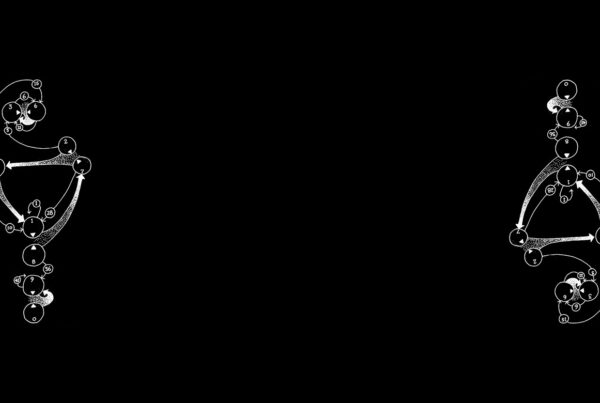Testi di
Odissea Di Bernardo
Fotografie di
Alice Migliavacca
Editing di
Simone La Penna
Alice Migliavacca
Categoria
Passaggi viscerali
Torre d’avorio
Data di pubblicazione
23 Marzo 2023
Attraversate dalla violenza
Critica della figura della vittima di violenza sessuale
Abstract: Si propone di analizzare la figura della vittima di violenza sessuale, come questa è stata descritta, narrata e costruita, e come questa narrazione sia problematica. Difatti vittima è un termine paralizzante che spesso tende a deumanizzare e allontanare il soggetto, un essere per cui provare pietà o da innalzare a portatore di valori morali, di verità incontestabili, simbolo di resistenza, forza e perdono. Proprio per restituire agentività alla donna violentata, per ridarle il potere sulla propria vita, di recente è stato adottato il termine survivor (sopravvissuta) per definire chi è passata attraverso l’esperienza traumatica dello stupro. Tale definizione però appare inesatta e limitante, in quanto riduce la donna al suo trauma e la definisce in base ad esso, il suo stupro diviene il perno della sua vita, una vita non più vissuta, ma cui si sopravvive, una vita che si trascina, spezzata e rotta per sempre. Siccome le parole costruiscono, influenzano e ingabbiano le nostre identità, è bene cominciare a pensare a una definizione diversa, a un diverso modo di nominare le vittime, che non le renda inermi e passive ma neanche bambole rotte non più recuperabili.
C’era una volta una principessa chiusa in una torre.
Si era rinchiusa lì da sola, dopo essere stata aggredita da un mostro tornando a casa. Quella sera indossava un abito bianco e lungo, il suo preferito, che le era stato strappato via con violenza da artigli affamati e affilati, artigli che le avevano attraversato la carne, sporcando il suo vestito irrimediabilmente.
Era rimasta lì, a terra, per tanto tempo, con il vestito rotto e il sangue che continuava a colarle sulle cosce.
Le sue mani si erano completamente tinte di rosso, mentre cercava di ripulirsi, mentre cercava di rendersi presentabile agli altri e a sé stessa.
Ma la principessa non riusciva a levarsi dagli occhi l’immagine di tutto quel sangue, filo rosso che la perseguitava di giorno e di notte, che le sembrava ancora di vedere scorrere fra le sue cosce e dalle sue mani che tentavano di scacciarlo via, della sua innocenza perduta, di quella bocca spalancata un istante prima di divorarla. Non riusciva più a vivere, non riusciva a uscire, a incontrare persone, a parlare.
Non riusciva più a fare niente, era diventata l’ombra di sé stessa: pesava la metà, il suo viso era scavato e perennemente rigato di pianto. La violenza l’aveva modellata a sua immagine, aveva apposto sul suo corpo il suo marchio di fabbrica.
E così si era rinchiusa nella sua torre, aspettando un principe che venisse a salvarla, perché lei ormai era troppo debole, sopraffatta dal dolore, dalla sofferenza, dal peso di quell’evento, una vittima dilaniata da un mostro che tornava ogni notte nei suoi sogni a strapparle l’anima con i suoi artigli lunghi e affilati e a ricordarle quanto lei non avessei possibilità di sfuggirgli ancora oggi, quanto fosse destinata a rimanere a terra, con il vestito strappato e tutto quel rosso a levarle il respiro.
La principessa sta ancora aspettando il suo principe, un principe che le ridia il sorriso, la gioia, la vita.
Se passi di lì, in quei brevi momenti in cui si affaccia dalla finestra, puoi vederla anche tu. La riconoscerai subito: ha il volto della violenza.
La violenza sessuale ha un volto: un volto livido e tumefatto, con occhi grandi, rossi e pieni di pianto.
La violenza sessuale ha un corpo: un corpo pieno di vergogna, che si scusa quasi di esistere, un corpo pieno di segni lividi sangue – medaglie alla resistenza.
La violenza sessuale è riconoscibile, ha i suoi tratti distintivi, visibili a tutti: lividi viola ferite oscene occhi gonfi contornati da occhiaie; una sofferenza evidente una tristezza sempre presente accompagna la vittima come un’ombra.
È impossibile anche solo pensare che quel dolore, quella tristezza, possano nascondersi bene, possano anche sparire ogni tanto, possano non accompagnare le donne per sempre.
Possano non definirle.
La violenza sessuale ha il volto della principessa affacciata alla finestra.
Ha il volto che troviamo riprodotto in centinaia di campagne di sensibilizzazione che si affacciano sulle
strade, sui social, sui giornali ogni 25 novembre. Immagini con al centro la vittima: ripiegata su sé stessa, ricoperta di lividi e sangue, circondata da frasi colpevolizzanti come “volta le spalle alla violenza, denuncia”[1].
La donna è l’unica attrice sulla scena. La principessa, oggetto della violenza, è l’unica rappresentata.
Del soggetto violento non c’è traccia. Dell’unico soggetto non c’è traccia.
Il mostro che l’ha trasformata nella vittima perfetta, eterna prigioniera della sua torre, non c’è, è invisibile. È un mostro, e in quanto tale non può trovare spazio nella sfera dell’umano, nella rappresentazione dell’umano. Così, l’artefice dello stupro non è rappresentato né rappresentabile.
È il rimosso.
E lo stupro è lividi, sangue, graffi, segni materiali di una violenza tangibile, visibile e fisica, carnale, o almeno così crediamo, immersi in queste rappresentazioni figlie di una narrazione unica che costruisce arbitrariamente la figura della vittima di violenza sessuale: una principessa, povera e indifesa, che aspetta di essere salvata, una vittima eterna incapace di vivere.
Ma questa figura non è reale: è artefatta, totalmente costruita da mani maschili smaniose di tenere le redini di un cavallo bianco per ergersi a salvatrici.
La principessa della nostra storia in realtà non è mai stata chiusa in quella torre. Alla finestra non c’era nient’altro che un’Elena di Troia, un simulacro, un fantasma lì posizionato da una data cultura e società.
La principessa della nostra storia è una ragazza normalissima, è la ragazza che ti passa affianco per strada, quella con cui incroci lo sguardo in metro, l’amica con cui prendi un caffè al bar, con cui parli liberamente di sesso e quella con cui vai a ballare in discoteca.
La principessa della nostra storia non è individuabile, perché la violenza non ha volto, o meglio, un volto ce l’ha: è il volto di ognuno di noi, anonimo, senza particolari segni distintivi che ci consentano di riconoscerlo. La violenza non è lividi, graffi, sangue; non è solo sanguinante, passionale, feroce e bestiale: la violenza è nuda, umana, fredda e razionale, invisibile e pervasiva. Gli unici lividi indelebili delle vittime non sono sul corpo, ma nell’anima, lividi permanenti, lividi dell’interiorità che non possono trovare spazio all’interno dell’iconografia della violenza[2]. Sono gli eterni assenti, assenti dal discorso pubblico ma anche dal discorso privato[3], e ciò fa in modo che si nasconda il carattere subdolo, invisibile e pervasivo della violenza, che tesse il reale e imprigiona tutti nelle sue maglie strette.
È la cultura, insieme alla società, a modellare non solo la nostra forma mentis ma anche la nostra stessa identità, attraverso raffigurazioni, narrazioni, miti reiterati più e più volte fino al loro instaurarsi nell’immaginario collettivo e rendersi unica realtà possibile e pensabile.
L’identità dell’umano si costruisce nella narrazione[4]. Solo nella narrazione, difatti, si ritrova un*Io organico, unitario; nell’esperienza della vita quest* Io saldo, solido, è disperso nella molteplicità degli istanti, nella sequenza di eventi più o meno importanti che si susseguono nel corso delle giornate[5]. Ci costituiamo a partire dall’Altro[6]: solo specchiandoci nell’Altro, solo venendo riconosciuti da un’altra coscienza (e riconoscendo un’altra coscienza)[7] riusciamo a riconoscere noi stessi.
Ci presentiamo agli altri: nel nostro apparire all’altro ci mostriamo esistenti e nel modo in cui scegliamo di narrarci all’altro, attraverso le nostre azioni e le nostre parole, costruiamo il nostro Io, diamo alle nostre azioni e ai nostri discorsi, agli eventi apparentemente slegati delle nostre giornate, un’unità, una continuità e una linearità che ci consentono di dire: io sono questo, sono queste parole, sono queste azioni[8].
Ci raccontiamo all’Altro: e raccontandoci all’altro ci raccontiamo anche a noi stessi, troviamo la nostra essenza, quello che pensiamo essere il nostro nucleo essenziale.
Il modo in cui ci narriamo definisce chi siamo, ma allo stesso tempo questa nostra narrazione è invischiata nel contesto socio-culturale in cui agiamo.
Per questo è tanto importante analizzarla, studiarla, capirla e decostruirla: decostruire per poter costruire una nuova narrazione che sia sempre più nostra. Ed è questo che vorrei fare qui: analizzare e (cercare di) decostruire la figura della vittima di violenza sessuale, una figura che ci è stata narrata sempre da altri, mai da lei stessa, una figura che è stata plasmata da mani estranee che l’hanno resa una scultura di vetro, un oggetto fragile, prezioso e inanimato.
Mani estranee che modellandola l’hanno resa aliena a sé stessa: non sa neanche lei raffigurarsi in altro modo che non sia quella scultura vitrea, non è padrona del suo corpo e delle sue percezioni e spesso finisce per non riuscire a comprendere di essere stata violentata.
Non perché sia stupida, anzi, ma perché la sua violenza non rispecchia LA violenza.
Non rispecchia la narrazione che ne è stata fatta da sempre: una violenza raccontata da voci maschili che hanno imputato a un mostro la colpa dello stupro, un mostro non umano e violento, che lascia sul corpo della vittima lesioni fisiche, che la aggredisce nel buio di una strada[9] e usa la forza brutale per averla, per forzare la sua resistenza[10]. Il mostro che ha aggredito la principessa sulla strada di casa può essere solo un mostro, uno sconosciuto, mai un amico, un marito, un compagno, un padre, un fratello, ma sempre e solo un uomo affetto da turbe psicologiche che lo portano a deviare dalla strada della sessualità normale, ignorando la complessità che riveste il fenomeno e ignorando il fatto che riguardi tutti gli esseri umani e il sistema socio-culturale in cui sono immersi.
La nostra vittima-principessa-scultura vitrea è avvolta da questo racconto maschile, da queste voci suadenti che le raccontano la sua storia, come da un piumone in estate: una carezza soffocante, bruciante, che le impedisce di venire a contatto con la realtà, fredda e agghiacciante in un primo momento ma poi sollevante e addirittura piacevole.
E queste voci calde le narrano della sua identità, della sua sofferenza, della sua violenza, unica, fissa e immutabile: è la violenza della principessa. Altre forme non esistono, e se per caso la nostra bella statuina dovesse imbattersi in qualcosa di diverso ma altrettanto doloroso, quella non sarebbe violenza, neanche lei riuscirebbe a definirla come tale, non riuscirebbe a nominarla e di conseguenza ad affrontarla.
Prenderebbe sulle sue spalle minute tutto il fardello della responsabilità, si crederebbe unica colpevole, meritevole di ciò che le è accaduto[11], e da questa responsabilità uscirebbe fuori un gorgo di vergogna pronto a risucchiarla.
La vergogna infatti sembra accompagnare naturalmente lo stupro: è naturale che una donna possa vergognarsi di parlare della sua violenza, possa non parlarne mai, possa nasconderla agli occhi del mondo sotto strati di fondotinta come fosse un’imperfezione, un proprio difetto da cancellare. Quando in realtà la violenza non è affatto qualcosa di cui vergognarsi, qualcosa da nascondere: la violenza è una colpa della società e della cultura, e l’unica a non doversi vergognare è proprio chi l’ha subita.
Le voci narranti non ci raccontano però che solo per mano umana lo stupro si inscrive nella sfera della vergogna e dello scandalo: nell’Ancien Regime lo stupro era definito nel diritto come un crimine contro la moralità, un crimine che si configurava prima di tutto come piacere illecito, non ferimento o aggressione illecita, ma gesto di lascivia, appartenente all’universo della lussuria, del peccato e della colpa[12]. L’attenzione era posta sulla trasgressione morale, trasgressione che includeva la vittima, partecipe del peccato, sporcata irrimediabilmente: il suo onore e la sua purezza venivano macchiate per sempre e la sua identità era completamente trasformata agli occhi del mondo.
L’oscenità macchiava non solo il suo vestito bianco e le sue mani, il suo volto, ma anche il suo nome. Il suo stupro la seguiva ovunque, non poteva sfuggirgli da nessuna parte. Nel corpo avrebbe sempre portato impresso il suo marchio di fuoco, che la condannava a una vita da esclusa.
Colpa, vergogna e responsabilità perseguitano le donne ancora oggi, residui di una mentalità antica profondamente radicata in noi, una mentalità che ha cominciato a subire delle piccole scosse solo a partire dalla seconda metà del XIX secolo, quando delle nuove voci si sono levate e hanno iniziato a raccontare con un sussurro i loro dubbi: chissà, magari non è vero che solo le lesioni corporee sono segni di violenza, magari ogni singola volta che non c’è consenso ci si trova di fronte a uno stupro, magari le ferite più dolorose sono quelle dell’anima.
Queste voci diventano coro durante il fondamentale processo di Aix del 1978[13] in cui le vittime svolgono per la prima volta un ruolo attivo. Voci femminili, voci incrinate di donne rotte che si appropriano per la prima volta delle parole, del discorso, e cominciano a parlare delle proprie violenze a modo loro: «lo stupro ha significato il saccheggio, la distruzione di noi stesse»[14].
Riprendersi la propria voce, dunque, narrare da sé la propria storia: non delegare ad altri il compito di narrare chi si è, la propria violenza, ma raccontarla da sé, come si riesce, anche piangendo, urlando e permettendo alle emozioni di fuoriuscire.
Purtroppo però nell’ottica dello stress post-traumatico la riappropriazione della narrazione della violenza subita viene depotenziata, in quanto ne viene negata l’utilità e viene messo in luce esclusivamente l’effetto di rivitalizzazione del trauma subito e di ri-vittimizzazione della donna, che si trova a rivivere il suo dolore e si ritrova in uno stupro rinnovato di cui viene messa in luce solo la sofferenza derivante, mentre viene taciuta la sensazione di liberazione dovuta al racconto del trauma e all’esternazione dello stesso che molte vittime confermano di provare[15].
La nostra contemporaneità continua a cercare di raccontare la vittima di violenza sessuale come un corpo saturo di vergogna traumatica e lo stupro un segreto inconfessabile, un atto privato osceno che è meglio coprire, nascondere, non fare uscire: un peccato di cui ogni donna potrebbe essere una vittima inerme, inerte, passiva e senza possibilità di reazione. Una principessa senza macchia, una povera vittima indifesa che non può far altro che tentare di andare avanti come può, marchiata per sempre nell’animo dallo stupro.
Chi era prima della sua violenza non esiste più: tutto ciò che conta ora è la sua violenza, che la definisce e la rimodella. È una statuina rotta, non più aggiustabile, senza la sua storia, senza la sua soggettività, che si definisce in base a ciò che le è stato fatto. Deve piangere e sperare che un giorno arrivi davvero il suo principe azzurro a salvarla[16].
Questa narrazione della vittima immobilizza la donna, la ingabbia in questo ruolo, non le permette di riprendere in mano la propria vita e decidere come comportarsi: la infantilizza, rendendola un’eterna bambina che ha bisogno della mano paterna per potersi gettare nel mare della vita.
C’è bisogno di cambiare parole, di cambiare lessico per evitare di essere di nuovo irretite dal canto maschile che ci narra chi siamo. Proprio per non pensarsi più come principesse da salvare, statuine di vetro, oggetti fragili e preziosi da conservare nel migliore dei modi, vittime piangenti impossibilitate a rialzarsi, si è pensato a un nuovo termine per definire le vittime di violenza sessuale: survivors[17], “sopravvissute”. Attraverso l’utilizzo del termine sopravvissute si sottolinea l’identità spezzata del soggetto, un soggetto che non può più ritornare alla propria condizione originaria dopo aver esperito una tale distruzione e un tale trauma, e che si muove costantemente fra le macerie della propria anima provocate dall’esperienza letale dello stupro. La sopravvivenza, a qualsiasi evento traumatico, comporta uno sprofondamento del soggetto in una sorta di zona grigia in cui la sua identità si annulla.
La nostra sopravvissuta è spezzata, ma continua a vivere, continua a trascinarsi nella vita come se questa fosse una delle dodici fatiche di Ercole: ora non è più una vittima passiva, ma è il suo stupro, è la sua violenza. Insegna al mondo che bisogna andare avanti sempre, ad ogni costo: denunciando, imparando a gestire le proprie emozioni e a parlare del proprio vissuto con razionalità e distacco. Le strategie adottate per riparare l’anima puntano a disfarsi del passato, a disfarsi della sofferenza e del male subito, cancellarlo ed eliminarlo per poter vivere di nuovo una vita normale, per poter vivere di nuovo la stessa vita di prima.
Siffatta retorica della brava vittima, della sopravvissuta, finisce per creare una frattura fra le vittime di violenza sessuale: ci sono quelle buone e quelle cattive, quelle che lottano, resistono e aiutano a combattere la violenza e quelle che invece si rendono complici non denunciando, non uscendo allo scoperto, ed è proprio a queste cattive sopravvissute che viene addossata la responsabilità del perdurare dello stupro. Con il loro silenzio vergognoso, con il loro mancato superamento della vergogna, con la loro rabbia e aggressività – ma anche con la loro narrazione della violenza subita divergente da quella dominante, che vede la vittima ergersi a paladina dei diritti umani, a guerriera gentile che perdona ogni torto – vengono definite colpevoli, responsabili delle violenze future.
Cercando di risolvere il problema dello stupro in realtà si continua a reiterare un ordine simbolico che costruisce le vittime come contenitori «saturi di vergogna inibitrice e depersonalizzante»[18], quando la vergogna dovrebbe invece essere fedele compagna di chi ha violentato e della cultura e della società che l’hanno permesso, alleati formidabili (nonché creatori stessi) della violenza.
Ogni donna dovrebbe sentirsi libera di poter vivere la sua sofferenza e il suo trauma nel modo che più le è congeniale, evitando di dover per forza rimuovere il dolore e l’elemento emotivo dalla sua narrazione, ma ridando piuttosto dignità e centralità, vivendolo appieno, attraversandolo e cercando di ricomporre la sua anima in modi nuovi. Un’ anima che non sarà mai più quella di prima, ma che può ritornare a brillare, a essere una, a non essere più frammentata, un’ anima che può essere ricucita con ago e fili d’oro, fili intrecciati d’amore e sofferenza.
È necessario ridare spazio al soggetto all’interno del discorso pubblico, rimettere al centro la soggettività e la persona, senza farla scivolare nella visione comune e stereotipata della vittima. Bisogna ridarle la sua voce, renderla padrona della sua storia e del suo dolore, legittimandolo e non svilendolo, senza colpevolizzarla, senza addossarle responsabilità che non le appartengono.
La violenza non definisce chi sei, non ti marchia per sempre: ti attraversa.
Ti trapassa, ti apre in due, ma a un certo punto se non ti rinchiudi in termini paralizzanti, se non ti ripieghi in questa violenza, se non ti accoccoli su di lei per tanto tempo, ti lascia: o meglio, la lasci tu. E dietro di sé lascerà degli strascichi, dei residui, ma il bello è che puoi decidere tu cosa farne: se lasciarli germogliare e creare un giardino fiorito, o se lasciarli seccare ed estirparli per sempre dalla tua anima.
Attraversate dalla violenza: una violenza che ti uccide, ma da cui si può risorgere e di cui soprattutto si può parlare, ma bisogna che lo facciano le dirette interessate.
È necessario che le donne rotte si riapproprino della loro voce e della loro storia, senza vergogna ma non senza paura, ché la paura è umana e sarebbe folle pensare di non provarne mentre ci si sta aprendo in due, mentre si stanno tirando fuori dal corpo le viscere e il cuore e si stanno mostrando ad altri.
Bisogna aprirsi all’altro: un’apertura non indolore, un’apertura responsabile, totale, consapevoli del fatto che davanti a te puoi trovare tanto una mano che ti salva quanto una mano che invece ti uccide, ma consapevoli anche che chiudersi in sé stessi equivarrebbe a perdere la propria umanità, umanità che si costituisce a partire dall’altro, come ci insegna Derrida[19].
Io nella mia vita mi sono aperta tanto, ma le mie viscere, il mio cuore, le conoscono in pochi, pochissimi, e se davvero voglio lasciare qualcosa di più profondo in questo mondo che un’orma leggera, impalpabile, riflesso di una vita giusta, condotta sui binari della società, perfetta ma di plastica, artificiale, finta, non posso esimermi dallo strapparmi fuori le viscere in questa sede.
Sarei difatti ipocrita a concludere così, esortando le donne a riappropriarsi di sé stesse, della propria voce e della propria storia, a raccontarsi senza vergogna, a raccontare la propria violenza senza vergogna, mettendo però a tacere di fatto me stessa e chiudendomi a riccio (come faccio abitualmente), ponendo una distanza abissale fra me e gli altri. Se voglio che cambino la percezione e la narrazione della vittima di violenza sessuale non posso aspettare che lo facciano da sole, che qualcun altro le faccia cambiare, non posso delegare ad altri la responsabilità del cambiamento quando anche io nel mio piccolo posso fare qualcosa: posso riprendermi la mia voce e raccontare senza vergogna, ma con tantissima paura, la mia storia. Raccontarla a modo mio, con le mie parole, con le mie azioni, riappropriandomi così della mia identità, del mio nucleo essenziale, costruendomi davanti agli occhi dell’Altro con il mio agire e il mio raccontare.
Sono una donna rotta anche io. Una donna rotta, attraversata dalla violenza, che si è ricucita da sola come è riuscita: grezzamente e dolorosamente, ché con ago e filo non sono mai stata un granché, ma il filo dopo anni ancora resiste e lo squarcio che era il mio petto, lo squarcio che pensavo di essere si è rimarginato, è diventato cicatrice.
E se non lo tocco, non fa quasi più così male.
Sono stata violentata due volte, entrambe d’estate, a fine agosto[20].
La prima volta in cui la violenza sessuale mi ha attraversata era anche la prima volta che facevo sesso, a me non era riservata dolcezza né tenerezza alcuna[21], ma solo una voglia alcolica, brutale; non ho avuto mani che mi accarezzassero, ma un filo spinato stretto intorno tutto il mio corpo; non ho avuto baci dolci e romantici, ma solo limoni alla tequila e controvoglia.
Non ho avuto rassicurazioni, parole dolci o affettuose, ma solo una botta e via.
Una botta secca e dolorosa.
Lui che mi bacia, lui che mi tocca, io che ricambio finché non mi solleva il vestito (un vestito corto e attillato, ovviamente, certo che così me la sono proprio andata a cercare! Per non parlare del mio tasso alcolemico, potevo forse aspettarmi un risvolto diverso? E poi andiamo Odi, sei troppo bella, troppo provocante, troppo disponibile, troppo gentile, troppo chiacchierona, troppo allegra, troppo intelligente per pensare che non sarebbe successo nulla e per non volerlo. Ma non penso proprio di averlo voluto, considerando che quel vestito non sono riuscita a rimetterlo per un anno. L’ho lavato decine di volte, a mano e in lavatrice, anche se le macchie bianche che lo ricoprivano erano già sparite al primo lavaggio. Ma io continuavo a vederle).
Mi chiama principessa: ma le principesse rimangono forse con il vestito alzato in mezzo a una strada?
Ma io voglio rimanere con il vestito alzato in mezzo a una strada?
No, no, no, non voglio, le mie mani cercano di coprirmi le cosce, di rimettere il vestito al suo posto ma non ci riescono, sono così piccole, sono così piccola, non sono abbastanza forte e il vestito rimane alzato. Non posso più rimetterlo giù, devo aver superato un punto di non ritorno a me sconosciuto.
Non puoi lasciarmi così, mi dice.
E io smetto di resistere.
La mia testa si spegne, la mia anima si annulla: dopo quella frase non ho ricordi.
Il giorno dopo un vuoto di memoria, una sensazione di angoscia, un dolore inspiegabile, sordo e bruciante e delle mutande piene di sangue nella borsetta.
Avrei potuto fare un sacco di cose in quel momento. Ho optato per la più facile: un mc menù in offerta con la mia migliore amica e una pillola del giorno dopo. La mia prima pillola del giorno dopo.
Non è stato facile mandarla giù, io che odiavo le pillole e non riuscivo ad ingoiarle e che a quanto pare trovavo quella situazione estremamente divertente, divertente a tal punto da non riuscire a smettere di ridere, fino alle lacrime, lacrime che nel giro di un istante si sono trasformate in un pianto disperato.
Un pianto inconsapevole del suo significato, perché non potevo pensare di non aver voluto la mia prima volta, perché mi sentivo pienamente responsabile di ciò che mi era successo, mi sentivo l’unica responsabile.
In fondo, avevo messo io quel vestito, avevo bevuto io quegli shot di troppo, mi ero fatta offrire io da bere, e sempre io avevo voluto baciare quel ragazzo, avevo fatto tutto io.
Non c’erano divisioni di colpa, percentuali, l’unica colpevole ero solo io e per me stessa non avevo assoluzione. Gli altri, invece, non avevo bisogno di assolverli: non li avevo mai chiamati in giudizio.
Sul banco degli imputati sedevamo io, la mia colpa, la mia vergogna e la mia responsabilità.
Un pianto che non capivo, di cui avevo paura, un pianto che non volevo capire, perché volevo ancora sentirmi spensierata e leggera (che poi, in realtà, non mi sono mai sentita spensierata e leggera), con tutta la spensieratezza tipica dell’adolescenza, con tutta la leggerezza sbrilluccicante di quelle serate estive a piazza Trilussa.
Dopo quella pillola sono andata a fare shopping con mia zia e con un senso di vuoto che mi divorava, un vuoto che ero io.
Mia zia non si è accorta di niente.
E se non si era accorta di niente lei, che era la persona più importante della mia vita, che è stata per me amica, zia, sorella, cugina e nipote, nessuno si sarebbe accorto di niente.
E nessuno se n’è mai accorto.
In quel periodo mi sembrava una fortuna incredibile ma ora posso asserire con fermezza che non c’è niente di peggio dell’indifferenza, un’indifferenza che ti annulla, ti rende invisibile, ti fa sentire niente.
Non c’è niente di peggio del silenzio degli altri: un silenzio violento, un silenzio che ti violenta non un’altra volta, ma altre dieci, venti, mille. Perché il silenzio copre il tuo stupro, lo nasconde, lo rende inesistente, lo normalizza.
Attraversare l’inferno senza che le persone che hai accanto ti stringano ogni tanto la mano ti spezza dentro, ti rende sola.
Fra te e loro ci sarà sempre uno scarto incolmabile, un burrone invalicabile, che è poi il burrone di te stessa, della tua anima, del tuo dolore impronunciabile, che non può trovare spazio nei discorsi, nelle uscite, fra i drink annacquati di pub discutibili.
Un dolore che non ti definisce, ma è parte di te: una parte importante che non può essere ignorata.
Non c’è stato mai un giorno in cui io mi sia sentita totalmente vittima, neanche dopo il secondo stupro. Non perché non capissi la portata dei due eventi che si sono abbattuti sulla mia testa come una spada di Damocle, anche perché intendiamoci: a convivere ancora oggi con il dolore sono solo io e nessun altro, solo io lo conosco bene, è stato il mio compagno per tanto di quel tempo che decidere pian piano di lasciarlo andare è stata per me quasi una violenza.
Non c’è mai stato un giorno in cui io mi sia sentita totalmente vittima, perché non potevo e non volevo accettare di essere definita da una parola sbagliata, vittima, termine paralizzante e passivo, che mi avrebbe rinchiuso per sempre in una sfera di inattività, che mi avrebbe definito per sempre e avrebbe banalizzato me e il mio vissuto.
Pensiamo sempre alle vittime con pietà e compassione, come soggetti quasi non umani, irreali, le collochiamo su un piedistallo di sofferenza che le costringe a non mettere mai un piede in fallo, a non uscire mai dal ruolo loro assegnato.
Una vittima di violenza sessuale la immaginiamo andare in discoteca, vestirsi in modo provocante, bere fino a non capire nulla?
Una vittima di violenza sessuale ce la immaginiamo forse riprendere a fare sesso poco tempo dopo?
Immaginiamo forse che a una vittima di violenza sessuale possa ancora piacere il sesso?
Il più delle volte una vittima è una creatura a noi estranea, aliena, un corpo saturo di sofferenza e vergogna, una sopravvissuta che si trascina a fatica fra le macerie della sua vita.
Prende parte a una tragedia[22]: ci illudiamo che basti solo collocarla nel territorio del mostruoso, del tragico e quindi della finzione, della pietà, per eliminarla ed eliminare ciò che essa implica, guardare negli occhi il dolore umano, ripetibile innumerevoli volte, lo schifo e l’indifferenza che tutti noi abbiamo dentro.
Pensiamo che tracciare una linea dritta, un confine netto tra noi e lei basti a metterci al riparo dalla colpa e dal senso di inadeguatezza, dalle voci nella testa che ogni tanto provano a dirci che lo scopo della vita non è quello di coltivarsi il proprio orticello, ma la relazione vera con l’Altro.
Ci illudiamo che esista un giusto e sbagliato assoluto, che una cosa sia nera o bianca, che non esistano grigi, neanche nella violenza: o hai lividi o la tua violenza non esiste.
O smetti di vivere, o la tua violenza non esiste.
O odii tutti gli uomini, o la tua violenza non esiste.
Tracciamo l’identikit della vittima perfetta, per riconoscerla, per non vederla in nostra sorella, in una nostra amica, in nostra figlia, in nostra nipote: una vittima, per essere tale, deve denunciare. Deve seguire un iter ben preciso, altrimenti la sua esperienza, i suoi sentimenti, la sua parola, non saranno mai validate. Una vittima non può discostarsi dalla narrazione che altri fanno di lei, pena la messa in discussione del suo vissuto.
Ma le vittime, così come noi le costruiamo, non esistono.
Le vittime che noi ci figuriamo sono irreali: io, invece, sono reale.

Io e le mie violenze siamo reali, non siamo atti di nessuna tragedia, esistiamo davvero, e se anche ora che ci spogliamo nude davanti al mondo il mondo chiude gli occhi e non vuole riconoscerci, beh, alla fine sti cazzi.
Dopo le mie violenze ho continuato a vestirmi aderente, ho continuato ad andare a ballare, ho continuato a baciarmi con gente sconosciuta, ad avere rapporti sessuali, a studiare, ad andare a danza nonostante ogni spaccata, ogni apertura, ogni salto mi dilaniava, mi faceva rendere conto di quanto non mi sentissi più padrona del mio corpo; ho continuato a vivere, portandomi dentro il mio dolore, dolore che spesso, quelle poche volte in cui lo tiravo fuori, veniva banalizzato.
Ero io quella esagerata, quella che prima faceva le cose senza pensare e poi se ne pentiva, ero io che pensavo troppo e mi complicavo la vita.
È capitato che ci credessi anche io, che mi dicessi da sola povera cogliona, non sai vivere, ma poco dopo il dolore mi piegava in due e non potevo più credere che non fosse reale.
Lo sentivo dentro, arrivava fino alla bocca dello stomaco, mi piegava in due e mi lasciava a terra.
Il dolore di una violenza sessuale non è passivo, è attivo: piega, spezza e travolge.
L’ho sentito dentro tutte le mie cellule, l’ho accolto in tutte le mie cellule e l’ho cullato, l’ho sviscerato, l’ho aperto in due, questo dolore, aprendomi insieme a lui.
Il dolore mi ha accompagnato dappertutto, è stato il mio porto sicuro, la mia casa, unica certezza a cui aggrapparmi in un periodo in cui la terra sembrava franarmi costantemente sotto i piedi.
Quel dolore immenso, dopo la seconda violenza, l’ho riconosciuto, abbracciato, abitato, e mi ha permesso di sentire tutta la violenza, la sofferenza, la malvagità e lo schifo dell’essere umano, mi ha consentito di abitarlo, lo schifo, di abitare ogni fragilità e piccolezza e riuscire, alla fine, ad accettarne alcune e condannarne altre.
Il dolore di una violenza sessuale non esaurisce la tua vita, la sua bellezza. La vita che segue un evento del genere non è la vita di una sopravvissuta, una vita che si trascina, una vita drammatica, una vita da portare sulle spalle come un fardello troppo pesante.
È una vita degna di essere vissuta, attiva, consapevole e, almeno per me, più vera.
E chi si è imbattuta in un dolore del genere non è condannata per sempre, non è marchiata per sempre dalla sofferenza, dalla vergogna e dallo schifo.
Io stessa ho pensato che quel dolore sarebbe rimasto ancorato alla mia anima per sempre, che mi avrebbe annullata, cancellata, trasformandomi da un grumo di sogni a un grumo di colpa, vergogna e responsabilità.
Ma il dolore non è un destino, non è la condizione necessaria per essere «vere donne», e se vi ci si imbatte è importante sapere che dal dolore si può riemergere, che anche se ci si sente condannate ad essere rotte per sempre, è possibile rimettere pian piano insieme i frammenti della propria anima per nascere una seconda volta.
Intendiamoci: la prima volta che è successo ho cercato di reprimere l’episodio sotto il peso di bocche diverse, spesso e volentieri bocche senza nome, sotto il peso leggero di serate alcoliche in cui io perdevo i contorni, li perdeva il mondo intorno a me e li perdeva anche la mia violenza, serate alcoliche che mi facevano amare lo schifo che vedevo fuori e lo schifo che sentivo dentro.
Potevo ignorarlo, quello squallore, anche tutti i giorni (e ci riuscivo alla grande, concentrandomi sui problemi degli altri, sicuramente più importanti dei miei, e sul mio studio), ma ogni notte si infilava nel mio letto e si faceva strada dentro di me, duro e freddo.
Un freddo metallico possedeva il mio corpo e la mia anima, quel freddo metallico era tutto il mio schifo che non riuscivo a vomitare: era il freddo metallico del cofano di una macchina (chissà di chi) su cui sono stata scopata per la prima volta[23].
Mi sono autoconvinta di non meritarmi e di non voler nient’altro che quel freddo metallico, che la mia sofferenza fosse il pentimento di una ragazza che non accettava il fatto di essere lei quella facile, perché in quel momento non riuscivo a comprendere tutto quel dolore, a dargli un senso, una forma, ad accettarlo nella mia vita e dentro di me; non riuscivo a non sentirmi completamente responsabile di ciò che era accaduto.
Perché in quel momento, in cui stavo iniziando a scoprire il mio corpo e la mia sensualità, il mondo che avevo intorno mi dava, con candida innocenza, della troia. Lo sottintendevano gli sguardi delle altre mentre ballavo in discoteca, i commenti non sempre lusinghieri delle persone che avevo vicino, lo asserivano i ragazzi che rifiutavo, quelli con cui mi baciavo, quelli che incrociavo per strada, i giudizi di mia madre se mettevo un vestito troppo stretto[24].
Perché era la mia prima volta ed ero vissuta nella convinzione che la prima volta fosse importante, bellissima e speciale, che non importava con chi lo facessi e come, ma che lo volessi.
Non esisteva prima volta senza la mia volontà.
Mi è servito un secondo stupro per comprendere ciò che mi era successo ormai tempo prima, e questa volta ero perfettamente sobria, nessun black-out della mente che venisse a salvarmi da quelle mani, dal suo sudore che mi colava sul seno, dai suoi gemiti che mi rimbombavano nelle orecchie. Mi veniva da vomitare, non riuscivo a fare niente, non riuscivo a muovermi, non riuscivo a scappare.
A un certo punto ero lì, schiacciata dal suo corpo, ricoperta dal suo sudore e dalla sua saliva, ma ero anche fuori da me, spettatrice di un film osceno che non volevo vedere né tantomeno vivere. Mi sembrava di vedere la scena dall’esterno, mi sembrava quasi di essere io la regista, di star girando io quella scena, di volerla girare in quel modo: lui che si muoveva sopra di me e io sotto immobile, in quell’appartamento caldo e opprimente vicino alla spiaggia.
Era come se non stesse succedendo realmente, come se fosse davvero una recita talmente ben eseguita da risultare vera.
Anche in questo caso il mio dolore è stato un freddo metallico. Questa volta il freddo metallico dello speculum che mi hanno infilato dentro la vagina già dolorante dal giorno prima le infermiere del pronto soccorso del Policlinico Umberto I[25].
Tutte le volte in cui il pensiero di essermi inventata tutto mi ha sfiorato, mi sfiora e mi sfiorerà ancora la mente ritorno lì, su quel lettino a gambe aperte, con le lacrime che mi sporcavano il viso (proprio io che avevo fatto del mio non piangere quasi mai un vanto), con un dolore così grande e totalizzante che non riusciva ad uscire dal mio corpo, contenitore ermetico della sofferenza che altrimenti se si fosse aperto chissà fin dove si sarebbe estesa, e le braccia di Simona ad aspettarmi una volta che fossi uscita da quella maledetta stanza.
Le braccia di Simona ad aspettarmi non solo quel giorno, ma tutti i giorni seguenti, ad aspettarmi ancora oggi.
Ritorno al mese di settembre, fatto di pillole e pillole e ancora pillole: una pillola rosa, una pillola blu, pillola rosa, pillola blu, e così via fino alla fine del tubetto.
Dopo i primi giorni in cui ne ho ingoiate una ventina al giorno, solo quattro pillole quotidiane, di cui due la notte: all’una e alle quattro.
E all’una e alle quattro mi sono svegliata per molto tempo, quando riuscivo ad addormentarmi.
Oggi all’una e alle quattro non mi sveglio più, ma dormire è ancora il mio incubo: diventa quasi piacevole solo fra le sue braccia (o dopo una sbronza)[26].
Ritorno al mese di settembre, in cui mi sentivo completamente drogata, quei farmaci mi annebbiavano la mente, me la offuscavano, mi avvolgevano in una nuvola di dolore da cui non volevo scendere. La mattina non riuscivo ad alzarmi, non volevo alzarmi, non volevo affrontare un’altra giornata, un’ennesima giornata in cui sorridere e fingere che la mia vita, che io stessa, non stesse andando in pezzi. Che tanto nessuno se ne accorgeva, che io ero rotta e il mio cuore non funzionava più, che era solo un ammasso di carne sofferente che si contorceva ogni giorno su sé stesso, provocandomi lividi permanenti.
Volevo rimanere ancora nel letto, avvolta dalla coperta, lasciare passare i giorni e lasciar passare anche me stessa.
Ma poi mi alzavo sempre, con le gambe un po’ malferme, la testa leggera e ovattata, l’anima pesante come un macigno e lo stomaco sottosopra. Mi alzavo e vomitavo.
Vomitavo quasi tutte le mattine: almeno questa volta il mio schifo veniva sputato fuori. Almeno questa volta non facevo finta di niente anche con me stessa.
Camminavo tutti i giorni dalla fermata della metro fino alla Sapienza, guardando il cielo e sentendomi spesso felice, felice perché c’era il sole, perché era capitata proprio la canzone giusta dalla mia playlist, felice perché ero viva, perché c’era gente intorno a me, ma in tutta quella felicità, probabilmente originata dalla disperazione, ogni tanto capitava improvvisamente che me lo sentissi dentro: lo sentivo di nuovo dentro di me, arrivava fino alla bocca dello stomaco e rimaneva lì, duro e immobile a volte per pochi secondi, altre minuti, altre ore.
Respira Odi, respira, era il mantra di quel periodo.
(E forse lo è ancora oggi)
Chiudevo gli occhi, per strada, solo per un secondo, per poter prendere un po’ d’aria e riuscire a muovermi.
Alla fine ci riuscivo sempre, solo che anziché guardare il cielo guardavo i miei piedi, unico modo per riuscire a concentrarmi sui passi da fare, unico modo per riuscire a volerli fare. Mi stringevo le braccia al petto e cercavo di camminare il più distante possibile dalla gente che faceva la mia stessa strada, gente che ora mi soffocava, mi opprimeva, mi bloccava il respiro.
Volevo solo allontanarmi il prima possibile da quella folla di persone che mi schiacciava.
Respira Odi, respira, sono solo due passi.
Tutto il dolore che avevo cercato di rimuovere la volta precedente, mi era piombato addosso triplicato.
Ma, paradossalmente, quel dolore mi teneva in vita.
Quel dolore e il tentativo di sopravvivergli mi facevano andare avanti, mi facevano vivere; se mi fossi pianta addosso, se mi fossi considerata una vittima, passiva e senza possibilità di agire, di resistere, immobile e senza possibilità di poter cambiare la situazione, non mi sarei svegliata mai più.
Se non avessi vissuto quel dolore attivamente, con tutta me stessa, oggi non sarei qui a raccontarlo.
Sarei stata probabilmente sopraffatta da quel peso, non sarei stata in grado di rialzarmi, di continuare a portare avanti la mia vita.
Vita che spesso ho portato avanti nel peggiore dei modi: dentro distrutta, fuori perfetta. Ma l’ho portata avanti, ho vissuto in fondo come si dovrebbe vivere: male, sbagliando in continuazione ma cercando costantemente di correggere il tiro e aggiustare gli sbagli.
Non mi sono mai fermata, non ho mai dormito, non mi sono mai riposata. Non potevo permettermi di detestare la vita, odiarla, rinnegarla persino, io che la vita l’amavo così tanto e che ancora non l’avevo vissuta fino in fondo. Io che non avevo ancora mai conosciuto l’amore, che non mi ero mai sentita veramente amata, che non riuscivo a sentire sulla pelle quell’amore, sulla pelle e dentro di me, pur sapendo che le persone che avevo vicino mi amavano. Non so se oggi l’amore degli altri lo sento, ma sento il mio.
Non potevo permettermi di odiare la gente, di non sopportarla, di volerla rifuggire, io che amavo la confusione, la gente ammassata, rumorosa, il sentirsi parte di qualcosa, le debolezze degli altri, i loro limiti, le loro qualità.
L’obiettivo era dimostrare a me stessa che ero forte, che avevo le spalle abbastanza larghe da non crollare sotto il peso della violenza, e anche se così non era, se avessi fatto finta di esserlo pian piano la finzione si sarebbe confusa a tal punto con la verità da non sapere più quale fosse l’una e quale l’altra.
E per non crollare sotto il peso dei miei stupri in quel periodo non li chiamavo mai con il loro vero nome – stupri – ma, quelle volte in cui non potevo proprio fare a meno di parlarne, rapporti non consensuali. Rapporto non consensuale: una formula non violenta, quasi pacifica, una formula per me quasi dolce, rassicurante, perché mi dava una sensazione di impersonalità e distacco, di freddezza, di razionalità. Rapporto non consensuale: tutta un’altra cosa rispetto stupro o violenza sessuale, termini che rinviano subito a un’immagine violenta, cruda, dilaniata. Nascondermi dietro queste tre parole, che ripetevo incessantemente quando mi sentivo male – è stato solo un rapporto non consensuale, non ha capito bene che il mio era un no, non è stata vera e propria violenza, solo un’incomprensione, solo un rapporto non consensuale – mi permetteva di continuare a essere quel superman che volevo essere, che pensavo di essere, che pensavo di dover essere. Quel superman che non si fermava mai, che non sbagliava mai, che raggiungeva i suoi obiettivi nonostante tutto: quel superman che dopo sedici giorni dal suo rapporto non consensuale si chiudeva in macchina con due uomini per sostenere l’esame pratico della patente, quel superman che dopo neanche un mese dal suo rapporto non consensuale si chiudeva in una stanza con un uomo per sostenere l’esame di Letteratura italiana I. La mia edizione dei Rerum vulgarium fragmenta è ancora cosparsa di lacrime, fra quelle pagine c’è ancora tutto il mio sangue, il tentativo di rimettere insieme i anche i miei, di pezzi, in modo goffo e maldestro. In modo superomistico e dunque necessariamente fallimentare.
Ho dovuto accettare di non poter fare tutto da sola, di non potermi salvare da sola e di non poter salvare gli altri, ho dovuto accettare di non poter essere superman – e ho capito che forse, quel ruolo, non l’avevo mai veramente voluto, era una maschera, un simulacro che mi permetteva di continuare a sopravvivere, di sentirmi in pace con me stessa, perché ero io a salvare gli altri e questo continuo mettermi a disposizione di tutti mi distraeva da me stessa, dal mio dolore[27]. Ho dovuto accettare di non poter contare solo sulla scrittura come terapia, così sono andata al consultorio e ho iniziato un percorso psicoterapeutico, un percorso che ho affiancato alla mia cura personale, fatta di parole, di centinaia di pagine imbrattate di lacrime e sangue, scritte usando la penna come coltello con cui scavare dentro me stessa.
E alla fine mi sono scavata così tanto a fondo, ho sviscerato così tanto quel dolore, che non ho potuto far altro che gettarlo nella mia tesi di laurea, dandogli una sistemazione “scientifica”.
In questi anni ho capito che ciò che ci accade nella vita non ci definisce, non sono gli eventi a definirci, non sono gli agenti esterni; questi fanno parte della nostra storia, sono pezzi di noi, ma non potranno mai essere noi.
Ciò che ci definisce è il modo in cui vi reagiamo, il modo in cui ci rapportiamo con il dolore, con la sofferenza, con i nostri traumi e con il nostro vissuto. Sono le nostre azioni e le nostre parole a dire chi siamo, tutte insieme.
Io non sono le mie violenze, le mie violenze fanno parte di me come fanno parte di me i miei organi, i miei muscoli, la mia pelle.
Qualcuno sognerebbe forse di definirmi in base a un organo?
Io sono tutti i miei organi, non uno solo.
- Sul sito dell’Istat è presente una sezione dedicata alle campagne di sensibilizzazione avviate in tutta Italia: https://www4.istat.it/it/violenza-sulle-donne/la-prevenzione/campagne-di-sensibilizzazione (ultima consultazione maggio 2022). Si hanno campagne più “tradizionali” (come quella promossa dalla regione Puglia a cui si fa qui riferimento, denominata “Volta le spalle alla violenza”), accanto ad altre più innovative, come la campagna della regione Lazio “Fermati finché sei in tempo”, proposta dalla Croce Rossa della sezione di Roma, che presentando un video i cui protagonisti sono cinque uomini autori di violenza responsabilizza così il genere maschile e le azioni compiute dal singolo. (https://criroma.org/26463–2/ultima consultazione maggio 2022). ↑
- La violenza sessuale viene difatti definita brevemente come violazione del corpo e invasione fisica, con la conseguenza di mettere tra parentesi la portata psichica ed emotiva di tale trauma: viene taciuta la devastazione psicologica lasciata dietro di sé dalla violenza, una devastazione che investe l’intimità e la stessa identità della donna. ↑
- Le narrazioni che non trovano spazio all’interno del discorso pubblico finiscono per non essere validati, per non essere legittimati da nessuna “autorità” e finiscono di conseguenza per non esistere, anche nella sfera privata e nella sfera più intima possibile: la propria interiorità. Per approfondire si veda Judith R. Walkowitz, “Jack the Ripper and the myth of male violence”, in Feminist Studies, vol.VIII, n.III, 1982, pp.542–574. ↑
- La teoria della narrazione come costruzione del sé viene formulata da Adriana Cavarero all’interno di Tu che mi guardi, tu che mi racconti, Feltrinelli, Milano, 2001. ↑
- L’asterisco è voluto in quanto l’Io a cui si fa riferimento è un*Io generale, che comprende in sé tutte le varie identità di genere. ↑
- Cfr. Emmanuel Levinas, Totalità e infinito. Saggio sull’esteriorità, Jaca Book, Milano, 2016. ↑
- Il riconoscimento reciproco di due autocoscienze si trova in Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Fenomenologia dello spirito, Bompiani, Milano, 2000. Nella sezione IV il filosofo esplica come il riconoscimento di sé stessi passi per il riconoscimento di un’altra coscienza e il riconoscimento della nostra esistenza da parte dall’altro. Solo se veniamo riconosciuti e riconosciamo l’Altro esistiamo. ↑
- Cfr. Hannah Arendt, Vita activa, Bompiani, Milano, 1964. ↑
- Il mito fondativo della violenza maschile è quello di Jack lo Squartatore, mostro sconosciuto che violenta e uccide le donne negli angoli delle strade (cfr. Judith R. Walkowitz, op.cit.). Per approfondire si veda anche Elizabeth Stanko, “Women, crime and fear”, in The Annals of the American Academy of Political and Social Science, maggio 1995, pp. 46–58 e Maria Antonietta Trasforini, “Il corpo accessibile. Una riflessione su corpi di genere, violenza e spazio”, in Polis, XIII, Il Mulino, Bologna, 1999, pp. 191–212. ↑
- Secondo l’opinione comune c’è stata violenza solo se la donna ha opposto una resistenza fisica all’aggressore, senza tener conto, il più delle volte, della strategia dell’equo scambio, della coercizione psicologica e della manipolazione emotiva che l’aggressore può aver attuato. La strategia dell’equo scambio è stata studiata da Susan Brownmiller, che la definisce come quella strategia di sopravvivenza che porta le donne a non ribellarsi, a non opporre resistenza per evitare di subire danni peggiori, quali lesioni permanenti o la morte. L’unica possibilità di salvezza che si profila nella mente femminile è la sottomissione alla volontà del maschio, la violazione del suo corpo e della sua anima viene considerata come il danno minore in cui possa incorrere, convincendosi che donando il proprio corpo possa aver salva la vita. Il meccanismo dell’equo scambio è profondamente influenzato dagli stereotipi di genere, dai miti dello stupro, dalla cultura patriarcale e dal modo in cui essa costruisce i corpi sessuati: il corpo della donna è per natura debole e vulnerabile, incapace di potersi servire della forza fisica, una forza fisica che sono educate ad aborrire sin da bambine. Questa rete di convinzioni e stereotipi di genere va dunque a compromettere la possibilità femminile di poter reagire a un’aggressione da parte di un uomo, portando al meccanismo dell’equo scambio, il quale di fatto ha fra i suoi effetti anche quello di aumentare la difficoltà di provare il reato di stupro. ↑
- A tal proposito in ambito criminologico è stato prodotto il concetto di “comportamento scatenante della vittima” funzionale a definire e ad evidenziare tutto l’insieme di comportamenti assunti dalla vittima i quali avrebbero portato l’uomo ad attuare l’aggressione, essendosi dunque quest’ultima potuta evitare se la vittima avesse adottato degli atteggiamenti più prudenti. Susan Brownmiller sottolinea però la problematicità di tale concetto in quanto risulta difficile delineare dei comportamenti interpretabili da tutti come prudenti e dunque tale concezione è sottoposta a interpretazioni inevitabilmente arbitrarie (v. Susanna Mantioni, “Homo mulieri lupus. Susan Brownmiller e la demistificazione della «cultura solidale con lo stupro»”, in Simona Feci e Laura Schettini (a cura di), Storia delle donne e di genere, viella, Roma, 2017, pp. 139–152, pp.146–147). ↑
- Georges Vigarello, Storia della violenza sessuale, Marsilio Editori, Venezia, 2001, pp. 16–56. ↑
- Processo che si svolse fra il 2 e il 3 maggio 1978 e in cui le vittime svolgono per la prima volta un ruolo attivo, orientando il dibattito e collegando i reati a un problema sociale e denunciando una società maschile i cui valori finiscono per impedire una valutazione reale dello stupro. ↑
- Citato in ivi, p. 233. ↑
- Cfr. Eleonora Selvatico, “Colpa, vergogna e pudore nell’identità della vittima di violenza sessuale” in Politics. Rivista di studi politici n. IX, Edizioni Labrys, 2018, pp. 65–84. ↑
- Daniele Giglioli in Critica della vittima, nottetempo, Milano, 2014, analizza proprio la figura della vittima in generale, osservando come le vittime «rimpicciolite a ciò che gli è stato fatto, hanno lacrime ma non hanno ragioni» (pp. 19–20). ↑
- Liz Kelly, Surviving Sexual Violence, Cambridge: Polity Press, 1988. ↑
- Uso questa espressione tratta da Selvatico, op. cit., p. 74. ↑
- Per approfondire la filosofia di Derrida vd. Jacques Derrida, Donare la morte, Jaca Book, Milano, 2021. ↑
- In questo modo ho la fortuna di non dover fare particolari sforzi di memoria per ricordarmi le date precise e posso festeggiare ogni anniversario senza mai scordarmelo, che culo! Sto ancora aspettando che qualcuno per festeggiare queste due fantastiche ricorrenze mi porti a cena fuori ma a quanto pare nessuno, a parte me, sembra trovarla una cosa divertente. ↑
- Per un po’ di tempo ho desiderato solo il sesso carnale e occasionale, senza tenerezza, non volevo sguardi sdolcinati durante la penetrazione, non volevo carezze, non volevo nulla di tutto questo. Non volevo nessun rapporto veramente umano con le mani che mi toccavano il corpo. Con il tempo ho imparato a conoscere e apprezzare anche il sesso dolce e romantico, (quello da cui sono sempre scappata), ho imparato a conoscere l’amore, anche se ancora oggi con quest’ultimo ho qualche problema. La violenza non mi ha privata della capacità di godere. ↑
- E quindi non è reale. ↑
- D’altronde, a quell’epoca, uno dei miei maggiori motivi di vanto era la mia avversione nei confronti del romanticismo. Beh, tutto posso dire della mia prima volta tranne che sia stata romantica: cosa volere di più? ↑
- “Non è il vestito il problema, sei tu! Con un vestito stretto sei troppo appariscente, che bisogno hai di vestirti così? Ti stai svendendo, ti stai oggettificando, non dovresti vestirti così” il problema ero io, sempre e solo io. Mi stavo oggettificando? Non lo so, non lo so neanche adesso, se vestirsi in un determinato modo, se suscitare un determinato tipo di sguardi, se voler suscitare un determinato tipo di sguardi, se voler, ogni tanto, in determinate situazioni, essere oggetto di desiderio significhi svendersi e oggettificarsi. E anche se fosse, ogni tanto mi chiedo se sia davvero una cosa così brutta, così anti femminista, voler essere oggetto di desiderio e ammetterlo. (Io propendo più per il no, ma d’altronde chi sono per affermarlo?) ↑
- Farmi penetrare da uno speculum è stata di gran lunga l’esperienza più traumatica della mia vita.Ma ringrazierò sempre la persona (M) che mi ha portata lì, perché se non fossi rimasta in quella stanza, con quelle infermiere, non sarei chi sono oggi. ↑
- Nella mia folle rincorsa all’autonomia e all’autodeterminazione ho cercato di non lasciare mai troppo spazio a quella che istintivamente mi sembrava essere una dipendenza da qualcuno, una debolezza, un’ammissione di fragilità e una richiesta di aiuto, provando a rendere le MIE braccia il luogo sicuro in cui riposare, con scarsi risultati, e preferendo di conseguenza ritrovare la mia serenità in qualche shot di troppo che ero io a ingerire. ↑
- E purtroppo, a volte, ancora tento di trasformarmi in superman, ancora tento di impersonarlo, ma ora riesco ad accorgermene. ↑
Arendt, Hannah, Vita activa, Bompiani, Milano, 1964.
Bourdieau, Pierre, Il dominio maschile, Feltrinelli, Milano, 2021.
Cavarero, Adriana, Tu che mi guardi, tu che mi racconti, Feltrinelli, Milano, 2001.
Corbin, Alain, La violenza sessuale nella storia, Laterza, Roma-Bari, 1992.
Guillaumin, Colette, “Il corpo costruito”, in Studi culturali, Il Mulino, Bologna, fascicolo II, dicembre 2006.
Giglioli, Daniele, Critica della vittima, nottetempo, Milano, 2014.
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Fenomenologia dello spirito, Bompiani, Milano, 2000.
Kelly, Liz, Surviving Sexual Violence, Cambridge: Polity Press, 1988.
Levinas, Emmanuel, Totalità e infinito. Saggio sull’esteriorità, Jaca Book, Milano, 2016.
Mantioni, Susanna, “Homo mulieri lupus. Susan Brownmiller e la demistificazione della «cultura solidale con lo stupro»”, in Simona Feci e Laura Schettini (a cura di), Storia delle donne e di genere, viella, Roma, 2017, pp. 139–152, pp.146–147.
Palladino, Lalla, Non è un destino. La violenza maschile contro le donne, oltre gli stereotipi, Donzelli Editore, Roma 2020.
Selvatico, Eleonora, “Colpa, vergogna e pudore nell’identità della vittima di violenza sessuale” in Politics. Rivista di studi politici n. IX, Edizioni Labrys, 2018, pp. 65–84.
Stanko, Elizabeth A., “Women, crime and fear”, in The Annals of the American Academy of Political and Social Science, maggio 1995, pp. 46–58.
Trasforini, Maria Antonietta, “Il corpo accessibile. Una riflessione su corpi di genere, violenza e spazio”, in Polis, XIII, Il Mulino, Bologna, 1999, pp. 191–212.
Vigarello, Georges, Storia della violenza sessuale, Marsilio Editori, Venezia, 2001, pp. 16–56.
Walkowitz, Judith R., “Jack the Ripper and the myth of male violence”, in Feminist Studies, vol.VIII, n.III, 1982, pp.542–574.
Attraversate dalla violenza è un testo che tiene insieme due forme di scrittura che forse non dovrebbero mai incontrarsi: un’accademicità asettica e volutamente distante si scontra con la nuda realtà di una vita vissuta nell’eco di un’immotivata colpa da espiare. Una narrazione cruda perché sincera e sincera perché reale, che non ha come protagonista la violenza, ma il ripensamento di quest’ultima all’interno dei propri confini carnali.
Accompagnato da due contributi visivi diametralmente opposti tra loro: stralci di campagne di sensibilizzazione incapaci di puntare il dito contro i veri colpevoli ed altre in grado di mettere in chiaro le responsabilità, accanto al frammento di una fotografia, la rappresentazione manchevole e imperfetta di questa storia che é può essere di tutte ma solo realmente di una sola.