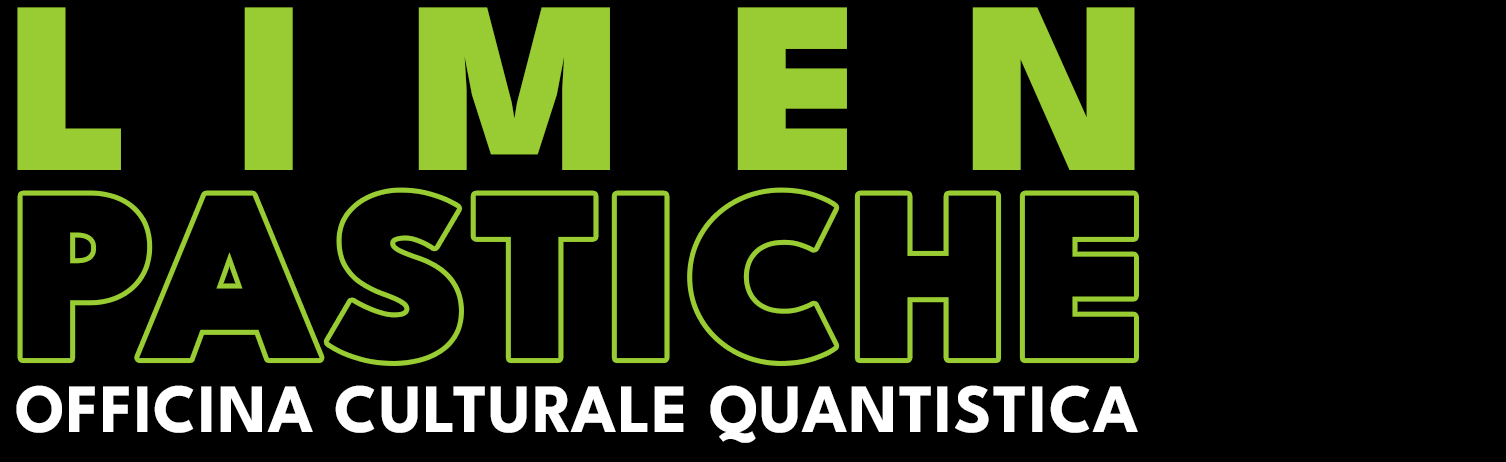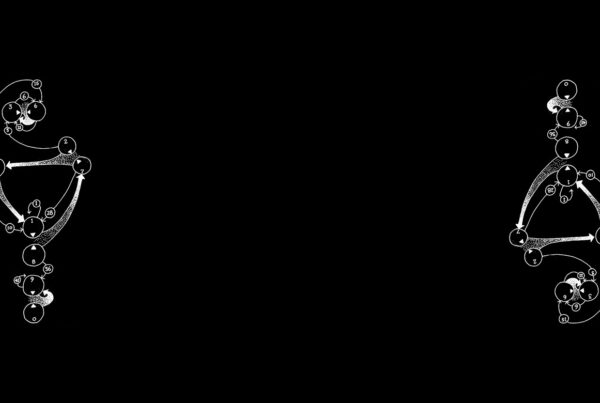Testi di
Simone La Penna
Copertina di
Andrei Costantino Cuciuc
Editing di
Andrea Ferraiuolo
Categoria
Materialismi
Passaggi viscerali
Data di pubblicazione
30 Aprile 2023
Elementi di materialismo schizo-librario
Note personali su un’ossessione consumistica
Introduzione alla serie: MATERIALISMI è un cortocircuito viscerale che indaga, sul piano materiale prima che concettuale, i vari rapporti che vi sono fra l’umano e l’oggetto cultura, qui materialismo librario, che ammette e poi smentisce, dichiara e poi si accusa, per il suo nevrotico-schizo-feticismo per il sentimento verso il libro, per la verginità del libro o per la sverginità del libro.
Della notte
(a mo’ di introduzione)
ho fatto il mio momento di elezione e dedizione alla lettura. Della notte, o meglio delle sue ore più giovani, mi sono impossessato, per sublimarle in un tempo sospeso e diluito. Una scelta non del tutto consapevole, forse più un mutuo accordo tra me (o meglio, la mia parte lettrice, il mio Io-Lettore) e le mie letture: un autoisolamento, più che una ghettizzazione forzata. La notte, le sue prime ore, sono un tempo altro, uno spazio alieno; nel coricarsi c’è un ritorno al buio del ventre materno, al suo calore, ad una posizione fetale che mi accompagna da sempre. Il letto è una sicurezza in cui si dissolvono, alla fioca luce di una lampada da comodino, i pensieri del giorno, della propria dimensione pubblica, per lasciare spazio al privato, alla propria incoscienza/innocenza. Il mio rapporto con la lettura si è da sempre misurato sul piano della simbiosi: atto essenziale, ossessivo e continuamente scrutato, indagato, si è andato ritagliando (forse strappando) un tessuto temporale proprio, personale, privato e unico, intoccabile. Nel silenzio, nella solitudine e nella pallida luce si compongono un coro, un rapporto privilegiato, un caleidoscopio: anch’io, come Marcel, a lungo mi sono coricato di buon’ora, ma non per ricordare la mia infanzia, quanto per poter conoscere quello che ancora non avevo letto.
Mi accade sempre più spesso di passare del tempo, nelle notti più insonni, a osservare un qualche scaffale della mia libreria. Non è uno sguardo buttato di sfuggita, come tanti me ne rubano i miei libri nel corso della giornata; è più un attento scrutare, alla ricerca di qualcosa di invisibile, come se potessi leggere i libri ancora non sfiorati dai miei occhi solo osservandone la costa o, al più, la copertina. Fino a poco tempo fa mi limitavo a restare in piedi, è solo da poco che mi sono accorto di prendere, fin troppo spesso, una sedia per riposarmi mentre li guardo, forse consapevole che non è quella l’attività che mi concilierà il sonno, e allora tanto vale stare un po’ più comodi. Quasi sempre ne accarezzo i profili, mi fermo ad assaporarne gli angoli, magari cambio il posto di un paio di volumi. A volte ne apro qualcuno e ne leggo poche righe, acontestualizzate, forse per qualche atavico retaggio paterno (è sempre stata un’abitudine di mio padre, quella di aprire un libro a metà e cominciare a leggerlo da lì; spesso l’ho visto terminare quello che aveva aperto, magari non curandosi mai, in un qualche futuro, di controllare di cosa trattasse la prima parte a lui sconosciuta). Molto più spesso rimango lì, sulla mia sedia-sgabello notturna, a fissare impietrito e senza scopo la colonna libraria che mi si erge davanti. Accade, con stupefacente intensità, soprattutto alla fine di un libro: una volta riposto, mi ritrovo ad indugiare su quelli che lo circondano, forse convincendomi (a torto) che sto solo ragionando sul successivo da scegliere.
Se sembro interrogare i miei libri con questo oscuro scrutare, è solo un’impressione: sono in realtà loro che, guardati, mi riguardano senza avere per me alcun riguardo, ma solo una necessità di sapere, di conoscere le mie ragioni per stare lì impietrito, come un Humbert Humbert qualsiasi. E la loro smania di conoscenza, mai minore della mia, non può che articolarsi a partire da una considerazione tra l’accusatorio e il sollevato: il rapporto del mio Io-Lettore con la lettura non si misura solo nella sua dimensione intellettuale e conoscitiva, ma anche nella sua dimensione materiale e fisica. Il rapporto, quindi, non si gioca tanto sul piano del significato del libro, quanto su quello del suo significante. Accarezzo le coste dei miei libri per la sensazione tattile che mi donano, non per altro; ne sfoglio le pagine per godere del loro fruscio (la lettura di quelle poche righe sparse e strappate dalla pagina sono solo una maschera); mi immergo, rapito, dall’insieme della mia libreria solo per quella sensazione di vertigine. Non sono solo attratto dalle edizioni più pregiate, ma anche il più economico dei tascabili mi lascia estasiato. Sono un materialista: un materialista librario.
Temo di essermi limitato, in questo rimuginio, a trovare – a scoprire – ossessioni e contraddizioni che a lungo albergavano nel mio Io-Lettore, e che da lì si erano già spostate da tempo in altre zone della mia coscienza. Forse è avvenuto tutto nell’arco di una sola, logorante sessione di osservazione dei miei libri. In ogni caso, quello che ne è scaturito non è altro che una sorta di contorta storia del mio materialismo librario, delle sue radici, delle sue complicazioni. Non dubito che qualcuno, il cui rapporto con l’oggetto libro possa essere gravato dalle stesse idiosincrasie di cui soffro io, riuscirebbe a trovare una qualche labile connessione con la propria esperienza personale, ma non è stata mia intenzione farmi possedere da questo duplice sguardo con lo scopo di creare un vademecum per il materialista librario: queste sono le mie ossessioni, scardinate nel buio di una notte insonne; un discorso che si fa dialogo, un po’ d’amore e un po’ di condanna, nato da un flusso malleabile, articolato con difficoltà e sempre liquido, quasi languido, nel suo procedere in un coro sgangherato con i miei libri; una posizione intellettuale, soprattutto, che, se anche propone un’apologia del materialismo librario (se di apologia, tra le contraddizioni e le ambiguità, possiamo parlare), non vuole disgiungere queste due dimensioni del libro, ma al contrario riconnetterle, ricondurre ad unità il significante e il significato: ritrovare il loro segno.
Sono le cose più piccole, forse anche le più insignificanti, ad avermi sempre attratto. Come mi ha canzonato giocosamente un mio caro amico, non molto tempo fa: “Simone, il fotografo delle piccole cose”. Mi sembra giusto, allora, partire anche in questo frangente dalla più innocua delle nostre tematiche. Partiremo dalla mia storia personale
Del segnalibro
che tanto a lungo mi ha fatto riflettere, vero prodromo di quel dialogo. La mia profonda incompatibilità con i segnalibri è un marchio di diversità la cui origine si smarrisce in un momento indefinito della mia infanzia. Non ricordo di averne mai usato uno, sebbene l’affastellarsi di questi rettangoli oblunghi sulle scaffalature delle mie prime letture dovrebbe testimoniare il contrario, ma ricordo la precoce consapevolezza della presenza di questa idiosincrasia. Presenza vissuta più come stigma sociale, che come orgogliosa presa di posizione: oltre all’imbarazzata incapacità di disfarsene (“Potrebbero sempre servire!”, mantra pervasivo di una famiglia disposofobica), a gravare realmente, per me, era ed è tuttora l’obbligo morale di spiegare questa mancanza, questa macchia, nel mio curriculum lectoris. A chi si interroga sulla mia antipatia per un oggetto che però, involontariamente, possiedo in quantità maggiore del normale, la questione si pone però su un piano tutto diverso e molto pragmatico: la domanda non è tanto “perché?”, ma soprattutto “come?”.
Come fa un lettore a rifiutare la comodità tutta analogica di un oggetto tanto semplice ed essenziale quanto rassicurante e funzionale? Come fa un lettore a sottrarsi alla quotidiana e per niente banale sfida di trovare un degno sostituto a quel segnalibro dimenticato sul tram o in casa di un amico, a quel gioco di risignificazioni semiotiche della materia che trasforma, di volta in volta, la fastidiosa fascetta commerciale di un thriller, o un vecchio e ingiallito biglietto da visita, o ancora un frammento di volantino nel perfetto filo di Arianna della nostra lettura corrente? Come fa un lettore a separarsi da uno strumento al limite del metonimico, da un correlativo oggettivo così strutturalmente necessario, nel nostro immaginario collettivo, da assumere (si direbbe) la funzione di ricordarci dei divani e delle sdraio colonizzati nelle nostre estati da lettori infanti, da assurgere quasi ad appendice complementare di una massa di fogli che acquisisce vitalità solo grazie alla sua presenza?
Incredulità e sospetto, quindi. Incredulità di fronte alla menomazione volontaria della propria esperienza libraria, sospetto per quel tomo poderoso in bilico su un comodino già troppo gravato da altri libri e che, però, in assenza di una pur piccola protuberanza cartacea policroma, nulla lascia supporre venga effettivamente letto. Ecco allora emergere il reale, subdolo sottotesto di una domanda (“Come fai?”) che altrimenti parrebbe alquanto innocente: “Lo fai davvero?”. L’insinuazione, detta altrimenti, è quella di essere un lettore solo virtualmente impegnato nell’atto di lettura, ma in realtà manchevole di un qualsiasi sintomo materiale che possa segnalare quello stesso atto: un lettore incapace di lasciare un segno, un marchio che proprio in virtù della propria specifica quotidianità (e quindi, possiamo dire, portatore di una presunta autenticità) assuma un significato inequivocabile di uso (e consumo) di quell’oggetto intellettuale. Per quanto surreale possa suonare la cosa, la questione sta effettivamente in questi termini: a meno di non essere colto in flagranza di lettura, o ancora peggio, in flagranza di spiegazione di quel che si è letto, il lettore non abituato a sottomettere l’oggetto libro e a farne propria la materia (come sono io) trova nel segnalibro l’unico alleato per dimostrare la sua buona fede, l’unico segno di una partecipazione concreta all’atto di lettura, l’unica prova che non sia tutto una mera finzione ben orchestrata. Effettivamente qualcuno ha toccato, forse persino letto, quel classico greco che, è vero, giace polveroso su di uno scaffale, ma di sicuro è stato aperto: il segnalibro ne è testimone!
Di qualsiasi natura fossero le reali intenzioni degli apologeti del segnalibro di cui sono costellate le mie memorie infantili, le domande rimangono e necessitano di un’adeguata risposta. Da bambino ero forse io stesso troppo infastidito da questa mia anomala insofferenza nei confronti di inoffensivi rettangoli di cartoncino per riuscire ad interrogarmi proficuamente al riguardo. Mi limitavo, quindi, a ricondurre tutto al punto centrale della questione, in fondo squisitamente pragmatica: il segnalibro semplicemente non mi serviva, mi ricordavo dove ero arrivato e, se non ero in grado di ritrovare subitaneamente il filo, rileggere un paio di pagine addietro era solo un’operazione piacevole, una regola del gioco. Solitamente, questa risposta veniva giudicata insufficiente e dovevo affrontare l’incredulità del mio interlocutore, legittimata dalla mia pessima abitudine dell’epoca di proseguire in parallelo la lettura di almeno un paio di libri per volta. Una situazione che diventava alquanto critica in estate, quando il tempo per leggere si dilatava a mio piacimento, e per la quale comprendevo la frustrazione di chi cercava, infruttuosamente, di farmi partecipe del culto misterico del segnalibro. Ma la mia determinazione sfociava fin troppo spesso nella più bieca testardaggine (e forse la lettura contemporanea di un numero sempre maggiore di libri era solo il modo per sfidare la mia memoria o, più romanticamente, l’ordine librario costituito che mi imponeva l’uso di quell’oggetto ai miei occhi così inutile), e il mio interlocutore era costretto a rifugiarsi dietro le linee dell’ultimo fronte, la roccaforte dell’estetica, non potendo immaginare che sono proprio coloro che svuotano il segnalibro di ogni portato pratico a poterlo osservare solo come oggetto dalle (quasi sempre modeste) ambizioni artistiche (incredibile come i segnalibri aforistici della Feltrinelli si siano scavati un posto nel mio immaginario di lettore, pur avendoli avuti per le mani quasi sempre solo per il tempo necessario a dimenticarli su qualche scaffale). D’altronde, qualsiasi oggetto sufficientemente piatto e lungo può fungere da segnalibro; viceversa, un segnalibro nato come tale può essere facilmente trasfigurato in qualcosa di diverso, fosse anche solo una cartolina molto allungata.
Così, nel perdurare di un’idiosincrasia tanto pervicace quanto misteriosamente insondabile, proseguiva la mia crociata squisitamente privata e solitaria contro il segnalibro. E sebbene interrogarmi su questo aspetto marginale della mia esperienza di lettore non fosse esattamente una prerogativa, la domanda resisteva a qualsiasi tentativo di archiviazione definitiva. Comprendevo, in qualche modo, che quella altrimenti innocua abitudine, tanto radicata, naturale ed istintiva da non poter essere datata nella mia storia personale, era forse l’epifenomeno di un’identità di lettore ben più profonda e significativa, forse persino potenzialmente epifanica. Arrivai lentamente alla conclusione di star sbagliando prospettiva: non mi dovevo domandare cosa trovassi di sbagliato (concettualmente? esteticamente? persino moralmente?) in un segnalibro in sé, ma cosa trovassi di sbagliato in un libro con un segnalibro. Perché, per dirla con Mark Fisher, un libro così segnato mi trasmette un’insopprimibile sensazione di weirdness?
Non più un’appendice naturale e quasi fisiologicamente necessaria all’oggetto libro, ma una mostruosa protuberanza tumescente, connotata da un’impossibile perfezione geometrica, da una turgidità violenta e violatrice: ecco che il segnalibro assurge per me ad elemento perturbante sia sul piano fisico che su quello temporale, al contempo un incrinarsi dell’unità spaziale discreta del corpo libro, e un ineludibile memento dei propri progressi che travalica la pura dimensione privata. In generale, qualcosa che non dovrebbe esserci, uno sconvolgimento della familiarità cartacea. Un corpo estraneo. Un corpo altro. È questo il concetto cardine, l’estraneità. L’assoluta incomunicabilità tra due corpi, una simbiosi mancata (o forse, al contrario, un’unione naturale vietata dal crudele arbitrio dell’Io-Lettore, signore e padrone del suo feudo librario? Un matrimonio che non s’ha da fare, ma solo nella mia schizofrenia lettoria).
Provando a scendere ancora più a fondo, sono le conseguenze della presenza di questa sottile materialità aliena, di questo spessore definitivamente altro, a dover essere indagate. Conseguenze che è bene analizzare, più che su un piano concettuale, da un punto di vista prettamente materiale. In altri termini, il vertiginoso senso di weirdness riguarda nello specifico la separazione materiale, sebbene impercettibile, che subiscono le pagine brutalmente divise dalla violenza segnalibracea: una sorta di parossistico horror vacui per uno spazio che, forse, proprio in virtù della sua impercettibilità e sostanziale trascurabilità assume, nella mia visione drammatica e drammaturgica, un’importanza cruciale e straziante.
Un vuoto insostenibile, quindi, che potrebbe spiegare la repulsione ancor più radicale che provo nei confronti dei surrogati segnalibracei interni al libro stesso. Se, infatti, non essendo elementi estranei al corpo libro, piuttosto appartenendogli, partecipando al e del suo unicum, un angolo di pagina piegato o un uso eterodosso dei risvolti di copertina risolvono aprioristicamente il problema dell’alterità del segnalibro, non si può dire lo stesso per la questione della separazione che subisce il continuum delle pagine, tanto più traumatica in quanto proviene, in questo caso, dall’interno del libro stesso. Aggressione meschina, violenza insensata ed irrazionale nella sua estrema funzionalità: un tradimento dell’Io-Lettore nei confronti del corpo libro, dell’epidermide libraria nei confronti delle pagine, delle pagine nei confronti dei caratteri che su di esse giacciono inermi. Ma se nel caso del segnalibro è lo spazio a costituire la perversione primaria dell’unità del corpo libro, nel caso dell’uso di parti del libro stesso in funzione segnalibracea ad intervenire come prima perversione è una manipolazione di quella stessa materia che sembra quasi auto-pervertirsi. Ecco, allora, che ad essere traumatizzante non è (solo) l’introduzione di uno spazio alieno al corpo libro, bensì un tentativo (in nuce) di dissoluzione
Dell’integrità materiale
del corpo libro stesso, della sua inviolata, forse involontaria, perfezione statuaria. La fisicità del libro entra prepotentemente in gioco, nullificando le possibili spiegazioni concettuali per una soluzione più radicale, atavica, viscerale. Non resta che rassegnarsi a dover spostare il piano dell’indagine: dal segnalibro e dalla sua intrinseca minaccia alla materialità libraria, al tragicamente inutile sforzo di preservazione di questa stessa materialità e alle motivazioni occulte di questa frenesia compulsivamente conservatrice.
Diversamente dal mio atteggiamento nei confronti del segnalibro, il problema dell’integrità materiale del mio patrimonio librario non ha assunto da subito i tratti che lo connotano attualmente, nell’economia della mia vita da lettore. Si può dire che l’attenzione per la concretezza del corpo-libro, e l’annessa riflessione sulle questioni che comporta il riconoscimento di questo ente nella sua fisicità, siano maturate in seguito a eventi ed evoluzioni del mio leggere per lo più contingenti. Pur non potendo escludere, infatti, un’ovvia influenza famigliare rimasta sopita nel corso degli anni, è con l’ingresso nei miei scaffali dei primi volumi fumettistici che è venuta ad imporsi con urgenza la necessità di guardare non solo al contenuto, ma anche al contenitore, uno slittamento significativo dal significato al significante. Lo scarto fisico tra un libro da lettura, anche prestigioso, e una qualsiasi edizione fumettistica che non sia un albo mensile è stato uno shock capace di farmi mettere in discussione buona parte dei paradigmi che dominavano la vita del mio Io-Lettore: da sempre devoto discepolo della brossura, mi sono ritrovato sperduto discepolo della compattezza rassicurante del cartonato di cui sono spesso rivestiti simili volumi a fumetti; mai frenato dall’acquisto di un libro se non dall’indisponibilità economica, ora subentrava nella scelta anche la valutazione materiale di un ente fisico calato nella sua spazialità, ancora prima che nella sua dimensione culturale; fino ad allora per lo più indifferente ai traumi che subiva il corpo libro, ho iniziato a temere per la sua fragilità intrinseca, a prendere precauzioni, a guardare con sospetto il tragitto che dalla libreria porta verso casa, irto di ostacoli che attentavano alla sua integrità materiale.
Questa nuova percezione ha presto condizionato, retrospettivamente, anche il passato della mia attività lettrice, e le categorie che ora guidavano la mia mano tra gli scaffali delle librerie estendevano il proprio dominio fino a raggiungere le più umili tra le edizioni economiche. Sebbene alcune idiosincrasie indissolubili siano rimaste radicate con forza nel mio Io-Lettore (la copertina rigida per tutto ciò che non sia un libro d’arte o un fumetto, salvo rare eccezioni, è tutt’ora in grado di devastare la mia coscienza), la necessità di avere tra le mani un certo libro si andava trasformando nell’ossessione che quel corpo cartaceo fosse intonso ed immacolato: la consuetudine di portare con me qualcosa da leggere si macchiava di sinistre insidie che dovevo trovare il modo di neutralizzare (l’interno del mio zaino non mi è mai apparso così sporco come la prima volta che ho prestato attenzione alla costa di un libro lasciato vagare lì dentro per qualche ora; non sono più riuscito ad abbandonare l’abitudine di portare a mano il libro prescelto per accompagnarmi nel corso della giornata).
Sono sempre stato cosciente dello statuto a dir poco ambiguo di questa nuova ossessione, sia sul piano più strettamente pragmatico che su quello concettuale. Innanzitutto, anche nella fervida speranza di immobilizzare temporalmente il corpo libro, di sottrarlo al degrado materiale, riconosco la vanità del mio presupposto (e, di certo, mi compiaccio anche dell’evanescente tono tragico che assume questa consapevolezza, o il tentativo incurante di perseguire comunque il mio fine). Il corpo libro, fuor di elegia, è prima di tutto corpus oeconomicus, bene di consumo atto, appunto, ad essere consumato (o meglio, a consumarsi) e non a durare: condannato alla dissoluzione, costruito con questo scopo. D’altronde, nel nostro mercato culturale, qual è il bisogno di creare oggetti che persistano nello spazio e nel tempo? La maggior parte delle opere che potremo leggere nel corso dei nostri anni ci sopravvivrà, se non fisicamente almeno digitalmente, ma lo faranno in quanti enti culturali e non come oggetti materiali. La scomparsa della necessità di preservare l’oggetto libro, ha decretato il venir meno della considerazione stessa per quel corpo. Replicabile, persino sublimabile in una forma eterna, il corpo libro considerato nella sua fisicità sembra essere il retaggio di un passato innecessario, una zavorra materialistica che però, paradossalmente, rifulge tutt’ora nella sua continua perpetuazione consumistica. Per trasfigurare l’oggetto fisico in mero guscio senza valore, bisogna puntare alla moltiplicazione infinita, o alla potenzialità sempre sottesa, invocata, minacciata, della moltiplicazione stessa.
Date queste premesse, sarebbe facile, per me, liquidare la percezione acquisita sulla fisicità del corpo libro come una concezione EstEtica, ovvero non solo rivolta alla preservazione/fruizione materiale del libro come oggetto Estetico, ma anche calata in una dimensione di resistenza Etica verso il sistema riproduttivo-consumistico. Il riconoscere una dignità Estetica al corpo libro permetterebbe di ricomporre quella frattura tra significante paratestuale e significato intracorporeo che la considerazione capitalistica del libro ridotto a bene di consumo comporta intrinsecamente. Bisognerebbe notare poi come, paradossalmente, la vittima meno evidente ma più eclatante della nostra produzione libraria fuori controllo sia il fronte fisico del libro, più che il suo contenuto, come si potrebbe inizialmente ritenere: continueremo a scovare le opere di oscure case editrici di cui dubitavamo l’esistenza, ma le loro fatiche tipografiche ci lasceranno inerti. Ben prima di considerare il contenuto delle nostre letture come puro consumo, avremo (o abbiamo, da tempo) degradato il corpo libro a ricettacolo esteticamente dimenticabile: lo Zeitgeist informa prima la nostra concezione fisica del reale che le nostre categorie del pensiero. Riportare al centro del discorso questo corpo è, forse, altrettanto urgente delle considerazioni reazionariamente pessimistiche sul contenuto letterario.
Per quanto profondamente convinto della validità di un simile discorso EstEtico, le intrinseche ambivalenze che lo connotano diventano pressanti se questa prospettiva viene calata nel mio caso specifico. Ecco che l’EstEtica, da potenziale mezzo di eversione, si trasforma in maschera vigliacca per delle contraddizioni personali insanabili. La questione si riduce, sostanzialmente, alla comprensione di quanto l’avvicinarsi, o meglio l’immergersi, in una dimensione materialistica possa cedere il passo ad una partecipazione conclamata ed entusiasta (ma travestita grottescamente da resistenza) a quello stesso sistema consumistico che cercherei di scardinare. Quale, dunque, il confine tra estasi mistica materiale e consumo sfrenato commerciale? È, ovviamente, una questione di gradazioni, di sfumature, impossibile da dirimere anche in considerazione della propria continua evoluzione: il mio materialismo attuale non è quello spasmodico del primo periodo, e non sarà simile a quello che condizionerà la mia attività futura da lettore. Eppure, anche nell’impossibilità di cristallizzare un’impossibile diacronia, l’interrogarsi (anche continuo) su questo aspetto della vita del mio Io-Lettore rimane un processo ermeneutico essenziale, vista la centralità del tema rispetto la percezione fisica dei miei libri, dei loro corpi.
Ho già accennato all’improbabile sopravvivenza dei nostri libri alla nostra morte. Quello che mi colpisce è l’assenza, in me, di una qualche ossessione legata a questa, temo ineluttabile, ingloriosa fine di un patrimonio librario, frutto di una paziente (e in gran parte ancora da realizzarsi) opera di accumulazione, selezione, raffinamento. Una stanca e fin troppo pacifica rassegnazione ne ha preso il posto, che proprio in quanto improbabile positiva eccezione in un rapporto altrimenti morboso risulta tanto più sospetta. Nelle mie elucubrazioni librarie manca del tutto una qualche percezione del futuro, estromesso quasi fosse una dimensione aliena, una categoria inapplicabile e fallace. E si potrebbe indagare, anche, come la stessa rassegnazione si trasmetta, retrospettivamente, a quei libri che, già appartenuti ai miei genitori, sono stati prontamente da me riacquistati: non tanto per godere di un’edizione intrinsecamente diversa, quanto per appropriarmi di un corpo libro nuovo, per farlo mio da principio. Ho condannato, quindi, dei libri ad un limbo eterno in quanto enti estranei e stranianti, corpi portatori di un’alterità ineliminabile. I miei libri sono enti senza passato né futuro, indissolubilmente legati alla mia presenza.
Il corpo libro necessita, dunque, di essere nuovo o, più precisamente, vergine: la sua integrità materiale è segno incontrovertibile della sua purezza, della sua non appartenenza antecedente. Lo sfiorare la copertina si trasforma in un primo approccio, il soppesare diventa un misurare la compatibilità tra Io-Lettore e corpo libro, lo sfogliare le pagine muta in possessione. Quel corpo, amato e riconosciuto come tale (chi ha detto che un libro non si giudica dalla copertina non ne ha mai amato uno), è un prescelto tra i tanti. Un unicum spaziale e temporale, irriproducibile anche se riprodotto.
L’ambiguità irriducibile di questa possessività risiede, ovviamente, nella concezione individualistica del corpo libro che vi soggiace e che trascina con sé tutte le contraddizioni EstEtiche già tratteggiate, proprie del sistema consumistico in cui questo processo si compie. Questo unicum librario è sì un prescelto, ma non lo è ontologicamente: lo è solo in quanto reso tale da me, è il mio prescelto. Ma prescegliere vuol dire anche escludere e soprattutto precludere; la possessione individualistica del corpo libro è un gioco a somma zero. In altre parole, il riconoscimento della materialità del corpo libro è sì uno strumento di lotta eversiva e di tentata ricomposizione della frattura tra espressione fisica e contenuto letterario, ma al contempo si deve piegare all’ossessione consumistica di un possesso individualistico soggetto ad una logica binaria presenza/assenza, mio/tuo. È, se vogliamo, l’opposizione tra libreria e biblioteca ricondotta ad una dimensione soggettiva.
Questa volontà di possesso è, nell’economia delle mie ossessioni, un elemento precipuo del rapporto che ho con i corpi libro, estraneo al resto degli oggetti feticisticamente analogici che mi passano per le mani. Degli strumenti fotografici squisitamente anacronistici di cui mi circondo non sono che un semplice guardiano. Potrei, forse, esserne persino l’ultimo, ma questa consapevolezza non potrebbe mai ridurre i miei sforzi per non proiettare il mio Io su quell’intrico di corpi metallici. Quel banco ottico che tanto mi pesa sulla schiena, quell’idiosincratica e bizzosa Polaroid che non ho mai compreso se fosse funzionante o meno, quell’ingranditore mutilato di cui ancora cerco introvabili componenti: tutti, anche se acquistati a caro prezzo, non sono per me oggetti da possedere, ma fragili corpi da custodire; tutti, già molto più vecchi di me, mi sopravvivranno; tutti, già posseduti da altri, non sono miei ma sono in potenza già di chi verrà dopo di me.
Alla luce di tutto quello che si è detto fino ad ora, si capiscono le ragioni di quel mio caro amico che mi interrogava: “Perché non compri libri usati?”. Domanda legittima, se si guarda all’ingenuo e idealistico amore proiettato nel futuro per quei sottrattori di attimi che sono le macchine fotografiche. Eppure, ovviamente, domanda scomoda e terribile, quasi una pugnalata alle spalle. Per quanto mi possa difendere con argomentazioni, anche valide e ragionevoli, quali il sostegno alle piccole realtà (librarie o editrici poco importa) o la necessità di aggiornarsi alle edizioni più recenti, la reale motivazione soggiacente al mio feticismo per il nuovo e il vergine è e rimane quella che abbiamo già esplorato: un’ineludibile volontà di possesso individualistico.
Questo primo scoglio di coscienza introspettiva, così faticosamente conquistato, non è però che la sola prima parte della questione, il primo lato, se vogliamo. Ad accompagnare l’ossessione per la verginità del corpo libro c’è, infatti, anche una fascinazione acerba e ancora incerta per i corpi lacerati, per le piccole ammaccature, per le imperfezioni involontarie. Emerge sempre da un senso di malcelata frustrazione, questa sfaccettatura inattesa del mio materialismo. Si palesa codardamente quando, una volta tornato a casa, il corpo libro prescelto, al tocco, rivela delle leggere bolle d’aria nella costa che era parsa così liscia e levigata; impercettibili slabbrature della sottile patina plastica che copre la copertina; un gruppo di pagine con una strana torsione, non piegate ma neanche perfettamente parallele alle loro sorelle; un piccolo grumo di sporcizia indistinta che sbiaditamente macchia l’interno della sovraccoperta. Il rigetto, istintivo e animalesco, è la prima reazione, presto sostituito da un senso di rassegnata accettazione: d’altronde, quel corpo imperfetto è comunque un prescelto. Se non è virginalmente puro, lo è comunque diventato ai miei occhi, anche solo per il momento in cui è stato raccolto e accolto. La colpa, se ne si può parlare in questi termini, è mia, non del corpo libro.
Da cosa deriva quel primo impeto di sfiducia, di repulsione, di incredulità per la messa a fuoco di un corpo misero dove prima sembrava esserci l’incolume purezza? Si potrebbe ridurre il tutto, compresa tutta la mia EstEtica, ad un’ottica puramente economica (e negarne del tutto la presenza, l’influenza sulle mie ossessioni sarebbe una scorrettezza intellettuale): ho pagato per quel corpo, per quella materia, e la perfezione è il suo plusvalore EstEtico. Eppure la questione appare più complessa, più stratificata, a partire dalla sproporzione con cui si manifestano queste occorrenze di imperfezione non colta. Non si tratta di un fenomeno raro, è invece una macchia estesa, che si riversa fino a coprire la maggioranza dei miei corpi libro. Il focus si sposta, allora, sul riconoscimento di un’intenzionalità sottesa a queste scelte errate; un’intenzionalità paradossalmente passiva, inconscia, difficile da sondare in quanto in apparente contraddizione con tutto quello che già si è detto; un’intenzionalità che, se riconosciuta, costringerebbe a rivalutare tutta la mia possessività individualistica sottesa al rapporto con i corpi libro. Non perfezione, ma leggera imperfezione; non l’optimus inter pares, ma il suo secondo. La ricerca inesausta del prescelto sarebbe, in realtà, la ricerca di un corpo insondabile, di un corpo liminare, non usato ma neanche del tutto nuovo, in quanto già toccato, già soppesato, forse persino amato ma rubato anzitempo da me ad un altro Io-Lettore, che contava di ritrovarlo nella sua successiva sortita libraria.
Sarebbe allora questo, il livello più nascosto di un materialismo alla ricerca, estenuante, di oggetti dallo statuto incerto: una fascinazione pudica e schiva per quelli che, forse, sono realmente corpi virginali e puri, ma solo ai miei occhi. Perché quel fulmineo impeto di rigetto, che segue alla scoperta delle imperfezioni superficiali del prescelto, non è altro che un fuoco di paglia. Una volta spento, è fra le sue ceneri che si trova l’amore sincero per quei corpi libro, la cui fragilità sempre esposta è evidenziata da difetti trascurabili ed invisibili, dal sottile, impercettibile strato di storia personale depositata sulle copertine, sulle pagine, sui dorsi e le coste. Un’incredulità che cede il passo al riconoscimento dell’oggetto del desiderio, all’accettazione consapevole di aver scelto un corpo libro già segnato per attrazione nei confronti di questa sua stessa condizione.
Letta in quest’ottica, l’ossessione per la preservazione dell’integrità materiale libraria perde la sua connotazione possessiva (e forse persino la componente individualistica). Se il corpo libro che (inconsciamente) mi interessa non è quello puro ma quello già parzialmente, impercettibilmente segnato, allora anche il conservarne lo status naturale-materiale si scardina in parte da una dimensione puramente soggettiva: non è per me che preservo l’integrità fisica dei corpi libro, né per qualcuno che verrà dopo di me, ma è per loro stessi. È l’atto finale di quella restituzione di una dimensione univoca al libro, di quella faticosa ricucitura tra significante e significato. Un atto d’amore per l’oggetto riconsegnato a se stesso, un atto EstEtico stavolta realmente puro, innocente, gratuito. D’altronde, se è una pulsione possessiva e capitalistico-individualista a guidare l’acquisto compulsivo e la ricerca di una materialità che mi soddisfi, questi stessi istinti sono quasi del tutto assenti dalla pratica e dalla pragmatica del mio rapporto quotidiano con i corpi libro. L’assenza dei segnalibri, la repulsione per gli ex libris, l’assenza voluta di un contrassegno per indicare la proprietà libraria: tutti indizi di un orrore inconscio per l’assoggettamento del corpo libro, di un rifiuto radicale per la sua sottomissione. Il libro è mio e al contempo è restituito a se stesso.
È, però, necessario riconoscere al contempo come la spinta EstEtica potrà pur essere un modo per sfuggire alla forza di gravità di una contraria spinta consumistica, ma fin quando continuerò a comprare i miei corpi libro avrò raggiunto solo un’orbita stazionaria. Ed è, infatti, non tanto sul tema dell’integrità materiale, quanto su quello
Della quantità
che si misura la pervasività dello Zeitgeist consumistico-capitalista. Non che il mio personale materialismo librario ne sia indenne nei singoli elementi: se i corpi libro sono da me prescelti, se vi è una selezione fisica oltre che concettuale, è perché innanzitutto questa scelta è possibile. Potremmo chiamarla una possibilità dell’abbondanza, distinta in due differenti accezioni: la prima si configura come possibilità di scelta permessa dall’abbondanza corpolibracea; la seconda, ed è qui che l’ossessione materialistica rientra in gioco, è la disponibilità economica a reificare il desiderio possessivo del corpo libro. In altri termini, il possesso dell’oggetto fisico è parte integrante del mio atto di lettura, una componente indissolubile del mio Io-Lettore, solo in quanto questa proliferazione di corpi mi è economicamente accessibile. Mai soggetto al prestito bibliotecario, quindi mai costretto a pensare all’oggetto libro con la categoria della temporaneità, il mio interesse si è evoluto naturalmente verso la sua fisicità. Il possesso del corpo libro, sebbene cooptato come mezzo eversivo, nasce quindi nei termini di un riflesso naturale dell’industria culturale tardocapitalista.
Il materialismo possessivo e l’EstEtica della fisicità sono, dunque, agenti ambigui del mio Io-Lettore da indagare non solo qualitativamente, ma anche quantitativamente. O meglio: il discorso quantitativo è anche un discorso qualitativo e viceversa, non facce diverse della stessa medaglia ma piani intrecciati impossibili da districare. Potremmo dire che la reale problematicità dell’EstEtica risieda nella sua intrinseca propensione alla poligamia con i corpi libro, alla proliferazione della possessione. È la reiterazione del possesso a renderlo effettivo, è il rinnovo del patto d’amore attraverso i singoli corpi libro a perpetuare la presenza reale di questo stesso amore. Per questo l’ossessione libraria fisico-materialista rischia perennemente di trasfigurarsi in agente inconsapevole ma colpevole di un consumismo bulimico: amo ogni singolo corpo libro, ma (per quanto paradossale possa sembrare) per amarne uno devo amarne mille.
Ed è, invero, proprio un paradosso: tanto intricato da dover sottintendere, se proprio lo si vuole risolvere, un amore per la fisicità dei corpi libro moltiplicabile a piacimento. Un gioco stavolta non a somma zero, che lascia sempre spazio per un altro elemento imprevisto, quel libro adocchiato di sfuggita e che non credevamo avremmo preso proprio quel giorno. L’amore ossessivo per i corpi libro diventa un amore caleidoscopico, al contempo uno e molteplice, un amore rivolto ai singoli elementi, ma che abbraccia anche il loro insieme. La questione è, nei suoi termini, ribaltata rispetto all’assunto iniziale. Non è l’amore sempre malleabile ad essere paradossale, ma lo sarebbe un amore definito e limitato a priori.
La si potrebbe anche porre come una pura questione di sistema, se volessimo: come il significato delle singole parole di una lingua non si definisce nella propria singolarità atomistica, ma solo in relazione al resto del repertorio lessicale, così l’essenza di ogni mio libro non si riscontra nella propria soggettività individuale, ma solo nell’insieme degli altri libri che gli stanno attorno. Se si accetta quest’ottica di analisi, l’opposizione libro nuovo/libro usato diventa una questione di macro-sistema, che si misura non più sul singolo corpo libro ma nell’insieme librario costituito dalla scelta, continuativa e costante, di una serie di corpi libro differenti: un’opposizione libreria/biblioteca. È, come si è già detto, un’opposizione nell’ordine della possibilità economica di procurarsi, possedendoli, i corpi libro. Possesso contro prestito, visione atomistico-individualista contro visione comunitaria: l’amore per il singolo corpo libro potrebbe essere scevro da queste antinomie, ma l’amore per l’insieme dei corpi libro posseduti (la libreria personale e selezionata) non può che presupporle. La costituzione di una libreria è, detto in altri termini, una scelta di carattere quantitativo che sottende quella di carattere qualitativo: anche una libreria ideale e limitata è, in principio e in sintesi, un insieme di libri.
Ovviamente, non si può ragionevolmente sostenere la tesi per cui ogni costitutore di una personale, cesellata ed idiosincratica libreria individuale sia soggetto, per forza di cose, a questa oscura forza consumistica. La casistica è ampia e soggetta alle contingenze della vita di ogni Io-Lettore, ma non sono questi gli argomenti della nostra indagine. La problematicità del mio possesso quantitativo, della propensione all’accumulo, risiede infatti non tanto nella stessa presenza di un insieme (che potrebbe essere ottenuto senza ricorrere alla degradazione del corpo libro a corpus oeconomicus), quanto nella necessità ossessiva di espanderlo illimitatamente. Lo possiamo leggere come un rifiuto aprioristico di un confine, di un limen, che però assume su di sé una valenza non univoca. Se l’accumulo porta all’espansione continua della mia libreria, e da questa nasce una negazione perpetua del limite, quest’ultima idiosincrasia da cosa dipende? È un tentativo di annullamento dell’Io come insieme, a favore di un riconoscimento preponderante (prima interiore e poi sociale, pubblico) dell’Io-Lettore? In questo caso, si dovrebbe presumere che io stia cercando di riempire, letteralmente, la mia vita (e soprattutto la sua fisicità) di un elemento tanto riconoscibile quanto identitario: una sorta di reductio ad lectorem, atta a limitare (interiormente, psichicamente, ma anche socialmente) il mio costitutivo eclettismo fino ad una (vagheggiata ma irraggiungibile) monodimensionalità intellettuale. Farmi sommergere dai libri per non lasciare spazio ad altro. Oppure potremmo ribaltare la questione, interpretando la mole libraria crescente che tutto divora come un modo per scaricare il mio Io (Lettore e non-Lettore, con tutto quello che vi è in mezzo) verso l’esterno: non un annullamento, ma al contrario una proiezione.
Che sia un’imposizione dell’Io sulla materialità o un tentativo totalizzante dell’Io-Lettore che parte dall’esterno per arrivare all’interno, il minimo comun denominatore rimane un insopprimibile horror vacui, vero motore dell’espansione fisica della mia libreria. Bisognerebbe chiedersi, allora, non più quanti corpi libro ancora potrei amare (una domanda a cui abbiamo già dato una risposta squisitamente tautologica: “tutti quelli che ancora amerò”), ma quanti ancora potrei fisicamente possederne prima di superare la solitudine spaziale che mi circonda. O, in altri termini: verrà meno prima la disponibilità economica per acquistarli, questi corpi libro, o prima lo spazio dove stiparli? Quanti ne potrò comprare, nella mia vita? Di quanti corpi verrò in possesso per vie traverse, nel corso degli anni? Quanti corpi dovrò imparare ad amare, senza averli scelti, senza averli pensati nell’insieme, eppure immettendoveli comunque? La questione della quantità è un tentativo (fallimentare) di rimozione, un’energia inglobante che provo a trascurare ma che sempre si ripresenta.
Un vuoto da colmare, quindi. Un vuoto spaziale ma anche un vuoto temporale: ridurre le ambiguità quantitative a una dimensione meramente spaziale vorrebbe dire lacerare, nuovamente, significante e significato, sottrarre al libro quell’unità EstEtica faticosamente raggiunta (ma anche sempre così fragile, così precaria e problematica), rinnegare la connessione bivalente tra il corpo libro e il suo contenuto concettuale. La quantità non si consuma nella sola fisicità sincronica di un momento, ma si evolve in un processo diacronico di continuo accrescimento consumistico. È la storia della mole, della massa, dell’insieme di corpi della mia libreria, il vero problema. Il mio piano di ricerca introspettiva si evolve: non più, solo, quanti libri potrò ragionevolmente e fisicamente possedere, ma quanti fra questi potrò leggerne. Qual è il rapporto tra i libri che compro e i libri che leggo? E se questo rapporto è a sfavore della mia velocità di lettura, perché ho acquistato quei corpi? Corpi che forse non toccherò per anni, che forse non avrò il tempo di soppesare, di carezzare, di amare. Leggere di più, leggere più in fretta, risolverebbe il problema? Quanti libri, quanti corpi, quante pagine, quante storie, quanti ragionamenti: quanto di tutto questo ho già vissuto troppo velocemente, senza lasciargli il tempo di farlo sedimentare, di segnarmi; senza permettermi di amarlo, senza permettergli di farsi amare? Horror liminis e horror vacui si accompagnano all’horror temporis: è il fantasma della conoscenza a tormentarmi, lo spettro della finitudine, la consapevolezza di non avere, già da adesso, il tempo per leggere tutto quello che vorrei o, forse, in una prospettiva ancora più inquietante, tutto quello che già possiedo. La domanda finale: quanti libri, di quelli che possiederò alla mia morte, non avrò ancora amato?
La tentazione è quella di dare ragione a Flaubert, quando professava la vera cultura attraverso la conoscenza approfondita di soli cinque o sei libri. Un tentativo estremo, radicale, disperato, tanto nella sua accezione concettuale che in quella librariamente materialistica: una selezione crudele e necessaria. Cinque libri, cinque corpi da conoscere, esplorare, alla ricerca inesausta delle piccole imperfezioni che fanno di quell’unicum un optimus mancato, che lo rendono prezioso. Cinque corpi da amare: ancora molti, se si considera lo standard monogamo occidentale per le relazioni tra essere umani. Eppure (paradosso nella linearità apparente della soluzione), se ammettiamo di riconoscere nella forma libraria il medium cognitivamente più economico per la trasmissione di informazione, come si può pensare di conoscere a fondo quei libri e rimanere, al contempo, fedeli ai loro corpi? Per scavarli nella loro concettualità non si può prescindere dalla conoscenza di tutto quello che li circonda, e per farlo si dovrà ricorrere ad altri libri. Un paradosso peirceano: in una eterna fuga degli interpretanti non si potrà che leggere altri libri per poter almeno tentare di capire davvero la cinquina prescelta. E se anche si decidesse di non possedere questi libri secondari, si sarebbero comunque (biblicamente) conosciuti altri corpi libro. La fedeltà nei confronti di quei cinque libri prescelti, assoluti, non potrà mai essere totale: è un rapporto condannato in principio al fallimento e alla rovina, ad essere intaccato dalla presenza continua di elementi altri, esterni eppure essenziali. Si torna, ossessivamente, ad un sistema libreria che presuppone, per poter amare un corpo libro, di doverli amare tutti: i presenti, i passati, i futuri.
Alla quantità bulimica in espansione si contrappone (apparentemente) lo stimolo razionalizzante
Dell’ordine
in cui i corpi libro sono disposti. In realtà, i due piani si intrecciano e si richiamano vicendevolmente; il passaggio tra una forza espansiva colonizzatrice dello spazio (esteriore ed interiore) e una logica ordinatrice è continuo, non discreto. Si tratta di momenti interconnessi, indistinguibili su un piano temporale: ampliare la libreria è già un atto ordinatore. Un atto dovuto, che collabora attivamente all’amore per i corpi libro, che li preserva nella loro integrità materiale, al contempo trauma nello spostamento e lenitivo dei traumi precedenti. Un atto in cui si condensano molte delle questioni che abbiamo già trattato: la pervasività del sistema culturale tardocapitalista nelle categorie e nei paradigmi individuali; il riconoscimento del corpo libro come parte integrante ed imprescindibile di un unicum librario spazio-temporale; le idiosincrasie, le ossessioni, le ambiguità e le parzialità del posizionamento del mio Io-Lettore nei confronti dell’entità libraria.
I sistemi di classificazione di una libreria personale (e, in quanto tale, per forza di cose ridotta e non soggetta alla necessaria e ferrea rigidità ordinatrice di una biblioteca) sono idiosincratici, arbitrari e parziali. Rispondono non tanto ad una reale esigenza di ordine tassativo, quanto ad un bisogno inconscio di sistematizzazione provvisoria. Non è un problema scardinato da quello della quantità; i metodi organizzativi variano a seconda della mola di corpi libro da ordinare, nonché, ovviamente, rispetto all’individuale storia personale del proprio Io-Lettore. Dal colore della costa, alla grandezza dei volumi, dalle collane editoriali, all’ordine di arrivo di ogni libro sui propri scaffali: l’arbitrarietà dei sistemi è sempre aperta a nuove declinazioni, ma è la loro commistione a renderle identitarie e uniche. Ogni libreria non è un corpus discreto e distinto dalle sue simili solo per la presenza di determinati libri e non di altri, ma anche per la loro disposizione, reale specchio (ben più di cosa la libreria contenga) della mente e del sentire del suo proprietario. Nell’insieme librario, indicatore ingannevole e disonesto dell’Io-Lettore, si sedimenteranno anche i corpi libro non prescelti, non amati, quelli di passaggio, quelli regalati e quelli relegati (all’oblio, all’assenza di un Io-Lettore che li ami, alla periferia della coscienza), mentre sono le permutazioni di questo insieme a dipendere ed essere interamente soggette alla volontà dell’Io-Lettore. È la forma del contenitore a plasmare il contenuto, non viceversa.
Questa unicità, però, non può che essere raggiunta dall’affastellarsi di metodi classificatori eclettici e costitutivamente insufficienti. Da qui la loro parzialità, centro di quel gioco di selezione, inconscio e così apparentemente naturale, che porta a plasmare, prima ancora della propria libreria, un necessario principio ordinatore. Si potrebbe dire, infatti, che la pluralità di forme organizzative nasce non tanto da una costituiva differenza idiosincratica tra singoli, quanto dalla loro intrinseca incapacità di assolvere pienamente alla loro funzione, se non in combinazione (e anche in questo caso, vi riescono solo parzialmente). Anche lasciando da parte il caso in cui principi ordinatori sostanzialmente funzionali vengano inficiati da idiosincrasie di vario genere (la mia personale categorizzazione risente costantemente del bisogno, quasi fisiologico nel suo atavismo, di procedere grossomodo secondo l’altezza dei volumi, una pratica tramandatami, oserei dire quasi geneticamente, da mia madre), riferendoci esclusivamente alle pratiche più razionali non si può non notare la loro (necessaria, ovvia, imprescindibile) parzialità: optare per una vuol dire escludere le altre, se non in toto almeno in grossa parte. Un ordine alfabetico può essere informato, come principio sovrastante, dalla decisione di seguire le letterature nazionali, ma solo a costo di un compromesso brutale che li conculca entrambi; una dispositio per genere letterario male si accorda con il tentativo razionalizzante di radunare, come piccoli bastioni da proteggere con la vita, tutti i volumi di una collana o di un editore.
Ecco, allora, che non è solo la sempre mutabile quantità dei corpi libro, a decretare un continuo riposizionamento spaziale dei nostri volumi, ma forse anche, ben più nel profondo del nostro Io-Lettore, una perpetua e borbottante insoddisfazione per questa parzialità ontologica, che porta a un’insofferenza incosciente per un assetto definitivo. Assetto solo ipotetico, ovviamente, irraggiungibile ma forse neanche realmente desiderato. Una provvisorietà condannata ma, nascostamente, amata nella sua imperfezione incorreggibile, non diversamente da quel corpo libro volutamente (inconsciamente voluto) imperfetto di cui si è già detto. Gioco letterario tra i più contorti, eppure tra i più appaganti, la continua risistematizzazione dell’ordine (e del rispettivo principio ordinatore) della propria libreria: peculiare, individuale, idiosincratico; condotto accompagnando con delicatezza l’immissione di nuovi corpi libro o rivoluzionando ciclicamente e irrazionalmente, con furia, la libreria intera. Un’esigenza interiore, quindi, forse atavica, forse semplicemente funzionale.
Riconosco, anche in questo caso, un rapporto peculiare: un momento che per qualcuno può essere non più di un obbligo da sbrigare alla svelta, per me diventa un’occasione di solenne riflessione, retta da un cerimoniale non formalizzato ma comunque formale. Le Campagne di Rinnovo dell’Ordine dei miei corpi libro hanno bisogno di tempo, non tanto per lo spostamento fisico dei volumi, quanto per la loro elaborazione; una Campagna inizia, idealisticamente e mentalmente, nel momento stesso in cui la precedente è terminata, o spesso anche prima. Vengono pensate, soppesate, il momento eletto selezionato con cura: non più solo storia dei miei libri, ma storia della mia mente. È un gioco di equilibri precari, una tensione sottile tra un’espansione che può continuare con piccoli, impercettibili assestamenti dell’assetto librario e l’ossessione serpeggiante per una mobilità continua che, paradossalmente, vorrebbe riportare l’ordine in questo perpetuo rinnovarsi della quantità dei miei corpi libro. Ecco le prime ambiguità: una propensione ordinatrice che però, all’atto pratico, è una costante rivisitazione dei rapporti di vicinanza e di parentela tra volumi. Le Campagne non sono una rassicurante ricomposizione dell’ordine, ne sono la brutale rottura.
Se le Campagne presuppongono una rottura, quest’ultima da dove trae la propria origine? È il cuore della questione dell’ordine: ordinare i libri vuol dire ordinare la propria mente; rivalutare la disposizione dei corpi libri è rivalutare le proprie categorie concettuali. O, ribaltando l’assunto: indagare le divisioni arbitrarie del proprio ordine librario significa scandagliare e mettere in crisi i propri paradigmi culturali. Corpo libro EstEtico, quantità consumistica, dispositio libraria sono, quindi, le tre coordinate di una pervasiva presenza-possessione dello Zeitgeist e dei paradigmi dell’industria culturale tardocapitalista. Ecco, allora, che l’ordine e le divisioni della mia libreria trovano una ragione soggiacente nei modelli che da sempre mi sono passati sotto gli occhi: un’infanzia nelle librerie delle grandi catene non può che avere, come effetto secondario ma non del tutto involontario, la riproposizione di una categorizzazione arbitraria ma culturalmente specifica, e la susseguente creazione di un canone altrettanto definito tramite l’inclusione e l’esclusione dei libri dai vari gruppi.
Scrutando la mia disposizione idiosincratica, l’impronta di questo modello culturale si legge pesantemente. I generi rimangono sempre ghettizzati, quasi fossero impermeabili al costrutto socioculturale della “Vera Letteratura Secondo l’Onnipotente e Incontrastabile Canone Occidentale”. Le divisioni secondo letterature nazionali rendono apolidi un nutrito gruppo di autori che vagano, pellegrini, tra gli scaffali, senza potersi fermare su nessuno, senza patria in lettera come lo erano stati (o lo sono ancora) in vita; costringerli all’immobilità diventa, allora, una violenza, sebbene una violenza necessaria per la stabilità del sistema libreria. I fumetti, relegati ad uno spazio tutto loro, lamentano costantemente la degradazione del proprio status, la lontananza dalle altre letterature; ma se provo a spostarli, accanto a chi si giova di questa nuova sistematizzazione, ci sarà sempre chi denuncerà l’obbligo morale al riconoscimento di un’individualità fumettistica: gli scissionisti subito levano la propria voce, invocando un ritorno alla separazione.
Nella successione incessante delle Campagne, lo abbiamo già detto, la ricerca condannata al fallimento di un assetto definitivo è continuamente frustrata. Il gioco, anche masochistico, dell’Io-Lettore si riduce allora alla continua approssimazione di una forma mai definitiva, un perpetuo avvicinamento a piccoli passi, correzioni che, sebbene nell’ordine di uno sconvolgimento generale delle nostre librerie, si rivelano nella loro impercettibilità. Categorizzazioni parziali che si scoprono tali, in definitiva, non solo in relazione alla nostra necessità, da lettori-consumatori, di una sistematizzazione funzionale, ma anche riguardo alla fisicità dei corpi libro. Per l’Io-Lettore materialista l’organizzazione libraria costituisce, innanzitutto, uno degli ultimi tasselli del progetto di accettazione del libro come entità univoca e ricomposta. Serve, quindi, un riconoscimento al libro e al suo corpo di una dignità che possa essere preservata, mantenuta anche nella dispositio e nelle sue permutazioni temporali. Possiamo aggiungere, oltre le dimensioni e le intenzioni che già abbiamo delineato, un ulteriore aspetto di quest’ansia organizzativa: l’ordine librario come atto sostanziale, politico-poietico, in grado di generare idee e non solo di esserne un riflesso. Detto in altre parole, il modo in cui organizziamo le nostre librerie (dal grado zero dell’assenza apparente di ordine, fino alle più sofisticate e contorte soluzioni) influenza le nostre categorie mentali e i nostri paradigmi culturali non meno di quanto questi si riflettano nell’ordine librario stesso. È in atto uno scambio continuo, che può essere riconosciuto solo attraverso la concessione di un’agentività al corpo libro, all’insieme librario. Il corpo libro ci condiziona, non siamo solo noi a manipolarlo, è stato lui a sedurci: ci ha scelto, come noi abbiamo scelto lui; non abbiamo imposto esclusivamente noi un ordine, ma anche l’ordine ci ha suggerito una nuova riconfigurazione mentale.
Quanto potrò informare il mio personale ordine librario di questa nuova percezione agentiva del corpo libro? Quanto riuscirò a farlo? E come, pragmaticamente, si dovrebbe operare questa disposizione radicalmente nuova? In cosa potrebbe consistere lo spazio di manovra lasciato ai corpi libro? Una lenta erosione dei paradigmi che hanno guidato la mia dispositio fino a questo momento, fino al loro completo dissolvimento? Cosa potrebbe, però, prenderne il posto? Quale logica, quale modello, quale canone avrei costruito; e soprattutto, quanto la si potrebbe attribuire a me, questa nuova forma? O forse, al contrario, dovrebbe essere uno strappo radicale? Ma, in questo caso, quanto potrebbe essere grande il pericolo di costruire una dimensione aliena, una libreria irriconoscibile agli occhi dello stesso che l’ha costituita? Riuscirei ancora ad amare i corpi libro che ne fanno parte?
Sono domande che, mentre osservo uno dei miei scaffali, so che non troveranno risposta. Non è il momento di progettare la prossima Campagna, non ora che sono all’apice del momento estremo dell’atto di lettura, che potremmo chiamare
Del cambio di guardia
(a mo’ di conclusione)
se non accettiamo acriticamente la metafora e ci poniamo subito l’interrogativo di chi stia a guardia di cosa, di cosa guardi chi. Momento delicato e soave, sospeso, come dicevamo all’inizio, ma accompagnato da un senso di vertigine estraneo alla dedizione totale dell’immersione (fisica e concettuale: olistica) richiesta dalla lettura in sé e per sé. Una dedizione che non può che lasciarmi vulnerabile, indifeso nell’ultimo scampolo di lettura, tale che il corpo libro diventa allora la mia unica difesa: una difesa contro la solitudine, innanzitutto, come voleva David Foster Wallace. È il libro a stare a guardia del mio Io-Lettore, quindi, perfettamente calato nel nostro rapporto simbiotico, probabilmente inconsapevole del tradimento al nostro mutuo amore che consumerò tra una manciata scarsa di pagine. La fine, spesso solo temporanea, del nostro rapporto: un sacrificio per la vita di un’altra relazione con un nuovo corpo-libro.
Una volta richiuso il libro appena finito, c’è chi lo sfoglia frettolosamente, o chi ne rilegge singole e brevi parti. Io indugio sulle sue superfici, mi riapproprio della materia di cui è composto, cerco di percorrerla nelle parti che ancora non ho esplorato, lo osservo malinconicamente. Sono consapevole che, forse, non lo vedrò più sotto questa luce. Mi alzo dal letto, raggiungo lo scaffale dove l’ho collocato il giorno che l’ho portato a casa per la prima volta, lo rimetto con cura al suo posto, prendo uno sgabello e mi siedo. Rifletto.
È questo il cambio di guardia, il momento estremo, la massima fragilità. Le mie letture, passate e future, mi guardano e mi proteggono. È qui che si addensano le contraddizioni, le ossessioni, le idiosincrasie, l’andamento schizofrenico del mio rapporto con il libro, con la sua materia concettuale, con la sua astratta fisicità. È un vortice impenetrabile, un rincorrersi compulsivo, un ritornare ciclico sempre allo stesso punto, sempre alla stessa materia, una spirale in cui si perdono tutte le riflessioni precedenti. È la scelta più difficile, il passaggio di consegna.
Sono tornato a letto, un nuovo corpo libro mi accompagna. Resisto alla tentazione di solcarlo con i polpastrelli, so che potrei andare avanti a lungo. Lo guardo e basta, approvando la scelta appena fatta. Spengo la luce, ma nel farlo allungo la mano e sfioro con dolcezza la copertina. Un nuovo testo da leggere. Un nuovo corpo libro da amare. Un nuovo libro a proteggermi.
L’iperrazionalizzazione in questo testo consiste nella resa psicoaccademica di una manifestazione polisemica della libido. Pulsione consumistica, feticistica e di accumulazione: in Elementi si mette a nudo il rapporto libidico con le merci. Si sviluppa in maniera chiara e decisa anche il rapporto carnale tra lettore e corpo-libro, una passione che ha del romanticismo, persino nella nevrotica fissazione della “cura”. Nel testo questo rapporto con il corpo-libro si presenta al contempo come un mea culpa e un autocompiacimento provocatorio. Questo perché l’atteggiamento autobiografico e di accademica sincerità la fanno da padrone, nella misura in cui tutto sembra essere oramai un ultimo testamento su quest’endemia dichiarata.
Si parte dalla notte e si finisce nuovamente a letto, con un nuovo libro a proteggerci: quello che ci viene suggerito – provando a farne una lettura più che semplificatoria – pare essere in sostanza il carattere affettivo del libro. Il corpo-libro come madre, la sua verginità e pulizia preadolescenziali come il suo ordine e la sua pulizia a rassicurare, la sua quantità, massa indefinita ad avvolgere il corpo-lettore, fino a farlo sprofondare in un altro universo. Quanta ingenuità e sincerità in un corpus così estremamente razionale, sia nel suo contenuto che nella sua forma.