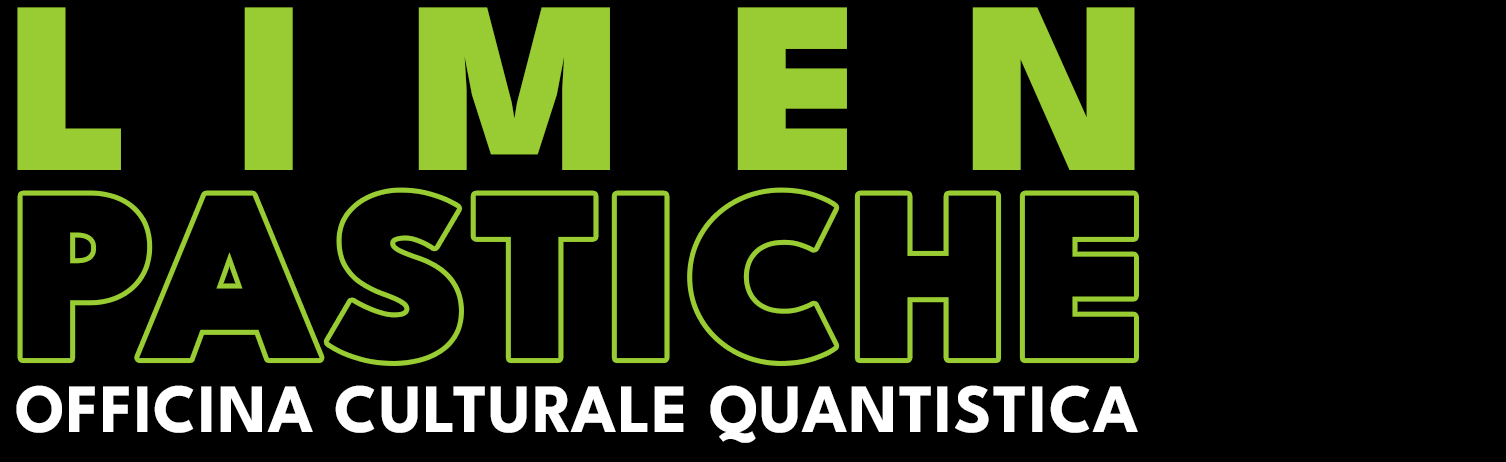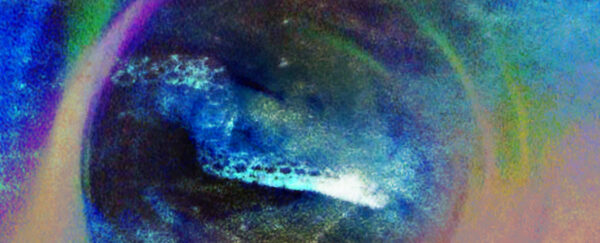Testi di
Andrea Ferraiuolo
Editing di
Odissea Di Bernardo
Categoria
Narrazioni rotte
Data di pubblicazione
18 Maggio 2023
In questo racconto l’autore ce l’ha con se stesso
Sensazione d’arsura, a morte. Frammento di una poesia [Giungla]:
L’unico agguato l’unica minaccia come
appesa a un vuoto, come lo sfatto emergere
di un’alba nuvolosa a una maligna febbre.
Una grande minaccia, come una febbre maligna o un’alba nuvolosa. Il tramonto è nero quando m’assale la febbre a trentanove. È difficile addormentarsi, ma la mattina tutto è a posto, sono solo un po’ sudaticcio. Dovevo andare a quel colloquio alla televisione. Ci posso ancora andare. Ma ho febbre a trentanove da tre giorni. Non ho avvisato, quanto potranno ancora aspettare? due, tre, quattro giorni? E io quanto ancora potrò aspettare prima di rinunciare? Non è mai cosa facile.
Perché non torni? Perché non vieni da me, eh? Sarà facile. Sarà facile, sarà. Sarà facile. Sono convinto che non è un caso ch’io abbia la febbre, questa febbre assai maligna. Avrò pur bisogno di cure. Beh, vieni, su, cosa aspetti? T’aspetterò.
Ho sonno, terribilmente sonno. Non riesco a decidere il da farsi.
Mi dico: benissimo! accettiamo questo umile lavoro da assistente, guadagniamo qualche gruzzolo e poi fanculo a tutti AH! me ne vado per i fatti miei a produrmi le mie cose con i miei soldi. Me ne vado via da questa catapecchia, sgomberate pure la mia camera, bruciate le lenzuola del letto, gettate via i vestiti, fate a pezzi la cucina, il cesso.
Ma: chi l’ha detto che riuscirò a svincolarmi? Chi dice che i debiti si esauriranno? Già, ho un debito con la banca di diecimila euro. Sì, debbo dei soldi anche a quell’altra, che incolpa sempre me della morte del bambino. Sì, ho mia mamma, mio padre, mio zio, che mi pressano per questo posto alla televisione, temono che la gente possa pensare che ho fatto una finaccia. Cosa?
E io rispondo loro con grandi discorsi. Mi rifugio nei grandi giri di parole. Altezzosi, sfrontati, insolenti, presuntuosi, sfacciati, sfrontati, spudorati, altezzosi, impertinenti, impudenti, sfrontati.
Piccola donna incinta che mi hai abbandonato, nel tuo grembo, nella tua piccola e sporca fica, vorrei riposare dolcemente. Io non andavo a puttane, no. Non andavo a puttane! Depravato io?
Mi chiedo se c’è qualcuno che non sia depravato.
[È caldo]
Vige in me un blocco. Irrefrenabile desiderio di morte. Cos’è la stima di sé?
No, no, per carità, è impossibile continuare a vivere senza ripetersi “io appartengo alla cazzo di élite”, “io sono uno dell’élite, ho le giuste carte” e così via. Ora vorrei esser sbronzo. Farò quel che devo, come si dice, il giusto percorso, la gavetta, ecco, e poi, insomma.
[Sera]
La febbre sale. Abbandono. Al computer è un’e‑mail che illumina la stanza, dallo schermo bianco. Bianca come l’illuminazione divina. Accende la mia mente: una notifica verde-azzurrognola, il fastidioso e invadente suono che l’accompagna penetrano la mia mente. Mi domando se non siano loro. Sensazione d’angoscia. È un rifiuto che non potrò rifiutare (la sensazione è simile a quella che percepii al rifiuto di Lucrezia; rifiuto irrifiutabile, inassimilabile, che rimane sullo stomaco, a pezzi, mi sentii a pezzi). Ma d’altronde come puoi rifiutarti al rifiuto quando sei tu il rifiuto? Quando sei un inetto senza speranze buono a nulla. Accendo sigaretta. Guardo portafoglio. Pochi spicci, ma conservo orgogliosamente quei trecentocinquanta euro nel cassetto dell’armadio. Un mese.
Il mio collo dovrebbe torcersi da un momento all’altro, so che sta per farlo, è lì lì per scattare, divorato dalla curiosità. Eccolo!
Dunque… rete televisiva (RTV)… gentilissimo… sì, siamo sinceramente dispiaciuti dalla notizia della sua malattia… sì, sì… sua madre ci ha informati (mia madre? Mamma?! Hai capito che non mi sarei sbrigato a contattare io loro, per questo l’hai fatto tu?) perciò… rinviamo il nostro incontro a quando starà meglio… nel frattempo si riposi… sì, sì… cordiali saluti. Rinviato. Rinviato. Rinviato. Rinviato. Ancora una volta rinviato. Rinviato. Rinviato. Rinviato.
Come ti sei permessa mamma? Chi cazzo te l’ha chiesto, voglio dire? Ora dovrò gestirmi questa situazione che s’è impelagata in qualcosa di ancor più imbarazzante; ora dovrò rispondere, dignitosamente, alle accuse che mi sono state fatte. Perché sì, sono stato accusato (in forma astutamente velata, si capisce) d’essermi in verità inventato tutto, d’essermi ammalato per gioco, così, per noia, ma per carità! Con quale altezzoso disprezzo mi sono state rivolte certe parole! Io da questo letto non alzerò mai il culo! Un demone si è infilato nelle mie mutande, si è posato dietro e non vuole sentirne di spostarsi. E io darò retta a lui. Saremo una grande coppia! Puoi fare di me ciò che vuoi, demone del culo, gli ho detto io.
Lista delle cose da fare:
- comprare dei fiori per Lucrezia (l’amore non s’abbandona mai, soprattutto quand’è lui che abbandona te)
- comprare scatoletta di tonno e confezione uova
- continuare a scrivere quei quattro versi, magari è la volta buona
- riflettere sulla mia situazione precaria e assolutamente folle per cercare di smetterla di addossarmi ogni colpa e al contempo deresponsabilizzarmi da tutto (ignavo)
- sborrare
- continuare a leggere quei Succubi e Supplizi di Artaud, anche se, si sa, è un libro che nemmeno l’autore ha mai letto da cima a fondo
- mangiare
- riflettere su come rispondere alla mail…
- sborrare
- dormire
Vengo subito. Arrivo. Sto arrivando. Ho perso il treno. Chiamo taxi. Perso il taxi. Chiamo ma nessuno risponde. In verità ho il telefono scarico. In verità sono a casa. In verità ho paura. In verità sono solo. In verità mi uccido. A camminare lungo i bordi ci vuol poco. Il più è guardare giù, in fondo.
Mentre aspetto te
lo spazio, lo spazio è inconcepibile
fuori non c’è niente
assolutamente niente.
Un bianco ospedaliero si forma nella mia mente. È vero che si è attratti dal vuoto?
La tentazione di concedersi qualcosa di
inafferrabile
la tentazione di un capriccio,
un capriccio.
Quale misteriosa e angosciante diavoleria che è l’amore! Abbandonarsi è un capriccio? Lo è mai stato veramente? O è soltanto un arrendersi inermi al proprio destino, sconfitti con pena, come vermi calpestati dal piede di un bambino ingenuamente cattivo? Io sono stato quel verme.
Dove ho trovato
questo mare di chiodi giunchi?
E cos’è dunque questo spazio?
C’è uno spazio immenso che mi circonda. Un deserto di solitudine. Per arrivare là dove c’eri tu e il nostro futuro mi è parso improvvisamente che avrei dovuto affrontare migliaia e migliaia d’infiniti chilometri. Semplicemente ho preferito camminare. Ma sai com’è, per percorrerne d’infiniti chilometri ci si mettono degli anni. Io chissà quando arriverò. Dovrei correre? Chi corre nella vita? Corrono solo i più fortunati, coloro che hanno soldi e amore, o almeno una delle due. Ma io, di questa insulsa querelle, non ne voglio sapere più niente!
Mentre aspetto te
è inconcepibile.
Il mondo nella sua stanza
attraversa un soffio che spegne
ogni candela.
Cosa mi inquieta? Da dove proviene quest’ansia insopportabile? Mi lamento e mi lamento e mi lamento e mi lamento e mi lamento e mi lamento e mi lamento e mi lamento e mi lamento e mi lamento e mi lamento e mi lamento e mi lamento e mi lamento e mi lamento e mi lamento e mi lamento e mi lamento e mi lamento e mi lamento e mi lamento e mi la men to emi la me nto lam en to emil a mento e mila m en to…
Oh mia cara, oh mia cara, io ora qui posso solo ricordare la tua mano posarsi sulla mia spalla. Quanto vuoto ci aspettava, quanto silenzio, io odio il silenzio, finisco a parlare da solo per questo se non c’è nessuno. Quanta assenza. Ricordo quella volta che uscii dall’aula dell’università (la mia prima lezione): dimenticai la giacca dentro ma era tanta la vergogna che non ebbi il coraggio di rientrare, sperai che l’avrei ritrovata il giorno dopo, magari qualcuno… Come hai potuto allora pensare che uno come me avesse il coraggio di avere un figlio, un bambino, una creatura nata per mano mia? Tanto meglio che sia morto! Tutte quelle smancerie, quella lingua – comprensibile apparentemente – quelle cerimonie, doveri a cui ci si deve attenere; mai che dimostrassi di sentirmi – come realmente era – fuori luogo, a disagio, se almeno avessi smesso di fingere per un giorno avrei confortato di più me stesso. Per carità Lucrezia! non è colpa tua, sia chiaro.
Devo dire che quello sguardo mi intimidiva. La mia faccia turpe e meschina. Lei mi accolse nel letto stanca. “Devo esser debole” dissi soltanto. “Non sentirti in colpa. Hai fatto più che potevi”. La pioggia batteva sul finestrone che affacciava sull’intera città. Era come se penetrasse il vetro e mi precipitasse addosso. La stanza era vuota, bianca, rifletteva il nostro stato d’animo. “Non si può continuare a vivere così”, pensai, ma non lo riuscii a dire.
Due giorni dopo l’andai a prendere. Arrivati a casa ci sdraiammo sul letto. Dormimmo. Poi lei si svegliò. Sentivo una mano carezzarmi il collo e scendere per il petto. Aprii gli occhi e vidi le sue labbra aperte avvolgere il mio pisello. Mi piaceva sempre osservare la fossetta causata dal vuoto che si crea all’interno della bocca quando si pratica la fellatio. L’impegno che c’è dietro. Era dolce il suo volto. La testa si abbassava lentamente in giù e lentamente s’alzava, ancora s’abbassava e poi si alzava. Continuava così, con passione. Io timorosamente le posavo la mano sul capo. La carezzavo. Poi, quando pensai (e forse, ancor più, volli) che avrebbe concluso l’affare in quel modo, lo prese e se lo portò dentro con violenza. Io la lasciai fare. Pareva che sentisse il bisogno di scopare più che mai. E questo non l’avrei detto, visto com’era la situazione. Eppure Lucrezia urlava, Lucrezia si dimenava, Lucrezia graffiava, cavalcava, stringeva, piangeva (sì, cominciò anche a piangere) ma quando capii ch’ella voleva riprovarci, come per una questione di principio, anzi di orgoglio, come dovesse necessariamente rimediare ad un errore fatto, subito lo estrassi da lei e sporcai le lenzuola in pizzo.
Domandami pure perché? perché? perché? Non te lo dirò mai. Non ti dirò mai che in verità t’ho amata, che in verità sono un fallimento. L’importante è averlo capito. Ed è doloroso pensarlo, ma devo dirti un segreto: ho gioito della sua morte. Ho gioito. Ci mancava poco che andassi al bar a festeggiare ubriacandomi. Ma poco prima c’è mancato tanto così che m’ammazzassi…
Quest’uomo è un vigliacco, della peggior specie. Questa carogna non è altro che un’insensibile.
Abbandonatemi qui
come un cagnaccio
perso
in un mare
di chiodi giunchi.
E poi cominciammo a parlare.
“Vedi tesoro, io proprio non sono in grado. È che proprio non si può…”
“Ma no, non capisci, è che proprio non si può, non è che non voglio, è che non riesco”. “Allora vattene! Avresti potuto dirlo prima, e invece…!”
“Zitta, zitta, ti prego! Non si vede nemmeno più la sottilissima linea rossa!”
E le mostravo il termometro.
“Adesso basta, basta! Ammazzati, ti odio! Ti odio da morire!”
Ma non morii.
È raffreddore? No, è sangue dal naso. Ero al mercatino. Vendere qualcosa. Una tastiera elettrica con sgabello annesso. Un anello rosso, importante, di famiglia. Un pennino giapponese speciale, con il quale si possono scrivere lettere sottili come un filo. Libri, libri, libri. Qualche CD, qualche DVD. Il signore si mise a ridere: “Ora mi scusi, ma devo proprio andare”
“Aspetti…” dissi con voce talmente flebile che neanche le mie orecchie sentirono. Per fortuna una vecchietta accanto a me mi chiese di quell’anello. Riuscii a venderlo per un centinaio d’euro. Non pensavo avrei racimolato così poco.
[Non sa camminare. Riempie le strade con i suoi enormi piedi e braccia. Non avendo agilità, non sa districarsi, non sa spostarsi. Urta con gli ostacoli goffamente].
[La donna]
Non esiste. Ci sono femmine madri e madri femmine. La donna è solo madre.
Madre maligna. Madre padrona.
La donna pensa solamente a fare figli e, al massimo, a scopare. Tutto ciò che viene prima, cioè l’amore, il trattamento, l’intessitura del rapporto con l’altra persona è una mera ed egoistica preparazione al parto, alla nascita.
Egoiste e ciniche, le donne sorridono, alludono, ammiccano quando son giovani; si lamentano, strillano, scalpitano, ma imparano tuttavia ad amare, quando son vecchie.
Volgarità del linguaggio. Bestemmie.
Ma recarsi in chiesa non fa mai male, di tanto in tanto…
Ascoltando con serenità della musica a gran volume e [lui] scordando che effettivamente c’era qualcosa di urgente da sbrigare. Ma cosa? Cosa…?
Era forse la salute della madre a preoccupare? O le numerose chiamate perse dallo zio, che cercava sicuramente il nipote per parlare di qualcosa.
Ma per la mamma non v’era da preoccuparsi. Aveva avuto solo un leggero mancamento.
[Baudelaire, seppur qui piuttosto autobiografico, trovo che si addica molto]
La salute è nell’attimo favorevole. La salute è il denaro, la gloria, la sicurezza, la rimozione del Consiglio Giudiziario, la vita di Jeanne.
Questo pensavo. E la mamma aveva almeno due elementi favorevoli su quattro (non considerando la fin troppo specifica vita di Jeanne).
Lo zio è invece un egoista spilorcio che s’atteggia da borghese. Non tira fuori mai una lira.
Voglio diecimila euro. Voglio diecimila fiori. Voglio diecimila poesie. Scritte ora: raptus.
Ma ascoltando la musica, pensando a questo e scrivendo seriamente qualche verso, si finisce per dimenticare i pensieri più profondi e rimane solamente un inspiegabile stato d’angoscia.
Giorno della malattia. Mamma all’ospedale. Dormo. Chiama lo zio, scrive un messaggio, nessuna risposta: dormo. Con che faccia dovrei presentarmi lì? E poi perché sempre quell’ospedale, lo stesso.
Simbolo di morte. Avvertimento.
Dormo. Devo dormire, ho sonno. Mamma la raggiungerò più tardi, quando non ci sarà mio zio. Ne nascerebbe un inutile litigio, dunque meglio lasciar passare. Odio lo zio, mi ricorda papà. Odio scontrarmi con mio zio, odio quando mio zio si arrabbia inutilmente. Mamma è in salute, l’ho sentita al telefono l’altro giorno, è in salute, per carità! Probabilmente non v’era nemmeno alcuna necessità di portarla lì dov’è.
Oh, zio caro, Vi ringrazio per il filantropico aiuto che state dando alla nostra famiglia da anni, alla quale Voi siete fortunosamente legato. Io Vi sarò per sempre infinitamente grato. Questo de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-denaro che Voi ci consegnate è per noi preziosissimo e io prometto a Voi che Vi farò contento, così come farò felice la mamma, trovandomi un lavoro rispettabile e, perché no, generoso, fottendomene e strafottendomene di ciò che in verità vorrei fare, di ciò che in verità sono le mie tendenze, di ciò che amo.
Ho bisogno di denaro…
Ho un debito con… mi han detto: “Perché non lascia perdere? Dopotutto non ha mai guadagnato un euro con le sue opere. Forse non è mestiere che fa per lei”. Forse dovrei partire per l’Australia. Ho sentito dire che si trova facilmente lavoro lì. E poi mi farà bene cambiare aria, qui è tutto così inquinato. È il mio cuore la città più inquinata.
E magari lì potrei continuare a scrivere, se non me ne vergognassi. Sento di avere il talento. Devo sentirlo, altrimenti da dove tirerò fuori la mia bravura, il mio coraggio? Cos’è la stima di sé? Stima di sé. Devo urlare: “Io appartengo all’élite!”. Nel deserto di solitudine. Non ci sarà nessuno ad ascoltare, leggere, vedere le mie opere. Perché sono un buono a nulla.
Prendo il computer. Basta. risponderò alla mail, fanculo la spesa, la masturbazione giornaliera e la cena. Prendo. Non va internet.
Dunque
per il povero
entoemilam
isolato
e costretto
a vivere senza
![]()
internet
non c’è più speranza
per il povero
toemilamen
non rimane
che
la
![]()
Spegni il computer. Magari domani andrà. Magari domani ripareranno il guasto, dev’esser colpa loro, non mia. Deve dipendere da qualcuno o qualcosa che sta al di sopra di me, che mi costringe a rimanere nell’attesa, ad aspettare, a sperare, a dilatarmi, ad addormentarmi. Se penso a quanto sia tutto così grande, così infinitamente grande rispetto a me. E non parlo di cosmi, ma del pianeta Terra. Del mio paese. Della mia città. Della mia casa. Della mia camera. Dormi. Dormi. Neanche ceno. Neanche mi masturbo.
Non c’è più sesso nella mia vita.
Non c’è più fame.
***
[N.d.A.]
Non posso più permettermi d’ascoltare certe idiozie, devo perciò intervenire. Tu non sei una persona, sei un coglione. Un pezzo di idiota, una merda umana, un parassita, uno scarafaggio, un pezzente, uno sfigato, un cialtrone, un inetto, un maldestro, un imbecille, un deficiente, un ladro, un truffatore, uno screanzato, un ebete, un demente, un idiota, un bastardello, uno scemo, uno sciocco, un rimbambito, uno stupido, uno stupido, uno stupido, uno stupido, uno stupido, uno stupido, uno stupido.
Come puoi pensare di diventare ciò che vuoi diventare restando in casa nel letto a dormire? E questo, bada, non vuole essere uno di quegli stupidi e moraleggianti discorsi. Perché, caro mio, tu sei un buono a nulla? perché ti lasci indurre a passi inutili, ti lasci sprofondare nel silenzio profondo della tua tomba, insomma perché non riesci a sopprimere quella che è soltanto un’ombra pesante.
Quello che ti servirebbe, si capisce, è un po’ d’aria, caro mio. Forse, perché no? un bel giretto in montagna. Come scriveva Kafka: “una gita in compagnia di nessuno”. Camminare fra gli ostacoli naturali, composti di rametti addossati, pietre, massi, salite, discese… Da solo, capiresti molte cose.
Amico mio, amico mio. Questa tua febbre è la tua infelicità. Ammazzati piuttosto. Saresti più felice.
Ma non farlo, non ha senso. Non ora.
È vero anche che c’è da dire: chi sono io per dirti questo, caro mio. Quando si guarda indietro al proprio passato, ci si accorge di aver vissuto un circo, uno spettacolo a buon mercato. Questa è la tua vita, così è stata la mia. Eppure mi par questo l’unico modo per rendere oggettivi dei ricordi, essenzialmente per liberare se stessi dalle pesanti catene della finzione. Il passato intero è una finzione! La storia è una finzione! E tu sei ed eri un buono a nulla. Un pezzo di idiota, una merda umana, un parassita, uno scarafaggio, un pezzente.
Trova una fronte su cui battere la mano. Ammetti che questo corpo e questa testa sono reali. Che tu non sei un simulacro o cos’altro. Ammetti di esser sprofondato in un baratro bastardo; forse qualcuno avrà la compassione di te? Ma fatti fottere! Non mi sembra il caso di “aspettare”, di “sperare”. Lascia perdere questi due atteggiamenti di fede, lasciali ai cristiani.
Parli tanto di tua madre e di tuo zio. Ma sai com’è finita? Sì che lo sai, mi par ovvio. Certo, non sarà colpa tua, ma cosa costava, dico io, recarsi in ospedale anche solo un giorno, un minuto. Lo so io cosa ti costava: alzare il culo dal letto, dalla tua bara sporca di sperma e capelli. Che schifo! Il problema era prendere una decisione all’istante, fare una scelta che comportasse un cambiamento di direzione delle seguenti ore, delle seguenti giornate. A te non piaceva l’angusta idea dell’esistenza del caso, della causalità. Dall’altra parte non potevi, non puoi, neanche permetterti di lasciarti trasportare dagli eventi senza prendere delle decisioni.
Tuo zio invece… su tuo zio siamo ancora d’accordo, è uno spregevole cinico in vesti borghesi. Ma tu, brutta merda, non pensare a lui, anzi proprio per lui tu devi alzarti e darti da fare, proprio per dimostrare a quella copia mal riuscita di tuo padre che sei migliore di quanto crede.
Primavera. In piedi sul tram osservi la luce del sole declinare sul volto di quella donna. Che somiglia assai a tua moglie. Che somiglia assai a tua madre. Guardi il cielo: è di un limpido! Non te ne capaciti, ieri fu così grigio. Cosa farò in questi ultimi giorni di primavera – pensi – che rapidi se ne vanno? Rimani sorpreso dell’andatura di quella donna. È così simile a lei. Ecco un’altra somiglianza! Va a prendere suo figlio a scuola. È un infante molto allegro; inclina la testa sorridendo, tende il braccio verso la madre e le stringe forte forte la mano. Perché non ho un figlio? pensi.
Perché sono sempre stato così indeciso?
La qualità dell’aria è peggiorata. Camminando, il ritmo dei tuoi passi pesanti crea un irritante rumore – tu sei irritante nella tua miseria.
Quando entri in casa hai qualche pensiero, ma nulla di che, figuriamoci. Eppure c’è sempre qualcosa, un pensiero, un sentimento, che ti turba, anche solo per cinque secondi, per quei cinque secondi che entri in camera, la vedi vuota, vacua, bianca come un ospedale. Un’angoscia repentina ti fulmina sulla soglia e poi scompare appena varcata.
È poi nel letto, la notte, che quel turbamento ti assale nuovamente. Eh, lo so, è un demonio. Non ti fa dormire. È come se costantemente ci fosse qualcosa che sai che devi fare, ma che ti sei dimenticato. Ah, era quel messaggio a cui dovevo rispondere, forse? Ah, era probabilmente quella telefonata che non ho più fatto? Senz’altro sarà la bolletta che non ho ancora pagato.
No.
E dopo aver risolto ogni dubbio spostando le soluzioni al domani, dormi sogni più o meno tranquilli. Dico più o meno poiché è norma svegliarsi la notte. Ci si sposta e risposta nelle coperte (sudati in quanto la febbre sale!), non ti dai pace, non ti quieti, finisci per addormentarti solo per esaurimento delle forze cognitive. Forse non dormi non per la febbre, non per il caldo, non per la fine della primavera ma perché è ancora vivo in te il pensiero riguardante quell’angoscia che ti fulminò sulla soglia di camera tua. La tua camera. Il luogo più sicuro del mondo, espugnato da un lampo inspiegabilmente illogico. Che pena.
La qualità dell’aria è peggiorata.
Tossisci, starnutisci, hai la gola secca e ti dimeni. Sembri un maiale malato. Che scena pietosa
Che pena.
Ebbene, che dire dei tuoi dolci versi? Malinconici quanto basta per far impietosire una donna, li scrivi soltanto per loro.
Non sono qui a dirti “fatti forza!”. Sarei ipocrita. Chi dice questo non ha abbastanza paura e cioè non conosce quanto basta della vita per aver veramente paura.
[La donna, che ama chiamare «madame» per una stupida e ridicola fissazione con la letteratura romantica francese]
“Amami Madame, amami nel rancore del tuo lenzuolo ospedaliero. Non avercela con me Madame, amami! Soffro profondamente delle volte, più di quanto sia permesso ad un uomo. Non vorresti vedere un uomo soffrire a morte… Ma io, io sono morto, sono morto. Sono morto per te. Madame, lo sapevi? Sapevi che non ti avevo abbandonata veramente? Sapevi che è stato solo un naturale gesto di paura, un passo indietro, un errore fatale? I cani così fanno, s’arrendono quando sanno di non potercela fare, altrimenti morirebbero all’alba. Lo sapevi? Lo sapevi…? Scompaio nella saliva della notte, scompaio. Mangiato, deglutito. Amami, Madame. Non sono più un uomo”.
“Dici di non esser più un uomo e hai ragione. Il guaio è che non lo sei mai stato. Il guaio più serio è che di questo non me ne sono mai accorta. Sono stata cieca e perciò ho subito la condanna. La morte di nostro figlio è stata colpa mia. Dici di amarmi, ma hai torto. È così evidente. Se mi amassi non lo diresti lontano nello spazio, lontano nella mente, lontano nel tempo. Se mi amassi moriresti e basta. Tu dimentichi di star scivolando in un oscuro e profondo pozzo. Io non voglio finire deglutita dalla notte con te”.
“Madame tu hai ragione. Se io t’amassi (e io t’amo) effettivamente te lo direi vicino nello spazio, unito con la mente, te l’avrei dovuto dire in passato così come te lo sto dicendo adesso. Ma tu cara mia dimentichi che io non ho mai chiesto a te una vita da spartirci, non l’ho mai cercata. Tu sei stata a volerlo di nascosto e la morte ti sei meritata per questo. Non è misoginia, Madame, non è nemmeno misantropia, ma soltanto buon senso. Quando mai hai preso in considerazione ciò che dicevo, volevo, facevo?”
“Sì, forse abbiamo entrambi ragione e perciò sarà meglio continuare ognuno per la propria strada.
E non chiamarmi più Madame.”
Questo dicono i tuoi versi e questo mi pare di sentire come risposta ogni qual volta li rileggo. Un odio sconfortante. Uno sputo in faccia.
I. ABBOZZI SULLA VITA QUOTIDIANA DI UN CIALTRONE
Mercatini. Libri di storia classica: ne è attratto: mediocre. Non presta attenzione alla modernità e al futuro. L’atteggiamento malconcio, ovvero la schiena ricurva, la puzza delle ascelle e i calzini bucati allontanano le persone attorno a lui, con un atteggiamento più moderno dall’impostata pulizia e cura di sé.
Sempre mercatini. È alla ricerca di qualcosa di vecchio, ma non sa cosa e non sa perché. io forse il perché lo so. Perché il vecchio conforta in quanto c’è già stato, è passato. Un oggetto vecchio è confortante perché è stato già usato da qualcuno e non è più vergine. Dunque lui non dovrà addossarsi la responsabilità di sverginare quell’oggetto: c’è da star tranquilli!
Note sul dialogo avvenuto con la madre in data 7 ottobre.
Lei chiede lui come sta.
Lui: bene e tu?
Bene, dice, ma non mi dici niente? Il lavoro come procede? O meglio, hai fatto domanda per il colloquio?
Lui dice che ancora non ha inviato la mail ma che la tiene già pronta da giorni. È confuso nel dire cosa attenda ancora precisamente.
Lei consiglia severamente lui di prendere una decisione in fretta.
Lui sostiene d’aver già deciso da tempo (pare sincero).
Lei le chiede cosa, dunque (pare non esserle chiaro).
Lui adirato dice che ovviamente ha deciso di sostenere il colloquio.
Lei: non è ovvio.
Buoni propositi (su uno straccio di foglio bianco)
-Scrivi mail
-Tutti i giorni 5 poesie e qualcos’altro
-Compra frutta e verdura (meno carne; magari chissà, si potrà diventare veg.)
-Ricerca denaro
-MAMMA?
Quando la notte sembra essere sul punto di svegliarsi, ecco che caccia un grido fortissimo, tanto per sentirsi gridare. Allora tutto nel suo cervello scoppia e sprofonda interamente. Satana si diverte a giocare con la sua sessualità. Gli vengono delle idee meravigliose che gli rifila però smorzatamente.
Non dovrebbe spaventarsi poiché è stato lui a decidere di non essere più due (anzi tre).
Ha sentito e poi dimenticato. Ha preso un rotolo di carta igienica in mano. Non conta ciò che ha preso ma conta il fatto di aver preso. In due quel rotolo andrebbe diviso. In tre ne ricaverebbe un terzo…
II. BREVE DIALOGO FRA DUE IDIOTI SU LE SCALE MOBILI
“Non sono affatto d’accordo con lei, signore, riguardo questa sua lamentela sulle persone che, alla sinistra, salgono le scale mobili camminando e superando la fila, appunto, immobile. Non è sciocco e nemmeno senza senso, se ci pensa bene. Lei odia loro perché, come ha appena detto, hanno quell’aria di superiorità e di decisa indaffaratezza. Non le va a genio che essi possano aver più fretta di lei, tanto da non voler usufruire del principio primo di quel magnifico e comodissimo servizio di spostamento dei corpi che è la fissità nel movimento, tipico del trasporto sia pubblico che privato e, anzi, essi non solo non usufruiscono con riverenza di quel principio primo loro donatogli, ma addirittura si fanno beffe di tutti noi e dello stato, sfruttando i meccanismi di spostamento per prender maggiore velocità, così da essere più veloci e giungere prima al loro tanto agognato punto d’arrivo.
E invece io le dico che così come io salgo i gradini delle scale “ferme” a due a due, anziché uno per uno, così posso permettermi di camminare le scale mobili, nonostante il loro scopo sia quello di trasportare, se voglio anche due scalini alla volta!”
“Divertente vedere come lei non entri nel merito della questione. Si tratta perlopiù di una questione di principio! Se io mi vedo superare da gente in giacca, cravatta e valigetta (e glielo dice un lavoratore!), con quel loro sguardo supponente e con quel fare trionfale, come se l’aggiungere un moto al moto gli desse quella spinta in più – del tutto individuale, basata insomma sulle proprie forze – verso un al di là degli impegnati, ebbene io, abbia pazienza, mi sento altamente preso in giro! Non vedo, insomma, il senso di dover strafare e andar contro il principio di qualcosa solamente per smania. E perché poi? Perché questa nostra società corre sempre più velocemente e a ritmi alterni. Non ci si capisce più un cazzo!”
“Sa, probabilmente ha anche ragione quando parla di coloro che s’atteggiano trionfalmente perché camminano per delle scale mobili, eppure la mia risposta precedente era entrata eccome nel merito; lo dimostra il fatto che lei mi abbia appena ripetuto all’incirca le medesime questioni sopra dette. Ma gliela ripeterò volentieri. Vede, così come una persona può saltare un gradino salendo a due alla volta – e non mi dica che lei non l’ha mai fatto – o, se preferisce, così come una persona cammina compiendo un passo più lungo del normale o un passo svelto e felpato, così ha la naturale propensione a salire le scale mobili con le proprie gambe”.
“Me ne fotto, dio porco!”
“Si calmi. Lei stesso ha parlato del particolare carattere ascendente delle scale mobili. È vero. La scala ricorda un po’ l’ascensione verso il Paradiso. Stairway to Heaven. Non c’è proprio bisogno di bestemmiare, dunque. Altrimenti andrebbe contro i loro principi e il suo atteggiamento parrebbe altezzoso e trionfale tanto quanto quello della gente per cui s’infiamma”.
III. STORIA D’AMORE FRA ME E LA MANO E IL PIEDE DI MADAME L.
Le parole che utilizzo mi sono state date e perciò le uso, ma non pretendo di farmi capire, voglio solo liberarmene, vuotarmene. Io appunto non le uso ma le butto. Io non farò altro che tacere, per il resto si parleranno da sé. In realtà io non dico mai niente e non faccio mai niente; non uso parole e lettere a volte, ma balbettii e schizzi. Perché? “Perché sei innamorato” diceva L. No, ahimè, non è per quello. Io ho una mia teoria: dev’essere questa febbre maligna. Mi sento toccare la fronte da una mano. Mamma! “No, sciocco, sono io”. La temperatura è molto alta.
1. Mano
Scivolo solerte dalla fronte alla guancia. È calda. Dai, alzati!, lo invito. Vieni pure qui se preferisci.
(È così delicata e affusolata. È così tiepida, senza fine. E scivola dall’apice del cranio.
Il mio è come un vecchio corpo, sepolto. Si sdraia sul proprio letto, che è il suo eterno feretro, con la complicità del cervello, dei sensi. Poi
riesumato da una mano. A presa lenta ma decisa, una mano di donna, fuori dalla caducità: aspetto millenario. Quando sto male voglio che stia con me, quando mangio voglio che stia con me, quando caco voglio che stia con me, quando mi masturbo voglio che stia con me, quando dormo voglio che stia con me, quando muoio voglio che stia con me. Lei,
pregna di tutta l’ancestrale lascivia,
e che quando vuole, appena vuole, può divenire dura come un martello
e pestare. Pestaggio e sborra).
“Fa di me ciò che vuoi” sembra dirmi. Perché mi fissa, perché mi tocca, perché mi bacia. Mi sfiora l’unghia smaltata con le labbra. Sembra fuori di testa. Ma io sono nobile, dignitosa, seria. Non mi infilo in un orifizio, non mi lascio baciare così facilmente, non pensare! Lo so che pensi che invece sia libidinosa. Ma io non sono fatta solo per il sesso!
(Ma che non vede che questo è un formicaio?
Perché non è un comune corpo. Io per lo meno non mi sento più d’appartenere a esso. Sento che l’animo, lo spirito, chiamatelo come preferite, non vi abita più. È solo sesso. Eros. È solo pestaggio e sborra. Mi scivola dall’apice della zona scrotale – perché la notte alle dieci si ritira, eremita – sino in su, su, su sulla pancia, poi nuovamente giù.
Dammi la mano. Questa tua mano è cattiva. Questa tua mano solletica! Il meraviglioso disgusto per l’inferno del primo amore. La mia prima chiavata con una mano! È così bello, sembra un sogno. E poi chissà che sognano le mani? forse il cielo?).
Preparo il caffè. Stanca, mi poso sulla gamba. Riposo. Mi raggiunge mia sorella, si posa su di me. Siamo fiacche, ci coccoliamo a vicenda ma non ne abbiamo le forze e ci lasciamo cadere. Carezzo le braccia, sembra abbiano freddo, sembra abbiano bisogno di me.
Vedo tanta carne tuonante, una cesta zeppa di carne. Ciò che il ginocchio prende di me non è me, ma la mia carne.
(E il corpo è ciò che s’è fatto luogo di questo dolore sconcertante).
[fine, per ora]
Grande attenzione da parte del popolo giapponese è riservata alla pulizia. Basti pensare che per entrare in un appartamento, appena si varca la soglia della porta, bisogna togliersi le scarpe e rimanere con i “calzini” (tabi) oppure definitivamente scalzi. Non si temono sporcizie sotto i piedi… perché non ve ne sono. Le case giapponesi sono pulite e di conseguenza lindi sono i loro piedi. Seppur questa cosa possa infastidire i più inviperiti con il genere del feticismo dei piedi, a me aggrada particolarmente. Aggrada la pulizia, ma certamente non ho la fobia per i germi o cose del genere; sicuramente, però, per ammirare un buon piede, è bene che esso sia pulito.
2. Piede
Prendevo esempio da Masao Shikhoka, maestro, Sempai dell’arte dell’adorazione del piede femminile, vissuto nell’epoca della Restaurazione Meiji. Egli si dedicava finemente alla pulizia della pianta, del collo, delle unghie, alla colorazione con smalto, al trattamento, insomma, estetico del piede sotto ogni aspetto. Ma Shikhoka non era solamente un professionista della pedicure, no. Non si limitava al trattamento, bensì le sue erano vere e proprie lodi liriche ed erotiche!
Io così facevo: ponevo il piede al centro dell’attenzione libidinosa. A chi importava dei seni, del culo o della fica! Io m’occupavo esclusivamente, così come il Maestro, delle «fette»! Divenne mia premura, poco dopo il matrimonio, cominciare con la pulizia del piede nella sua interezza.
Lavaggio della pianta.
Lavaggio del tallone.
Lavaggio della caviglia
Lavaggio del collo. Poi: minuzioso lavaggio delle dita e dell’infradita.
Poi (onestamente, uno dei miei passaggi preferiti): smalto sulle unghie!
Madame L. inizialmente accettava passivamente le mie attenzioni. Cominciò a sembrarle una cosa strana man mano che prese una certa confidenza sessuale sia con me che, soprattutto, con se stessa. “Mi pare una cosa da matti! Da pervertiti!” diceva. E come non darle torto. Ebbene, lo era; era sì qualcosa di perverso, di depravato… e allora? Io così le rispondevo ma – nonostante all’inizio accettasse di mal grado – ella cominciò a rifiutarsi disgustata.
Impossibile!
Era la tentazione a me inviata dal Maestro
di passare il soffio del mio cuore tentato fra le vene scalze.
Il negarmi questo mi faceva impazzire. E il suo divieto divenne man mano sempre più assoluto e radicale. Mi venne impedito anzitutto la pulizia, poi l’annusamento (come a me piaceva definirlo), poi la colorazione – che ella ritenne fino a tardi qualcosa di, nonostante tutto, funzionale – e poi tutto ciò che, nell’atto sessuale, mi suggeriva la mia mente libidinosa e lo spirito in me sepolto del Sempai Shikhoka.
Finì soltanto per rimanermi la sofferente ammirazione che un poeta può avere per la sua Silvia, o la sua Beatrice. Per me, Silvia era il piede di Madame L.
“Occupati piuttosto delle mie poppe!” amava dire lei per provocarmi. Che sciocca! Non mi accontenterò di due semplici palloni, già in fase calante, quando potrei puntare alla luna! Certo, quando dicevo questo, non mi veniva di certo consentito anche solo di sfiorare la sua “luna”, e così – brutta, bruttissima abitudine che cominciò a prendere – s’infilava due calzini, ma non semplici e aderenti, bensì due tabi! Capite? oltre il danno, anche la beffa! Impazzivo.
Ora le strade da intraprendere rimanevano soltanto le seguenti:
- Compiere un grandioso atto d’erudizione, tale da far commuovere Masao Shikhoka tra i fili d’erba dove si trova, spiegando per filo e per segno le mie motivazioni psico-erotiche sul perché è bene l’arte dell’adorazione del piede;
- Dedicarmi all’arte della poesia del piede;
- Morte.
E siccome la prima mi fu rifiutata sin dal principio, fui costretto ad intraprendere la seconda via, sia per mia curiosità, sia per, sinceramente parlando, mia inettitudine nel morire per tali motivi (cosa direbbe di me il Maestro!).
Dunque scrissi.
[poesia sul piede di Madame L.]
Ecco: si rovescia nell’avorio la mia angoscia,
appena varcata la soglia
diventa meravigliosamente minuscola
una donna alta come alberi,
fragile e altrettanto libera:
quanto vi ebbi a lungo in testa…!
Riempirono i miei giorni d’estate;
il contatto con la terra…
l’odore di fragole seminato tra il fogliame
e il tatto, cosciente di ogni sua malizia.
Stàncati la sera nella coperta,
sollèvati bruciacchiante a fiore rosa
quando ottobre s’inoltra,
passeggiando nella mia mente.
Il respiro dei tuoi piedi è lo scorrere del mio tempo.
Quando il corpo scompare allora
ne scorgi le radici mentre scioglie quel tuo
quel loro movimento che richiama i sensi
e che affiora nell’inquieto desiderio.
E più ti pare di conoscere
il mistero che tu ami, più improvvisamente
vola via. Questo qualcosa di inafferrabile
buttato su di me come sporco spirito
sono costretto a picchiarlo, a distruggerlo.
D’ogni cosa si svuota il senso,
in transito,
dove dimora il vuoto
dov’è turbato il mio cuore.
Questi, i tuoi appunti, abbozzi, rigurgiti letterari – chiamali come vuoi – mai finiti, mai portati a termine sino in fondo. Tu, che ti lamenti di non ricevere approvazioni, lodi, ringraziamenti, apprezzamenti, allo stesso tempo quasi denigri la tua stessa intelligenza rinunciando già la sera alle opere che cominci la mattina, senza dar loro una seconda possibilità – che è quella che tu tanto richiedi al mondo. Tu, che vorresti sentirti realizzato, non fai altro che auto-sabotarti in qualsiasi cosa, a cominciare dall’alzarsi dal letto fino al compimento di un progetto finalmente serio.
Inetto! Cialtrone! Come potrebbe qualcuno fidarsi di te, come potrebbe qualcuno affidarsi a un tale vomito?
D’altronde un fesso come te non poteva che indebitarsi fino al collo con quei quattro spicci che ha in tasca.
Banca 2.000, Zio 1.000, Mamma 800, Lucrezia 200. Lavorare dalle 6 del mattino fino a mezzanotte, a digiuno dai piaceri, a digiuno dall’ozio.
Tutto si può riparare. C’è ancora tempo. Chissà se anche per i nuovi piaceri? …
Pagamento dei debiti. Lavoro immediato, anche cattivo, è meglio della fantasticheria… Non sognare, non pregare; non ti serve. Nelle ore notturne mettersi a scrivere; contemporaneamente alla fatica, proseguire con i propri progetti, non lasciarli morire, non seppellirli.
È un buon proposito partire dallo scrivere qualsiasi cosa venga in mente, seguendo l’ispirazione del momento. Tutto andrà bene, purché sia vero.
Quel progetto che hai abbandonato: riprendilo in mano. Lo zio ci tiene tanto che tu conosca il direttore dell’emittente televisiva: ti sarà utile, prima o poi.
L’e.t. non sarà il luogo della tua guarigione progressiva, ma sarà il luogo che ti porterà ad essa.
La salute è nell’attimo favorevole. La salute è il denaro, la gloria, la sicurezza.
Perché qui non si parla della malattia dell’autore. La tua non è di quelle malattie che l’artista, irritato di fronte alle evidenze della vita, crede d’avere perché la società ha sempre avuto più di un mezzo per farglielo credere. Tu non sei un poeta.
Alla fine, facendo uno sforzo e qualche calcolo, si giunge alla consapevolezza di non esserlo mai stati. E non eri forse tu, minuscolo insetto, a non averlo mai voluto essere? E non eri forse tu che di fatto fondamentalmente ti trattenevi perché pensavi che nella vita esistono cose ben peggiori dell’essersi trattenuti fuori dal tempo e dallo spazio come in un sogno nella tela di un ragno?
Devo fare in modo che tu cambi idea su te stesso. Ho il dovere morale di trasformarti nella miglior forma tua.
***
(Entrata dell’autore negli appunti del suo personaggio, davanti al quale corre una linea dell’orizzonte tratteggiata sopra il rosso e il verde, forme tondeggianti e scheletri di collinette, segnali di pericolo. Cielo nero che rende impossibile la visuale oltre i cinque o forse quattro metri. Rari lampi di luce gettano deboli abbagli attorno alle barche in legno fissate con la corda al molo. Dietro, rotaie abbandonate finiscono su di una schiera di casette fuligginose con le porte spalancate. È vicina ormai l’imbarcazione che tra notte e nebbia ha varcato la soglia dell’invisibile per entrare in quella del visibile. Lui, come un idiota, è rimasto a bocca aperta).
AUTORE
“Dove stai andando?”
PERSONAGGIO
“Faccio un giro”.
AUTORE
“Vieni con me”.
PERSONAGGIO
“Così dunque con l’imputazione d’essere un poeta vengo martirizzato? …”
AUTORE
“Al contrario. È bene che tu veda il fondo a cui appartieni”.
PERSONAGGIO
“Il poeta vive nel fondo”.
AUTORE
“Parliamo di due fondali diversi”.
PERSONAGGIO
“Sembri conoscere questo fondale. Si tratta dello stesso a cui io appartengo?”
AUTORE
“Si tratta dello stesso fondale, sì”.
PERSONAGGIO
“E allora spiegami direttamente di cosa si tratta senza mostrarmelo. Parlamene ma non portarmici. Perché farmi vivere sulla pelle dolori di cui potrei fare a meno, soltanto per tuoi gusti sadiani?
Non voglio più essere toccato. Non ne voglio più sapere nulla. Non voglio sapere quando finirà, come finirà… Non voglio più essere invaso, disturbato – per cui fammi scendere da questa barca! – non le voglio più queste angosce di morte. Non voglio più dormire. Non voglio più sognare”.
AUTORE
“Dici il contrario di quello che fai. Tu sogni ancora e lo fai proprio perché vivi nell’angoscia. Io sono qui per dirti che sei un coglione! …”
PERSONAGGIO
“E allora dimmelo! Grazie, ora che lo so, prego, fammi scendere”.
AUTORE
“Aspetta. Non c’è bisogno d’essere così…
Io sono qui soltanto per avvisarti che la tua non è una vera malattia, capisci?”
PERSONAGGIO
“Ti ho detto che non voglio più essere toccato. La mia è una malattia seria.
E poi con quale coraggio mi parli, tu che sei rimasto uguale a com’eri prima…”
AUTORE
“E difatti io qui per questo sono! Per questo sono entrato qui”.
PERSONAGGIO
“Basta! esci subito dal mio scritto”.
AUTORE
“No. Non uscirò da qui finché non ti ammazzerai”.
PERSONAGGIO
“Ammazzarmi? …”
AUTORE
“Sparati, datti fuoco, impiccati, affogati, scegli la morte che più t’aggrada ma fallo. Solo allora, ti giuro, io sparirò”.
(Il giovane si lega con una corda un pesante masso alla caviglia. Lancia così l’oggetto nel mare vermiglio e, con esso, sprofonda lontano).
***
Egregio sig. Direttore,
Le scrivo finalmente stamani, dopo che le varie richieste dei suoi collaboratori e i numerosi tentativi di mio zio di spronarmi, al limite del ricatto, si sono viste sfumare contro un mio ostico silenzio.
Capisco che mio zio ci tenga particolarmente che io lavori per lei. Capisco perché la situazione economica su cui versa la mia famiglia, io in primis, non è delle più confortevoli. Capisco perché, se così fosse, mio zio, affidandosi alla mia voglia di lavorare, sistemerebbe sia me che lui. E, infine, in questo modo farebbe un favore anche a lei, che pare cerchi proprio una persona con le mie caratteristiche e capacità.
Stamane mi sono svegliato da uno strano sogno. Affogavo in un mare color vermiglio, ma poi non ricordo né cosa accadde prima né cosa dopo. So solo che ha lasciato in me una grave angoscia. Sa, il motivo per cui ho rinviato i numerosi appuntamenti per un colloquio è che una febbre davvero maligna mi ha colpito da un po’ di tempo. Non si sa da dove provenga, né quali siano le cure. Perciò mi sento di dirle: aspetti. Abbia la bontà d’attendere ancora un altro po’, almeno il tempo che mi riprenda un minimo per uscir di casa (esco solamente per cose essenziali, come cibo e sigarette). Le prometto che nel frattempo butterò giù un’idea che m’è venuta in mente giorni fa su un possibile programma; un’idea che si basa sul dialogo fra gli autori e i concorrenti, un po’ come fosse un dialogo con Dio. Che ne pensa? Anche a lei sembra geniale? Beh, forse non sta a me dirlo…
In ogni caso appena questa grave febbre mi lascerà in pace prenderò il primo volo per la sede centrale e verrò direttamente da lei. Se preferisce farò prima un colloquio, giusto per non dare nell’occhio, d’accordo (attendo comunque una sua risposta precisa, per questo).
In sostanza, ci sentiremo presto. Aspettiamo solo che questa malattia passi e speriamo che avvenga il più presto possibile.
Ah, poi un’altra cosa. So che le saranno giunte voci o solo magari pensieri su di me riguardo una mia scarsa voglia di lavorare o, peggio, riguardo una mia presunta inaffidabilità. So che può sembrare ovvio che sia così, viste le mie mancate risposte, ma le assicuro che le sta scrivendo la persona più seria e vogliosa di lavorare che lei abbia mai conosciuto. È facile parlare quando non si sanno i problemi delle persone e, soprattutto, quando queste non sono presenti e dunque non hanno possibilità di controbattere. Questo ragazzo è il più serio e disponibile della sua generazione. Solo, unica cosa, non ha sempre le idee ben chiare e limpide come l’acqua d’un ruscello. Complice il momento che sto vivendo, sento tuttavia d’essere in gran forma, nonostante debba spesso remare contro la mia stessa natura. Le dico: sto scrivendo una grande raccolta di racconti. Glielo dico per farle capire ciò che intendo, mica per altro… Dunque, sto scrivendo questi racconti dove i protagonisti sono afflitti dalle stesse misconosciute malattie che affliggono me. Il tutto potrà sembrare mera mediocrità, eppure non è così. Per ora sono ancora a una fase embrionale, una bozza per intenderci. Presto però vedrà la luce e mi piacerebbe che lei fosse uno dei primi a leggerlo, così magari capirà meglio (anche se sono più che convinto che lei abbia già colto sin dall’origine i miei problemi).
Se proprio devo esser sincero, ora ricordo qualcosa in più del sogno di questa notte. Pare che qualcuno che mi conoscesse in modo particolare si sia raccomandato con me d’essere più sicuro e deciso nelle scelte che faccio. Vede, però, io non credo di essere d’accordo con quest’uomo. In fin dei conti, perché uno dovrebbe esser fiero di star con la schiena ritta, i piedi a terra radicati al suolo e le idee chiare? Perché uno dovrebbe rischiare di perdere la propria vita (perché è di questo che si parla in fondo) e vergognarsi di tener incassata la testa fra le spalle e la confusione nel cervello? Per me, direttore, uscire dal proprio stato d’insicurezza è per l’essere umano qualcosa di impensabile.
Cordiali saluti,
P.
Quest’opera si presenta come un testo liminare: non solo poesia, non solo prosa, non solo sceneggiatura, si muove sul bordo di queste tre forme e le travalica costantemente attraverso continue invasioni ora poetiche, ora prosastiche. Un testo ibrido, dunque, che si dispiega sul fil rouge dell’inadeguatezza, della mediocrità e della malattia, una febbre endemica, misconosciuta e maligna che affligge il protagonista per tutta la durata del racconto.
Il flusso febbrile e delirante, quasi allucinatorio, di parole in cui lə lettorə si ritrova risucchiato viene spezzato dalle intrusioni dell’autore stesso, che prende la parola e, novello Virgilio, accompagna il protagonista a toccare il fondo, che poi corrisponde al suo stesso fondo. Dialoga con lui, in quello che il titolo sembra suggerire essere una sorta di sdoppiamento dell’Io: personaggio e autore finiscono per confondersi nello stesso disordine letterario, nello stesso fondale di incertezza per arrivare alla conclusione che forse, quest’incertezza, questa insicurezza, questa confusione nel cervello non sia qualcosa da demonizzare ma una condizione costitutiva dell’umano da abbracciare.