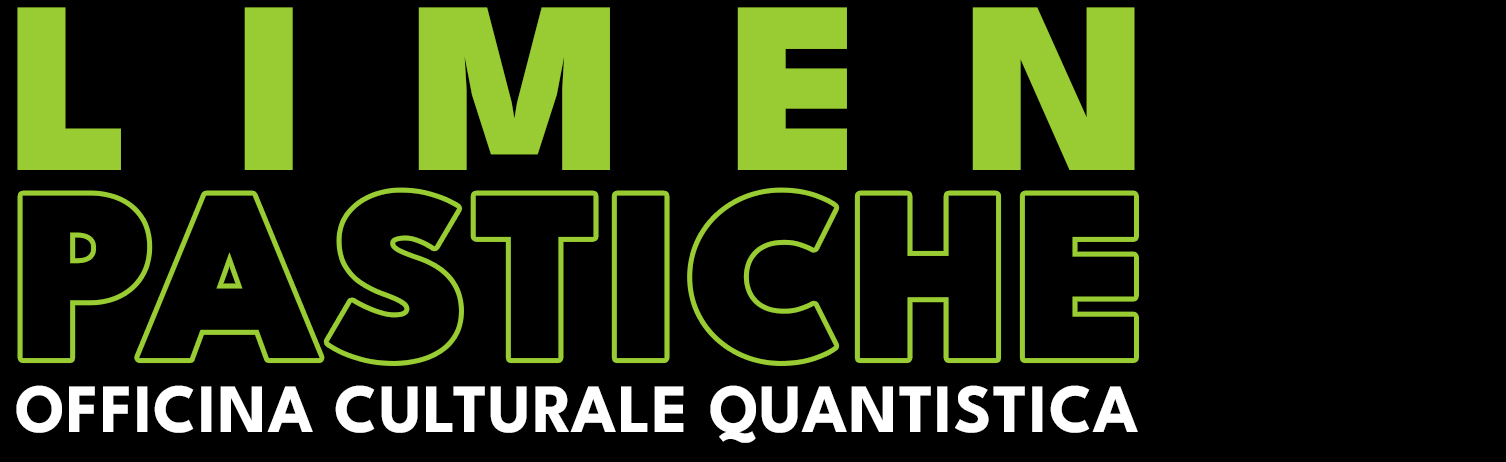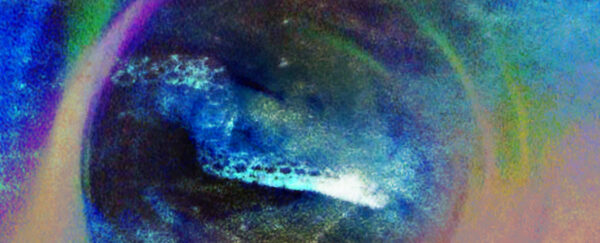Testi di
Gian Marco Ferone
Disegni di
Daniele Giampaolo
Editing di
Simone La Penna
Categoria
Narrazioni rotte
Data di pubblicazione
13 Settembre 2023
Il coso del prete
Insieme ad Acidalia, una ragazza molto magra, alta quanto una bambina, con l’aurichiome fini e rade, che mi ero messo accanto per il carattere arrendevole e sommesso che la rendeva adatta a me, tanto impavido e atto al comando, mi sistemavo ogni estate nella sua casa di montagna. Erano mesi di noia rivoltante, ma dove trovare un altro posto in cui venir servito gratuitamente per tutto quel tempo? La mia bionda amanza aveva proposto di quando in quando, timidamente, di cambiare meta per una volta, ma l’avevo messa a tacere con un perentorio diniego e discorsi sulla “genuina e rustica vita delle alture” così ipocriti – lo ammetto – che anch’io me n’ero vergognato un poco.
Arrivai stanchissimo la prima sera, e avrei voluto soltanto sorbire una lauta cena e andarmene a dormire, ma Acidalia insistette a che bevessimo una cosa all’unico bar della zona. In uno zelo di compiacenza, l’accontentai – dopotutto era sua la casa in cui avrei pasteggiato e ronfato per una stagione – ma la testa prese subito a pendermi dal sonno. I suoi discorsi mi suonavano nel capo come un ronzio lontano. Anche il barista, un tipo strano, con la pelata rotonda e due baffi da domatore di leoni, mi appariva irreale mentre si esibiva in contorsioni impressionanti per mostrare a un ubriacone come riuscisse a giungere le mani in preghiera dietro la schiena. Giunse a riscuotermi dal torpore il verso dei maiali dalla Via dei porci, una strada lunga e stretta che dà sui recinti in cui gli zotici tengono quelle bestie col pene simile alla coda. Ora sveglio, ordinai imperioso il ritorno a casa, ma Acidalia mi si avvinghiò e prese a darmi carezze e baci che – nonostante la mia consueta irruenza passionale – proprio non ero in condizione di accordarle. Soltanto quando sputai a terra, dopo che ebbe slinguazzato i miei denti serrati e decisi a non cederle il passo verso le tonsille, si convinse a rientrare.
L’abitazione si trovava in una forcella sopra una valle, dove le facevano ombra da un lato folti di frasche, e dall’altro un noce piantato nel giardino. Si trattava di un edificio ideato per ospitare un’intera famiglia: il piano terra era stato diviso in tre case per i figli, mentre sull’ammezzato, nell’abitazione più grande, vivevano i nonni. C’era infine una specie di soffitta che loro chiamavano “la mansarda”, che quell’estate era tenuta in fitto da un prete – a quanto pare amico dei nonni -, tale padre Umberto. Proprio per la sua presenza, quella sera fui costretto a sedermi a tavola e non potei consumare, come mio solito, la cena in camera.
Poteva avere quarant’anni. Era alto e smilzo come un fusto di mandorlo. Il suo volto sembrava quello di un manichino, e portava pettinati all’indietro i pochi capelli rimastigli.
Mi causò una forte ripulsa, quasi un conato, notare che teneva fra le mani uno strumento non identificabile, una specie di grossa molla organica e malleabile, dall’aspetto assai ruvido. Padre Umberto andava ogni tanto acchiocciolandola, modellandola in forme sempre più strane, compiacendosene con un «mpf hm hm». Il suo comportamento era reso ancora più sinistro dal fatto che aveva scelto il posto davanti alla finestra da cui si vedeva il camposanto con le sue lucine rosse. O forse ce l’aveva piazzato la nonna, che gli stava seduta di fronte ammirando estatica il quadretto attraverso i suoi occhialoni da bruco, e non si decideva a mettere in tavola. Finalmente la vecchia si alzò e servì il pranzo strepitando – era mezza sorda — uno dei canti di chiesa che conosceva a memoria. Il prete portava il tempo agitando quel suo schifoso affare, mentre il nonno faceva osservazioni sarcastiche sulla consorte.
A un certo punto, la vecchia si dispose con aria di predicatrice sullo sgabellino che preferiva a ogni sedia e iniziò a raccontare, rivolgendosi ancora a padre Umberto che mangiava i suoi involtini di carne, ma invero pretendendo indivisa attenzione da ciascuno di noi, ché ogni volta qualcuno pareva guardare altrove la nonna schioccava le dita e con uno “eh eh!” lo richiamava all’ordine.
“Pensate, padre, che una volta invitai a cena don Carmine e due amici della chiesa, e quelli portarono queste cozze da Scauri. E io le cucinai tanto bene, ma tanto bene, che don Carmine mi disse ‘Rosa, ma quando lo apri questo ristorante?’ ” e a quel punto si fermò sorridente a guardarci tutti in attesa che concordassimo con don Carmine. Ottenuto l’apoteosi, riprese: “Embè, secondo voi, padre, l’unica cozza andata a male dove va a capitare? Nel piatto di don Carmine!” e così dicendo baciò il crocifisso. “Quando la mise in bocca si fece bianco! Io capii subito e gli feci segno di no con la testa, perché, come voi sapete, è maleducazione sputare a tavola. Così io mi alzai! sì! mi alzai, e con una santa pazienza lo baciai in bocca, mi presi io la cozza, e andai al bagno per sputarla nel gabinetto”, e stette ad aspettare la pioggia di ammirazione che tutti quanti, escluso il nonno, fummo obbligati a rovesciarle addosso.
Padre Umberto aveva masticato ininterrottamente per tutto il tempo del racconto, o almeno mi parve, lo stesso boccone, al massimo un paio, poiché quando tutti avevamo ormai terminato il nostro piatto, quell’imbecille stava ancora occupandosi del suo primo involtino. Gli invidiai il bolo, presumibilmente ridotto a liquido a quel punto, che aveva ancora tra le fauci, perché gli fruttava il privilegio di non verbalizzare alla nonna la sua approvazione: si limitò a guardarla accondiscendente, e le fece anche un breve applauso, mentre la stupida vecchia ridacchiava tutta fiera di sé, e mancava soltanto che si mettesse a ballare o a mostrare qualche nudità, come fanno i bambini in una certa fase dello sviluppo psicosessuale.
La cena, per quella lentezza di Padre Umberto, durò oltremodo e soltanto alle undici ci liberammo degli sciù riempiti di crema al cioccolatte. Il nonno fu il primo a lasciare la tavola, visibilmente disgustato dall’esibizionismo di quella pinzochera della moglie. Dal mio canto, ero molto più disturbato dal prete che continuava a giocherellare instancabile con quel diabolico fattapposta, tanto che mi venne voglia di chiedergli a cosa diamine servisse. Reputai tuttavia più saggio ritirarmi anch’io, ché la nonna ciucca di nocino stava riprendendo a decantare gesta sue mirabolanti, e andarmene finalmente a dormire. Nella stanza preparata per me – non mi era concesso dormire con Acidalia, confinata per gerontocratico decreto al piano inferiore – c’erano un lettino a molle con accanto un piccolo comodino e la sua abat-jour, una scrivania, una cassettiera e una cassapanca con dentro qualche coperta. Il balconcino affacciava sul giardino del noce, il quale dava a sua volta sulla valle da cui veniva, ininterrotto giorno e notte, il grugnito dei maiali. Messomi a letto tutto acciocchito, mi riuscì appena di leggere, prima di addormentarmi, qualche pagina della Justine. Nel testaciondoloni presi nota di un fatto: durante la cena il prete non aveva detto neppure una parola.
 Una certa Clotilde, amica di Acidalia, aveva sempre stuzzicato il mio buongusto per la sua albagiosa signorilità, che le veniva dall’essere figlia del sindaco, e per un procacissimo sodissimo seno che in estate esibiva sotto alcuni vestitini di cotone trasparente.
Una certa Clotilde, amica di Acidalia, aveva sempre stuzzicato il mio buongusto per la sua albagiosa signorilità, che le veniva dall’essere figlia del sindaco, e per un procacissimo sodissimo seno che in estate esibiva sotto alcuni vestitini di cotone trasparente.
La sua compagnia nelle serate di lassù, tanto noiose, aveva l’effetto di eccitarmi troppamente: un problema, visto che non potevo neanche sfogarmi su Acidalia. I nonni non ci proibivano solo di dormire insieme, ma non ci lasciavano mai soli neppure durante il giorno: arcirarissime erano le loro assenze, e si può dire si dessero il cambio per farci la guardia. Un paio di volte si era pensato di appartarci, ma lo schifo al pensiero che qualche insetto, di cui gli alberi intorno abbondavano, potesse infilarsi nelle fessure in quei momenti vulnerabili, mi aveva spinto a far desistere la mia fidanzata. Così potevo raggiungere un tal grado di frustrazione che iniziavo a maltrattare Acidalia, e notavo allora in Clotilde una sadica soddisfazione, di come quando ci si gratti con furore una puntura di zanzara; questa mi spingeva a insistere e calcare la mano, ma non si pensi che mi facesse piacere: quando accadeva ci ripensavo mortificato, ed ero poi molto più buono e gentile del solito con Acidalia, cosicché si può dire che lei ci andasse meglio di me.
La sera seguente, dunque, non cenammo dai nonni, ma ci incontrammo con la figlia del sindaco, la quale si presentò in un succinto tubino giallo scollato, con sulle spalle dei lussuosi fiorelloni di strass. L’ultimo tavolo libero nell’unico ristorante del paese – affollatissimo dei discendenti degli emigrati che tornavano lì ogni estate per ubriacarsi tutte le sere – si trovava sotto una luce legata a un tronco di cotogno. Il caldo sotto il riflettore era insostenibile e Clotilde agitava il menù per farsi aria sul petto e fra le cosce, mentre io dovevo togliermi di dosso Acidalia che nel frattempo mi si provava a incollare al braccio, al collo, con quelle sue minuscole zampe. Sulla lampada si erano già immolate centinaia di moschilli che ci precipitavano nel piatto, dove più di una falena aveva aliato impazzita prima di stendere le zampe al cielo e crepare.
Infine, accadde che si posasse addosso a Clotilde, proprio in corrispondenza del capezzolo sinistro, un insetto orribile dal volto perverso, gli occhi avvolti di una rossastra fotosfera, con sul dorso il disegno di un fallo umano.
Acidalia restò inerte, fissando il mostro a bocca aperta, mentre l’amica mi porgeva il petto muggendo “Toglimelo! toglimelo!”. Pizzicottai il delicato punto, afferrando la bestia, e quella si inturgidì tutta e diede uno squittio agghiacciante mentre la schiacciavo nel palmo spremendone un ributtante liquido giallastro. Ahi, quale divenni! Sudai anche l’acqua del battesimo, stretto da un nodo d’ansia alla gola, e quanto soffrii a spiccarle dal corpo tafani, cervi volanti e vermi alati di ogni genere che pareva facessero apposta ad aggirarsi sempre intorno alle mammelle! La mia stessa mano mi pareva un disgustoso ragno peloso: appena gettato via l’insetto, la ritraevo in fretta a occhi bassi. Quei contatti con Clotilde mi turbarono tanto che per il resto della serata fui intrattabile. Respinsi le moine di Acidalia in silenzio lungo il ritorno verso casa, e quasi neppure la salutai quando ci separammo nell’androne.
 Salii al piano superiore che era da poco suonata la mezzanotte. Alla porta rimasi sorpreso dal non trovarla chiusa a chiave; mi aspettavo, dunque, entrando, il suono del televisore, o il ronfare dei vecchi catatonici allo schermo, ma invece…
Salii al piano superiore che era da poco suonata la mezzanotte. Alla porta rimasi sorpreso dal non trovarla chiusa a chiave; mi aspettavo, dunque, entrando, il suono del televisore, o il ronfare dei vecchi catatonici allo schermo, ma invece…
Dal soggiorno venivano sospiri e mugolii ambigui, accompagnati da tonfi di non meglio specificata natura. Trovai i due vecchi di profilo, mentre seguivano dalla poltrona i gesti di padre Umberto dietro un tavolo allestito ad altare. La nonna, eccitatissima, si passava una mano sotto la vestaglia rovistandosi tutta fino al petto, mentre si leccava via le gocce di sudore da sotto al naso. Suo marito la schiaffeggiava forte sulla gamba, mentre con l’altra mano teneva stretto il bracciolo; dal gozzo gli usciva un hiii asmatico e le palpebre gli battevano come a un epilettico. Il prete ficcava le dita in un calice schizzando intorno vino rosso, gemeva, barriva, grugniva, ruttava perfino, quell’animale. Cavò infine da una ciotola la maledetta molla con cui s’era gingillato tutta la sera prima; a quel punto la vecchia si mise a urlare “Dillo! Dillo!”, e siccome non lo diceva lo picchiò forte con un pugno. “Dillo! Il corpo di Cristo!”, e gli afferrò la mano in cui teneva il coso, prendendolo sulla lingua che le pendeva bavosa dalla bocca spalancata. Si voltò poi con sguardo da fanatica e mi fece il seducente gesto di avvicinarmi.
Il coso del prete è un racconto che sceglie di dispiegarsi con docilità e pazienza, con cura flemmatica e certosina, tratteggiando e suggerendo, sussurrando più che indicando. Un racconto fedele a sé stesso, che non abiura mai all’intenzione di intrigare senza respingere, di innescare scintille di senso senza farle mai spegnere ma senza neanche farle trasformare in qualcosa di più persistente, persino nell’abietto finale, che invece di scoprire le carte ricopre piuttosto di ambiguità le precedenti scene. Si tratta, allora, di un di-spiegarsi che, invece di ripiegarsi su sé stesso, incita (o forse persino induce) il lettore a un continuo scrutare. Uno scrutare tragicamente destinato, forse, a rimanere inespresso nella realtà intertestuale, in cui il protagonista non può che sottrarvisi, consapevolmente o contingentemente.
Si tratta di un racconto sopito ma sommessamente aggressivo, di un racconto equilibrista che gioca con le proprie sottili antinomie pur, al contempo, presentandosi come un continuo ribaltamento di prospettiva. Ma è un ribaltamento che è costretto nelle maglie di un’indagine personale mancata e tardiva del narratore, un’indagine che in un altro testo sarebbe potuta essere inquieta e sceglie invece di palesarsi come inquietante. Così, nella prosa cesellata e attenta si annidano faux pas che minano non solo la credibilità narrativa del protagonista, ma specialmente la sua sicurezza (ormai solo percepita) nella comprensione di quell’anti-realtà che si trova ad abitare; nell’incedere densamente metaforico delle scene si costruisce una rete di senso impietosamente intrappolatrice. L’unico elemento a salvarsi è il dubbio: sulla nostra morale, sulla nostra percezione, sull’assurdità e sul rovesciamento dei nostri valori. Sulla morte che, in mille forme silenti, ci si poserà addosso o finiremo per ingoiare.