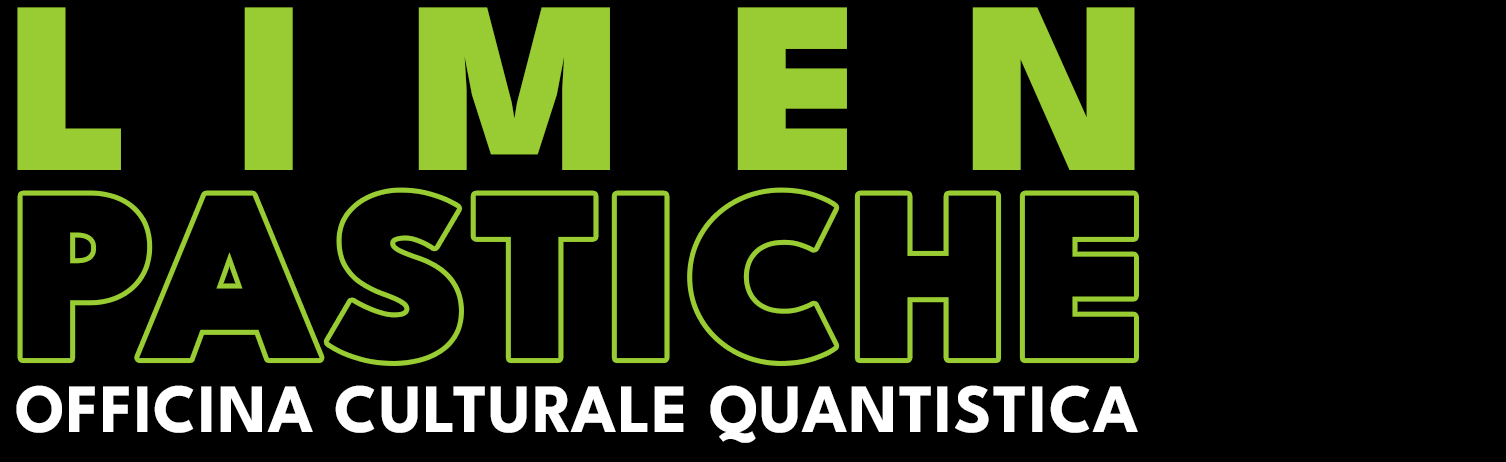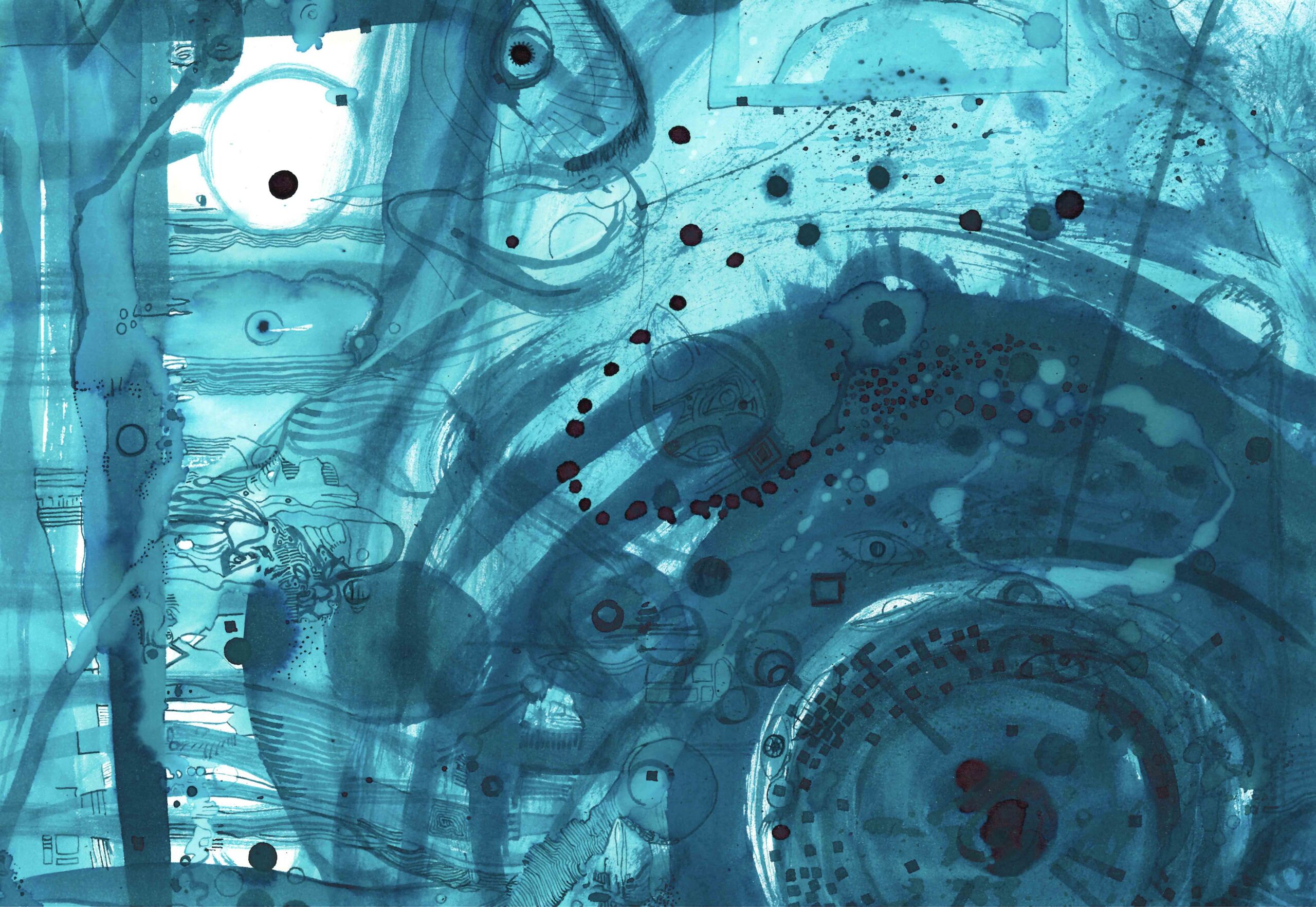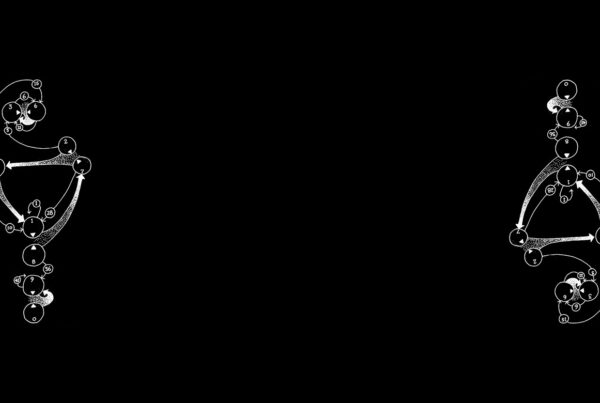Testi di
Odissea Di Bernardo
Copertina di
Andrei Costantino Cuciuc
Editing di
Andrea Ferraiuolo
Categoria
Materialismi
Passaggi viscerali
Data di pubblicazione
23 Aprile 2023
Abitare l’umano
Introduzione alla serie: MATERIALISMI è un cortocircuito viscerale che indaga, sul piano materiale prima che concettuale, i vari rapporti che vi sono fra l’umano e l’oggetto cultura, qui materialismo librario, che ammette e poi smentisce, dichiara e poi si accusa, per il suo nevrotico-schizo-feticismo per il sentimento verso il libro, per la verginità del libro o per la sverginità del libro.
Con la mano ancora incerta e malferma di chi ha appena imparato a scrivere, a cinque anni e mezzo ho tracciato le parole che avrebbero definito me stessa, la mia vita e il mio stesso rapporto con i libri per molto tempo: io volevo essere perfetta. E così l’obiettivo della perfezione mi ha accompagnata come un’ombra, mia compagna fidata, probabilmente da molto prima che lo confidassi al mio diario segreto, dolce illusione e amara ossessione in cui amavo rifugiarmi, abbraccio rassicurante che sembrava garantirmi l’amore, perché, se mi fossi impegnata abbastanza e con tutte le mie forze per raggiungere il mio obiettivo, un giorno ce l’avrei fatta, sarei diventata perfetta e la gente allora avrebbe potuto amarmi per davvero, non per compassione o per bontà, ma per ciò che ero: una bambina senza macchie, pieghe, segni di matita a sporcarle l’anima, quest’ultima un’anima bianca, pura e immacolata. Ho inseguito la perfezione dappertutto: a scuola, nelle relazioni, nello sport, nella lettura e nella scrittura, cercando insistentemente l’ordine di parole perfetto, la perfetta esposizione di qualsivoglia argomento, il perfetto bilanciamento di ragione e sentimento, la perfetta coordinazione nei miei movimenti e in quelli del mio cerchio, la perfetta conservazione dei miei libri, che non dovevano avere nessun segno, nessun’orecchia, perché se li amavo così tanto come asserivo già a sei anni, non avrei mai dovuto rovinarli. Avrei dovuto prendermene cura in modo meticoloso per dimostrare il mio amore verso quest’oggetto magico, capace di trasportarmi in mondi fatati, terrificanti, ma in cui il bene vinceva sempre e il protagonista veniva amato da tutti; per essere degna di poter entrare in quelle storie, senza lasciare nel cammino delle frasi, righe sbilenche e cuori imperfetti.
Ma per un malvagio scherzo del destino, per quella che appariva ai miei occhi come un’amara ironia della sorte, per quanto io mi impegnassi non riuscivo mai a raggiungere ciò che volevo, la perfezione era sempre due passi più avanti a me; per quanto consumassi le mie giornate in preda all’ansia divorante di fare tutto ciò che dovevo con il massimo delle mie energie, la perfezione era sempre avanti a me e io cercavo di arrancarle dietro, di recuperare terreno come Achille, ma lei era la mia tartaruga, sempre in vantaggio, sempre oltre, sempre irraggiungibile.
Ero un dieci meno, un nove e mezzo, un 98 su 100.
Non ero in grado neanche di prendermi cura dei miei libri, per quanto mi impegnassi a leggere composta e dritta, finivo sempre per assumere posizioni assurde che facevano in modo di creare pieghe fra le pagine, tagli microscopici, impronte di dita sporche di cioccolata. Mi capitava spesso di leggere a testa in giù, con le gambe appoggiate sullo schienale del divano e la parte superiore del corpo lasciata penzolare nel vuoto, con i capelli che sfioravano il pavimento e le dita che stringevano forte la copertina per non perderla, finendo per sgualcirla. Leggevo accovacciata sulla sedia come un avvoltoio, tenendo il libro fermo con il braccio e sgranocchiando intanto un biscotto, depositando briciole nella rilegatura senza mai riuscire a levarle. Leggevo nella vasca fin quando la pelle non si raggrinziva tutta, assumendo fattezze squamose, bagnando le pagine irrimediabilmente. Leggevo al parco, a scuola, in mezzo all’erba, finendo ogni volta per covare una frustrazione immensa verso me stessa, incapace di lasciare qualsiasi libro immacolato così com’era quando i miei genitori me l’avevano comprato. Poi a dodici anni ho iniziato a bere caffè e a dar vita, attraverso goccioline beige, a miriadi di costellazioni fra le pagine di tutti i miei libri, sbuffando per la mia disattenzione e il mio essere caotica e disordinata persino nella lettura.
Per quanto mi accanissi, la mia ricerca della perfezione faceva acqua da tutte le parti: a scuola, nello sport, nella cura dei libri e anche nelle relazioni: nelle amicizie mai amata per chi ero ma sempre e solo per ciò che davo, negli amori sempre e solo per il mio corpo.
La ricerca della perfezione si è così fatta spazio lungo tutte le mie cosce e mi è entrata dentro violentemente, aprendomi in due e lasciandomi a terra senza respiro, con le mani macchiate di sangue e un filo rosso che mi colava lungo le gambe. Un filo rosso che cercavo irrimediabilmente di fermare, ma che continuava a scorrere veloce, incurante delle mie dita che cercavano invano di raccoglierlo, che gli passavano attraverso. Un filo rosso che cercavo di lavare, ma ogni volta che sfregavo con forza il sapone sopra tutta la mia pelle brillava quasi fosse un rubino.
La perfezione mi ha sverginata senza pietà, ha sporcato la mia anima bianca, a cui impedivo di vivere per conservarla immacolata. Ha distrutto in un sol colpo tutte le mie certezze: ora che ero rotta per sempre, ora che mi ero rotta da sola rincorrendo un mito inafferrabile (in quanto inesistente), facendo del mio corpo e della mia mente ali per il folle volo verso il raggiungimento del «perfetto», nessuno avrebbe mai potuto amarmi.
Ero a pezzi, rotta, sgualcita, a ogni passo perdevo pagine della mia anima; si strappavano al minimo accenno di vento e non facevo nulla per riprenderle, non ne erano degne, ora che erano così imbrattate di rosso, ora che erano così sporche del mio sangue non più innocente.
Volavano dappertutto, volavano via da me; e ogni foglio che vedevo strapparsi era un pezzo perso per sempre, un passo in più verso una perdita del sé, che in fondo aspettavo, vergine immacolata mai aperta alla vita, sempre attenta a non mettere mai un piede in fallo. Che in fondo, non aspettavo altro che farmi a pezzi: perché solo attraverso la successiva ricomposizione sarei riuscita a essere davvero chi ero, lasciando indietro ciò che pretendevo di essere per riuscire a sentirmi amata realmente.
Ma quanto faceva male rompersi!
Quanto faceva male accorgersi che fino a quel momento avevo portato avanti una farsa, avevo cercato di diventare la mia maschera, e quanto faceva male il modo in cui ero arrivata al raggiungimento di tale consapevolezza. Non riuscivo a rendermene bene conto, ma la violenza era diventata parte di me, della mia identità spezzata, si era infilata fra le pieghe della mia anima e l’aveva rotta completamente. Non che questo fosse un male, anzi, ma il modo in cui era avvenuto era qualcosa di totalmente umano e disumanizzante al tempo stesso: uno strappo netto, crudo e brutale, un pugno allo stomaco che ti piega in due.
Non avevo più niente: non la mia anima, non il mio corpo, non la mia vita in cui potermi rifugiare: che quest’ultima andava completamente ridisegnata ma io non ero più neanche in grado di stringere tra i palmi una matita.
Una sola mano amica a tirarmi fuori dall’inferno, anzi, ad attraversarlo insieme a me; solo lo studio come rifugio e distrazione, come medicina al dolore; solo i libri ad aggiungere fogli alla mia anima, per rimpiazzare la perdita degli altri, volati via mentre li osservavo senza vederli realmente. Li guardavo senza soffermarmici troppo, senza metterli realmente a fuoco, come fossero solo degli elementi che compongono un unico paesaggio, finendo per confondersi in esso e non essere riconoscibili a occhi distratti e alienati.
Si mescolavano con la strada, con le insegne luminose di un mercatino di libri usati che mi sembrava di vedere per la prima volta. E che mi sembrava così simile a me, sfavillante all’esterno, accattivante, con un cartello che invitava la gente ad entrare, e un dentro in disordine, confuso, polveroso da cui si voleva uscire il prima possibile.
Dopo tanto tempo, per la prima volta, mi sono sentita a casa.
Ho trovato un nuovo modo di approcciarmi alla vita: non più cercando di lasciarla intonsa, di non sporcarla, ma rovinandola quasi appositamente, sottolineandola fino a farla rompere, per imprimere il mio segno su di lei. Per riuscire ad affermare la mia esistenza, che altrimenti si ridurrebbe a pagine bianche, perfette, levigate, senza nessun particolare che le differenziasse da quelle delle esistenze altrui.
Tutte le sovrastrutture che mi ero costruita addosso, tutti i miei sogni, tutte le mie certezze, tutto il mio modo di vivere, a partire dal mio rapporto con il libro, era cambiato.
Non dovevo più essere degna di lui e delle sue storie, conservandolo intonso, ma potevo e volevo viverlo a fondo, lasciando fra le sue pagine i segni del mio amore disperato, del mio bisogno insaziabile di riconoscermi in qualcosa, di ritrovare quelle pagine di me tanto disprezzate fra le pagine dell’anima di qualcun altro; di non sentirmi più sola nel mio dolore, ma di accogliere dentro il mio cuore la sofferenza degli altri e accorgermi che in fondo non è così diversa, che ci piega tutti allo stesso modo, ci svergina tutti senza pietà ogni volta che entra nella nostra vita. Non importa quante volte lo faccia, noi la vivremo sempre come la nostra deludente prima volta.
E il libro ci narra di questo continuo appassire dell’umanità, di questa continua natura maligna che ci priva costantemente della nostra felicità, di questo continuo senso di solitudine che non riesce a trovare appagamento da nessuna parte, in nessun abbraccio, in nessun bacio, in nessuna stretta, in nessun contatto se non in quello più intimo possibile: quello di due anime nude, imperfette e fragili che gridano con voce tagliente e incrinata dal pianto il proprio dolore, senza nascondersi dietro maschere fisse, sempre uguali a sé stesse, perfette e immacolate (e ridicolmente false). I libri ci sbattono in faccia la verità su chi siamo: esseri umani imperfetti, pieni di difetti, falle, errori, sbucciature e ferite che tentano di cicatrizzarsi non sempre riuscendoci del tutto; esseri umani storti, incasinati, caotici, sofferenti e difettosi, ma vivi. E ricercare la perfezione, disprezzando le imperfezioni che ci caratterizzano, significa solo rinnegare l’umano, storcere il naso di fronte all’umanità sporca che si contorce su se stessa dal dolore, nuda come un verme, significa rinnegare la nostra natura più intima e vera: il nostro abisso che ci osserva ghignando ogni qualvolta facciamo finta di non vederlo.
E se rifiutiamo l’umano che è in noi, se tentiamo disperatamente con ogni mezzo di cancellarlo per non sentirci più così inermi, piccoli e brutti, rifiutiamo anche l’umano negli altri, non accettandoli, eliminandoli dalle nostre esistenze non appena osano mettere un piede in fallo, disprezzando le tante vite spezzate e gravate da un peso troppo grande per loro da sostenere e abbandonandole a loro stesse, perché in fondo, la sofferenza se la devono essere meritata in qualche modo; avranno sicuramente commesso errori per cui meritano di essere condannati, in questa o in un’altra vita. Perché, in fondo, la sofferenza ci sporca, macchia irrimediabilmente la nostra anima candida, e noi questo non lo vogliamo, non vogliamo essere imbrattati da mani sporche di sangue che tentano di chiederci aiuto, non vogliamo essere macchiati dallo schifo che si portano dentro.
Cerco fra mille libri quelli più brutti, macchiati, rovinati, vecchi, con quell’odore stantio di muffa appiccicato come miele sulle pagine, con la polvere che si alza non appena vengono presi in mano e con i fogli che scricchiolano non appena vengono toccati.
Cerco fra mille libri quelli che parlino di me, che mi raccontino della mia violenza, della mia insulsa corsa alla perfezione, dei miei errori e delle mie debolezze, che abbiano raccolto in se stessi almeno un frammento accartocciato e sporco di quella che un tempo era stata la mia anima.
Cerco fra mille libri quelli a dieci, venti, trenta centesimi; quelli usati e strausati, quelli che quando li apri sprigionano tutta la vita che li ha attraversati, tutte le innumerevoli vite che li hanno percorsi, le dita confuse di troppe mani che ne hanno accarezzato le lettere, le matite che hanno tracciato righe malferme, parole scomposte, commenti acuti e anche idioti, orecchie piegate più e più volte.
E mi rendo conto che anche nelle cose rotte c’è bellezza, una bellezza che resiste al tempo, ai dolori della vita, alle mani invadenti di corpi sconosciuti. Una bellezza vissuta, non lasciata appassire, non chiusa per sempre e ostentata su uno scaffale ricolmo di libri nella forma tutti identici fra loro, tutti immacolati, perfetti, intonsi, toccati con i guanti per non farli sporcare ma non vissuti fino in fondo.
Una bellezza dell’umano, dell’imperfezione e dell’irripetibilità; libri tutti unici, tutti diversi fra loro, stessi titoli di edizioni diverse, stessi titoli di edizioni uguali ma profondamente differenti fra loro in virtù del fatto di essere stati toccati da mille mani, scavati da mille occhi, segnati da innumerevoli sofferenze e sottolineati da mille cuori.
Vissuti davvero, fino in fondo, da tante persone unite dalla loro condizione di esseri umani, perché la vita richiede righe sbilenche, righe ondulate per via dell’autobus sopra il quale stai leggendo, commenti insulsi, banali, arguti, lasciati ai margini di una pagina che ti ha scavato il cuore, lacrime salate impresse per sempre sui fogli per quel passo che ti ha fatto tanto commuovere e che hanno saputo persino farsi spazio al di sotto della mascherina per arrivare a destinazione. Servono orecchie per le parole che ti hanno fatto battere il cuore, per ritrovarle più velocemente quando ti sentirai troppo rotta per rialzarti da sola; servono cuori imperfetti per accogliere frasi-medicina, frasi-sale che si depositino su tutte le tue ferite e le facciano sanguinare più forte di prima, perché solo attraverso il sangue ci si rende conto di essere umani, di non essere supereroi, di non poter essere perfetti, immacolati, intonsi.
Anche perché sai che noia, tutti uguali, tutti freddi e bianchi, privi di colori accecanti, disperati, confusi ma veri, vivi, caldi. Sai che noia la bellezza asettica di mille volti mai segnati dal pianto, mai scavati dal poco sonno, mai macchiati dagli eventi, perché chiusi alla vita, come uno dei tanti libri adorati a mo’ di sacra reliquia, aperto quel tanto che basta per leggerlo ma mai completamente per evitare pieghe; quel libro collocato nello scaffale della tua libreria con i suoi vicini della stessa grandezza, della stessa casa editrice e perché no, anche dello stesso colore, identico allo stesso libro presente in negozio.
Non c’è paragone con la bellezza delle cose rotte, delle pagine strappate, delle sottolineature sbilenche e delle pieghe imperfette, segno del passaggio della vita, segno della stessa apertura alla vita, un’apertura che ti spezza, ti fa male, ti fa sanguinare ma ti dà in cambio la vera bellezza, la bellezza dell’unicità e dell’umanità.
Non c’è paragone con la poesia dei libri usati, con le pagine appassite dal trascorrere del tempo, ma ancora vive, ancora capaci di scuoterti, di ricomporti l’anima frammentata, di ricucirtela alla buona, in modo imperfetto, rozzo, ma reale.
Dai libri usati ho imparato ad abitare l’umano, ad abitare la mia anima distrutta, fatta a pezzi dalla vita, la quale voleva forse solo essere accolta da me, non accantonata per raggiungere un ideale folle e privo di bellezza.
Ho imparato a essere contenta dei miei deserti, ad abbracciare la mia umanità e conseguentemente anche quella degli altri; novella ginestra che ha fatto pace con la sua fragilità e si erge proprio grazie ad essa, che resiste alle colate di lava che le piombano addosso riuscendo a splendere nella sua immensa debolezza, regalando bellezza dove prima si vedeva solo schifo.
Questo primo passaggio viscerale si dimostra capace di un’eccezionale sensibilità, un libro aperto a mostrare ferite e dolori. L’oggetto-libro è reso quasi con prosopopea l’autrice stessa: le pagine sgualcite divengono pezzi di organi e tessuti, sentimenti rotti, le pieghe e impronte delle dita divengono il disordine interiore, l’imperfezione del corpo-libro diviene l’imperfezione dell’autrice. La formula proposta è un intrecciarsi di pensieri privati (diaristici) con una filosofia dell’uso e “consumo” librario che risulta escamotage per riflettere su questioni di genere, sulla violenza, sulla nevrosi, sull’ ”identità spezzata”. A partire dal titolo, si vogliono ricordare le difficoltà di “abitare l’umano”, e cioè le difficoltà del vivere: come scrive Pessoa, “Vorrei avere il tempo e la quiete sufficienti/per non pensare a cosa alcuna,/né per sentirmi vivere”. Ma qui non ci si piange addosso, Abitare l’umano non è un piagnisteo. Lo si dice: “… novella ginestra che ha fatto pace con la sua fragilità e si erge proprio grazie ad essa, che resiste alle colate di lava che le piombano addosso…” e anche qui il riferimento alla poesia è chiaro: l’umano-ginestra risorge (come un cristo) fra ceneri pompeiane addolorato e distrutto, ma vivo. Eppure una seconda eruzione lo ricoprirà, prima o poi; non vi è presente, qui, la sfacciataggine retorica di dire che non accadrà. Tuttavia il corpo-stelo si piegherà per natura all’ultima colata di lava ma, com’è la poesia leopardiana a suggerire, lo farà con estremo coraggio e resistenza.