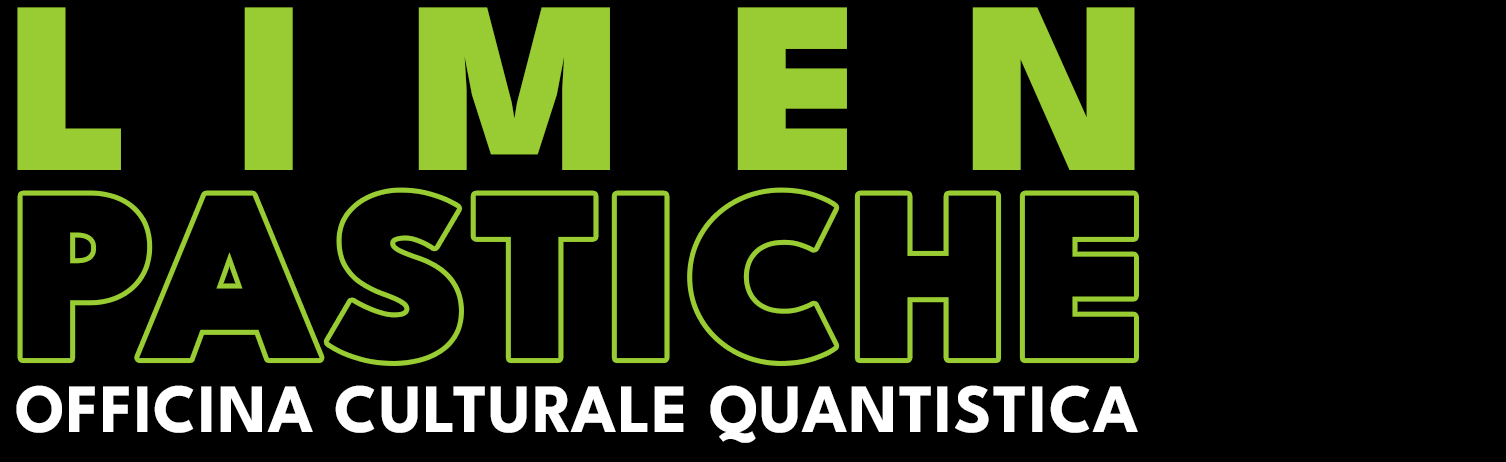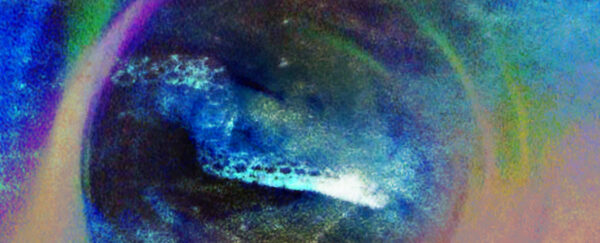Testi di
Gian Marco Ferone
Illustrazioni di
Gian Marco Ferone
Editing di
Simone La Penna
Categoria
Narrazioni rotte
Data di pubblicazione
20 Marzo 2024
L’infausta costellazione
Al dio delle trasformazioni
Quando un bambino non viene amato, il suo cuore va in pezzi. Così strisciò fuori un piccolo di donna dalla mitica triade familiare, simile a molte altre che compongono l’umana compagine pericolante.
A onor del vero va detto: era orrendo. Era basso, rattrappito in una S. Il suo busto era tozzo come il carapace di un artropode, e come quegli animali pareva diviso in segmenti. Staccandogli una delle estremità, quella avrebbe certo proseguito per la propria strada. Brutta era la bocca dalle labbra tirate all’ingiù; brutto era il naso con cui emetteva respiri dal suono rivoltante, come se avesse due grassi batraci in luogo dei polmoni. Violenti, sotto la bassa fronte irta di ispidi capelli, più simili al vello di scimmia che alla chioma umana, stavano due enormi occhi sempre strabuzzati. E all’inquietante aspetto si univa l’altrettanto inquietante nome: Testa di Corvo.
Avidi negli affari, duri di cuore, i genitori dell’abietto avevano concordato di sposarsi solo quando i campi coltivati insieme avessero iniziato a dare i frutti sperati. Si concedevano poche spese, volgari ostentazioni degli opimi raccolti. “Austero accumulo e sperpero infruttuoso” avrebbe dovuto star inciso sulla facciata della casa eletta a dimora familiare.
La passione materna per la grande città aveva riempito gli interni della villa, con oggetti provenienti dai centri commerciali, in plastica, alluminio e compensato, materie predilette e gelosamente conservate. I prodotti erano con somma cura avvolti in cellofan, con regolarità ripuliti dalla polvere e, laddove possibile, interdetti all’uso per ritardarne l’inevitabile decadimento dell’aria di novità. Finivano poi gettati tra i rifiuti appena iniziavano ad apparire in qualche modo familiari. Durante i pasti venivano consumati cibi precotti o surgelati, serviti in piatti di plastica, accompagnati da bevande imbottigliate in plastica, versate in bicchieri di plastica, e ci si puliva il muso in tovaglioli di carta precedentemente avvolti in plastica. Per il resto, l’abitazione non aveva un’anima. Casa di Corvo sembrava un flat esploso da un condominio urbano e precipitato qui per caso, senza relazione con le villette di pietre spaiate, dai cocuzzoli fumari di varie forme, e i rachitici tre piani delle costruzioni medievali che dominano nelle nostre zone.
Davanti ai genitori, un entomologo avrebbe provato il piacere fiabesco di una bambina che riuscisse davvero a prendere il tè con dei gattini. Il padre, ellissoidale, tendenzialmente marrone nel vestire e nei baffoni, ricordava lo stercorario. La madre, più che altro gialla, strettissima di sotto, per una speciale postura delle braccia sempre allargate ad afferrare pacchi, ceste, buste, carte, appariva come uno scorpione. Non si amavano, si possedevano con ferocia. Le loro dimostrazioni di affetto reciproco si limitavano a reazioni difensive, istintive, come gli scatti delle mosche, ai tentativi del figlio di ricevere o donare loro affetto. In questi casi, si sigillavano l’uno all’altro come una cerniera, restavano appiccicati e immobili, vibrando ogni tanto e lasciando un suono gutturale che poteva sembrare un umidiccio ronzio di ali.
Erano d’accordo che del rampollo non ci fosse altra necessità di curarsi, oltre a nutrirlo, vestirlo e grattargli via le scorze quel tanto che bastava per farlo apparire figlio di gente benestante. Il padre lo voleva rude, capace di spaccare la legna conle mani. La madre lo voleva invece segregato in casa, a studiare come far di conto, per diventare magari un giorno commerciante e andare a vivere lontano, nella grande città. Scelsero poi di tenerlo separato dagli altri bambini del paese, per inculcargli un senso di superiorità che non poteva venirgli soltanto dalla ricchezza.
Si incamminò dunque Testa di Corvo per la china della pedagogia nera, tecnica millenaria che insegna ai piccoli come soddisfare le pretese dei grandi, e si rivelò alunno diligente. Al canto del gallo si recava in giardino dal padre, che se lo disprezzava a ogni segno di debolezza con una risatina blattoide, hi hi hi!, dall’altro lo esaltava quando rompeva, per esempio, l’osso del collo a un gatto randagio. Pagato il tributo alla paterna voglia di sangue, si recava dopo pranzo in salotto, dove sotto l’addestramento di sua madre imparava a misurare, calcolare e risparmiare. Un’operazione sbagliata costava uno schiaffo alla testa, due operazioni di seguito una testata al banco, tre poi significavano dover scendere le scale piegandosi prima sulle ginocchia, stendendosi poi per il poco che poteva, e urlando “pullice-vierme!” – e il padre rideva hi hi hi!. Veniva lasciato poi libero di fare ciò che più gli piacesse, armato di un bastone di castagno dal pomo duro e spesso e la punta di metallo.
Ma una tetra notte, la quiete della domus intra montes venne turbata, se il male può turbarsi.
Si era al principio di novembre, quando le nebbie riempiono già le valli. Alla porta della casa sentirono bussare: toc toc fecero alla porta, toc toc fecero ancora. Madre e padre vi si avvicinarono, Testa di Corvo ringhiante al seguito, armati di pistola, con sguardi d’assassini. Sentirono in risposta al chi va là, frammisto a un gorgoglio, qualcuno chiedere del cibo, e capirono trattarsi della janara del paese.
Risinganna si chiamava, e non si comprendeva se fosse per beffa della fame patita per tutta la vita, com’è d’uso per i soprannomi da queste parti, o per la singolare cicatrice lasciatale da un colpo di coltello infertole alla gola da parte a parte, da non si sa chi, non si sa quando. Risinganna appariva quasi sferica, sempre coperta di stracci com’era, una specie di sacco da cui spuntavano la minuscola faccia e due ciocche di capelli grigiastri, due mani enormi e due enormi piedi su cui si spostava attraverso la campagna. Quando voleva far paura più di quanto non ne facesse il suo aspetto da cipolla, Risinganna scopriva il collo squartato ed emetteva un suono gorgogliante: gloshgloshclclsh, faceva, e chiunque le si trovasse avanti perdeva la parola e il colore in volto per giorni o settimane.
A quella vista i di Corvo risero di perfidia. La madre andò in cucina e fece ritorno con un salame, prendendone un’estremità nella bocca e così porgendone l’altra al marito, che l’addentò. Iniziarono a masticarlo voraci fino a che le labbra non si toccarono, sudice del grasso di maiale, mentre Testa di Corvo osservava attento. Per l’umiliazione Risinganna mostrò il collo e gloshgloshslclsh, fece piena d’ira. Il padre, forse per vincere lo spavento, sparò, ridendo la sua sinistra risata, ai piedi della janara. Risinganna fuggì, seguita da strani latrati di Testa di Corvo, sparendo nelle nebbie di novembre, lasciando nel loro fumo, come di latte lasciato a bruciare, un comico buco a forma di cipolla.
La madre andò a letto di malumore, calcolando le perdite in salame e piombo, e dal mattino seguente iniziò a comportarsi in tutto e per tutto come una gallina. Chiocciava aggirandosi spiegazzata – provava a tendere le braccia come suo solito ma questo la sbilanciava in avanti e dovette ben presto smettere –, muovendo la testa indietro e avanti, razzolando in terra alla ricerca di vermi, insozzando di escrementi i pavimenti della villa e gli oggetti tanto cari.
Il responso dei medici fu inequivocabile: non si sa, una disgrazia. Quello del padre fu tremendo: era la maledizione della janara! La cercò in lungo e in largo, perché invertisse il maleficio o anche solo per vendetta, ma non poté più trovarla. Alla madre spuntarono piume e cresta, i bargigli, speroni e garretti. Furono costretti a confinarla in un recinto, dove le fu costruita una lussuosa stanza secondo le necessità di gigante gallinaceo. Accade spesso agli umani, non soltanto se zotici, che quando una forza maggiore si porti via la loro roba, scoprano nei suoi confronti – roba umana o meno che sia – un attaccamento più vivo, meno da materialone. Così, teneramente, il marito si prendeva cura della moglie ridotta a un pollo.Lei gli strofinava la testolina allo stivale ogni tanto e per ringraziarlo di tanta dolcezza non lo tradì mai con il loro più bel gallo (sebbene ne avesse avuto la voglia e le occasioni). Anche col figlio era cambiata. Non lo umiliava più. Se sbagliava un conto, lo becchetteva piano sulla mano, se ripeteva male la lezione crocchiava bonaria, e in effetti Testa di Corvo apprese in quell’epoca più di quanto avesse mai fatto.Mestissimo fu il giorno in cui perì. La trovarono distesa, ventre a terra, che esalava gli ultimi chiocciolii. Coccodè! Coccodè! Addio marito mio! Addio figlio! parve dire, prima di rivoltare gli occhi e spegnersi per sempre.
Fu sepolta in un tumulo sotto un salice, accanto al bel pollaio. Sconvolto dalla perdita, il padre vendette per accrescere il patrimonio e, con i soldi ricavati, avviare un commercio di un qualche genere nella grande città, dove si sarebbe sentito più vicino alla moglie scomparsa. Del figlio non volle sapere più nulla o, meglio, si accorse di non saperne nulla e di non volerlo.
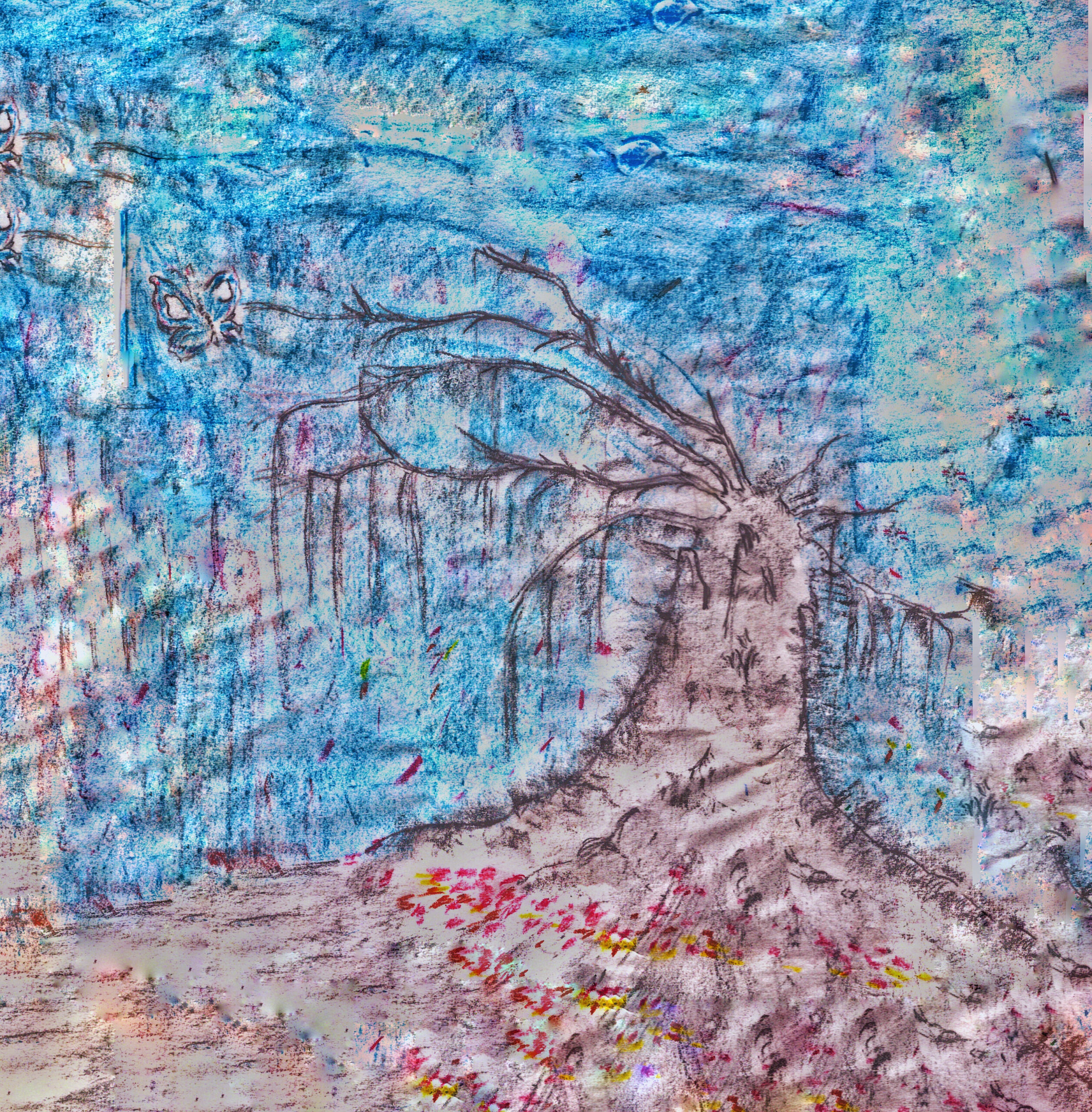
*
Il tempo scorre, oscuro fiume, e al principio dei suoi vent’anni troviamo Testa di Corvo sconvolto nell’equilibrio degli umori, pieno d’odio per sé e per gli altri.
Come il padre, cercò un modo di sentirsi vicino al fantasma della defunta, divenendo studioso come lei voleva. In città la sua educazione fu affidata alla scuola, dove gli fu presto resa nota la sua abominevole bruttezza. Di questa dovette iniziare ad accorgersi già nel momento in cui venne a contatto con l’abitudine cittadina di fissare i casi anomali e non di evitarli con un gran giro secondo l’usanza delle nostre montagne. Finché, un giorno, compagni e compagne lo assalirono e gli scrissero sulla fronte a grandi lettere rosse: MOSTRO.
Per tutti quegli anni rimase solo, neppure una persona gli tese la mano, e per le vie di quel dolore trovò consolazione fra le lettere. Divenne amante di certi libri ottocenteschi che hanno la pericolosa virtù di far sentire un eletto l’emarginato. Si convinse di essere un uomo superiore, il più disilluso di tutti i tempi; soprattutto, vantava con sé stesso un’immunità alla tentazione di avvicinarsi alle donne. In verità, le inconfessate volte in cui aveva guardato a un essere femminile attraverso gli orridi occhi di sotto l’ispida fronte, aveva visto nell’altra lo sguardo che le sciagurate Sette dovevano aver avuto scorgendo dietro l’angolo, nel Labirinto di Cnosse, la terrificante ombra del Minotauro.
Il padre acconsentì a che prendesse una casa dove vivere da solo, per gli anni universitari, e gli fornì una discreta pensione mensile per toglierselo dai piedi. Testa di Corvo cedette alla fascinazione di un grande appartamento in cui si vociferava Giacomo Leopardi avesse intrattenuto per mesi rapporti con una delle eredi di una nobile famiglia, innamorata della di lui ferita bellezza, la quale gli avrebbe addirittura dato un figlio, tenuto poi segreto. Bisogna dire che colui con cui Testa di Corvo aveva a che fare per regolare i conti di casa si chiamava Monaldo, come il padre del recanatese; tuttavia, poiché l’uomo presentava una sensibilità soltanto per il denaro, si rivelava in lui in proporzione maggiore il sangue degli Antici.
La casa faceva parte di un mediocre edificio seicentesco nel centro storico della città, costruito secondo le necessità di risparmio della famiglia nobile trasferitavisi all’epoca per timore di suscitare il sospetto nei regnanti Asburgo, che avevano invisi i baroni di campagna. Dopo secoli, divenuto cosa vecchia, l’edificio fu trovato bello e ancora oggi la brutta facciata reca una ancor più brutta targa col nome della famiglia committente e del disgraziato che li accontentò. L’appartamento di Testa di Corvo era stato ricavato dalla divisione di un’abitazione un tempo più ampia, alzando al centro del salotto un muro in maniera tanto barbara che da entrambi i lati si potevano ascoltare i rispettivi discorsi e movimenti.
Anche negli anni universitari, il raccapricciante reietto non stabilì nessun contatto col resto della società. Si fece crescere i capelli in modo da coprire il volto, si presentava alla facoltà di Lettere in vesti fuori misura con cui provava a nascondere la propria deformità, ma l’effetto che otteneva era quello di spaventare ancor più, se possibile, gli altri studenti che gli si tenevano lontani, lasciandolo solo ai tavoli della biblioteca, e separato da due o tre posti liberi intorno a lui nelle aule dove si tenevano le lezioni.
Testa di Corvo, checché raccontasse a sé stesso, era affamato di parole, di mani che lo toccassero. Guardava con desiderio insopportabile ai lieti giovani nel grande peristilio soleggiato, e per questo li detestava. Il suono degli evidenziatori che grattavano le carte gli sembravano sussurri e risa soffocate al suo indirizzo; il silenzio che si faceva al suo ingresso o al passaggio vicino a un gruppo ridente, lo prendeva per l’imbarazzo che sorge quando d’improvviso compare qualcuno proprio nel momento in cui se ne sta sparlando.
La paranoia lo rese ancora più amaro e infiammò in lui un altro desiderio, quello del riscatto. Pensò che se avesse scritto un libro di assoluta bellezza, e tutte le altre ciance neoromantiche apprese dai suoi autori, allora il mondo si sarebbe pentito di averlo disprezzato, e quando lo avesse cercato per conoscere la sua parola sul giusto vivere, avrebbe risposto di no.
Si promise di scrivere una Draculeide ma, oltre alla certezza di doverla comporre in esametri, neanche uno spunto da cui partire. Progettò un romanzo su un ragno che imprigionava donne e uomini al fine di accudirli come bambolotti, ma si impelagò nella descrizione della grotta del protagonista. Accumulò appunti per dei dialoghi fra la Morte e la Letteratura, ma cosa avrebbero avuto da dirsi? Insomma, si accorse di non essere in grado neppure di immaginare: persino i suoi sogni erano vacanti, quasi sempre scene al buio in cui provava un’infinità d’angosce e si sentiva come paralizzato. Solo un’idea tornava a proporglisi, scrivere le proprie memorie. Sembrava fertile, ma continuava a rifiutarla. Esporsi con un narratore omoautodiegetico? Fuori questione. Qualcuno prima o poi le avrebbe lette, avrebbe saputo da dove veniva, e questo non doveva accadere.
Gli fu necessario pensare la colpa fosse dell’ambiente universitario, con le sue aule funzionaliste, le sue scrivanie di resina, le sue sedie di poliestere e pellicola. Neppure la biblioteca, resa a suo avviso più simile a un ospedale dagli ammodernamenti, era lo spazio giusto per la creazione poetica. Si mise allora ad arredare l’appartamento come più gli sembrava coerente col suo proposito. Tappezzò le pareti con certe carte damascate rosso carminio, verde salvia e oro spento; riempì la sala con tavolini coperti fin sulle gambe da finti velluti, e con un enorme divano chesterfield in finta pelle percorso da spesse cuciture in finto cuoio, accompagnato da poltroncine uguali, spinto contro la parete sottile la cui penetrabilità sonora fu ovviata da un tappeto finto-persiano in poliestere, recante il disegno di un serpente avvolto in spire. Il resto dei muri della casa fu coperto da strani oggetti, tra cui piccoli tondi commemorativi con certe scene patetiche composte dai capelli del defunto: il preferito di Testa di Corvo ritraeva un cane uggiolante davanti la pietra tombale del padrone. Si circondò di mobili artificialmente invecchiati per sembrare d’epoca e libri, stampe e lampade nello stesso stile. Tuttavia, il risultato finale lo lasciò frustrato: la casa ancora gli appariva contaminata da uno spirito tenacemente contemporaneo, e ne attribuì la responsabilità agli oggetti di plastica. Quante delle cose di cui si era circondato — la plastica ha infinite forme, consistenze, usi — erano costituite anche solo in minima parte di quel materiale e, mioddio, quando provò a liberarsene si trovò la casa vuota. Ciò, gli rese chiara, in un colpo solo, la vanità di ciò che stava facendo.
Non potendo ricostruire il loro habitat, provò allora a adattare il proprio stile di vita a quello dei suoi autori più amati. Iniziò a osservare una dieta grassa, pesante e speziata, accompagnando piatti alsaziani, arabi, nord-italici, iberici con alcolici sempre più forti; ma presto quest’abitudine lo portò a disturbi del sonno che cercò di risolvere acquistando un enorme materasso in schiuma poliuretanica, largo due metri e mezzo e lungo tre, circondato da un baldacchino ricamato di stelle su sfondo blu notte, ricoperto di morbidi cuscini e tessuti che imitavano i più pregiati e delicati. Iniziò a vestire solo pigiami in ciniglia di acrilico verde bosco, profondo turchese e borgogna, e in quel narcotico ammasso sintetico passava tra le diciotto alle venti ore al giorno, anche a causa delle malattie gastrointestinali che avevano iniziato a colpirlo, costringendolo in posizione orizzontale quando non era seduto al bagno.
Testa di Corvo era deluso da quanto di queste malattie non avesse mai letto dovessero essere state un aspetto tanto fondamentale della vita degli artisti decadenti dediti ai paradisi artificiali che andava emulando. La morte, mettiamo per tubercolosi, l’aveva trovata romanzata a volontà, ma di artisti costretti per ore sulla tazza, ficcandoci dentro la testa o evacuando, nulla di nulla. Non c’era un racconto in cui si trovasser i flussi di acido che gli risalivano alla bocca a ogni momento del giorno, e nemmeno il grande amante del macabro aveva mai fatto cenno alle infuocate e sanguinolente scariche diarroiche che gli riempivano il bagno di mefitici puzzi e suoni ridicoli. Sotto questo punto di vista, considerava Testa di Corvo, la letteratura lasciava molto a desiderare quanto a onestà. Mise via anche quei libri, e per quanto ne sappiamo non lesse mai più.
Per il giovane atroce divenne impossibile mangiare se non cibi secchi e piatti mai composti da più di due ingredienti per volta. Non smise mai tuttavia di bere, nonostante le sofferenze che ciò comportava Lo stato di costante ubriachezza lo rese paranoico: se fino a quel momento aveva continuato a lasciare casa per far almeno spese, prese a ordinarsi ogni bene da lì, facendosi lasciar buste e scatole all’ingresso e passando le banconote sotto la porta. Oltre ad aprirli per gettare i rifiuti da quella del bagno che dava in un vicolaccio sul retro del palazzo, finestre e scuri erano sempre accostati, tenendo la casa in una costante penombra. L’oscurità notturna era alleviata da candele che Testa di Corvo consumava in gran quantità. Per del tempo fu Monaldo, l’unico ambasciatore del mondo esterno. Testa di Corvo lo accoglieva nell’abitazione e si intratteneva con lui nelle solite chiacchiere, ma presto smise di lasciare entrare anche lui e iniziò a pagarlo come faceva coi fattorini. Una condotta che rese sospettoso il presunto erede di Leopardi. Ogni giorno andava a battere alla porta d’ingresso, ed esasperato era giunto a urlare minacce di sfratto all’inquilino, che lo ignorava. A Testa di Corvo, di notte pareva di udirlo dall’altra parte della sottile parete del salotto, di sotto il tappeto finto-persiano, ridacchiare hi hi hi! e grattare contro il muro, parlando fra sé dei modi che escogitava per togliergli la vita. A un certo punto, avveniva sempre che il giovane, terrorizzato e insieme attratto da quei suoni, si infilasse sotto il tappeto per ascoltare meglio; ma a quel punto Monaldo avvertiva la sua presenza, iniziava a colpire forsennato la parete, facendolo sussultare e correre verso la camera da letto a nascondersi sotto le coperte del gigantesco letto fino al mattino successivo.
Andò avanti così per settimane, fin quando in una gelida notte d’inverno, mentre Maestrale soffiava alla finestra e Testa di Corvo vegliava a occhi sbarrati, Monaldo fece saltare in aria la parete con una carica di esplosivo. Corse urlando verso la camera da letto, ne scardinò la porta e si lanciò su Testa di Corvo brandendo un’arma orrenda che poteva trasformarsi in un enorme coltello di fibre muscolari affilate o in una pistola di sangue raffermo, a seconda della distanza che l’aggredito riusciva a stabilire fra sé e l’erede di Leopardi.
Testa di Corvo fuggì a piedi nudi, lanciandosi da un pianerottolo delle scale all’altro senza fermarsi, fino a cadere coi polmoni arsi dalla corsa sulla strada cittadina.

*
Gli era parso di trascorrere la lunga e scura notte aggomitolato nel buio di un vicolo, ma al sorgere del sole si guardò intorno e, sorpresa, Testa di Corvo era per strada, vestito di tutto punto come si esce per le passeggiate. Era arrivato poco lontano e, se impiegò tanto tempo per far ritorno all’appartamento, fu per via di un fatto inusuale: mentre camminava, senza che se ne avvedesse, la sua andatura si faceva più regolare, e la sua spina dorsale serpentina si stendeva verso il cielo.
Salì le scale fino al suo piano e trovò la porta aperta, entrò: le pareti erano intatte, la stanza da letto in ordine. Accatastò quello che poteva in due valigie. Testa di Corvo voleva tornare a casa.
Durante il viaggio, avendo immaginato che il vagone su cui stava stesse prendendo una direzione sconosciuta, cacciava mezzo busto fuori dal finestrino, cercando con affanno un punto di riferimento in grado di rassicurarlo. Gli altri passeggeri provavano a tirarlo dentro, ma tornava a sedersi soltanto quando ritrovava una collina o un edificio di cui aveva memoria. Fu chiamato il capotreno, un brav’uomo, il quale, davanti al mutismo di Testa di Corvo, si convinse fosse soltanto un pazzo che si era perduto l’accompagnatore. Lo portò allora con sé nella cabina di guida, dove il giovane riuscì a sedere sereno fino alla stazione di arrivo. Lì, il capotreno lo scortò alla corriera e lo raccomandò al conducente.
In quel pomeriggio del suo arrivo, il paese era deserto. L’ultima volta che ci era tornato con suo padre era stato cinque anni prima. Avevano trascorso una lugubre vacanza di due settimane, vegliando, il padre accovacciato, Testa di Corvo muso a terra e ventre a terra come un cane, presso il tumulo sotto cui riposava la madre.
Il giardino era ormai inselvatichito; circondato da muretti in pietra e protetto da un cancello, abbandonato da tanto tempo, aveva preso un’aria gotica. Ciò che restava della tomba si distingueva soltanto per un lieve rigonfiamento nell’edera, sotto il salice scosso dal vento. Dentro, le mura avevano l’odore del freddo. Tutto era al suo posto. La polvere aveva formato uno strano feltro fondendosi al cellofan che ricopriva i mobili, le orrende statuette dei due elefanti con le proboscidi incrociate, i telecomandi.
Nella tetra oscurità, sedette in una poltrona ancora avvolta nella pellicola con cui era stata portata dal centro commerciale. Fuori solo il rumore del Maestrale e il gracchiare dei corvi neri neri. Sentiva la stanchezza delle molte notti trascorse a vegliare. Stava per addormentarsi, ma fu scosso da un forte martellare che proveniva dal bagno, accompagnato da un respiro affannoso.
Dove andare, dove nascondersi? Scivolò sotto il letto che era stato dei genitori. Dal bagno continuavano il martellare e l’affanno; si distingueva di tanto in tanto un creeeak come di legno che si pieghi sotto un peso. Dopo un tempo indefinibile, nella stanza entrò uno spettro. La visione si infilò sotto il letto accanto a Testa di Corvo. Era, certo, sì, doveva essere una gallina: aveva i bargigli, i garretti, e un delizioso piccolo becco, ma emanava una luce fluorescente e muovendosi trascinava dietro sé un vapore. Prese a becchettarlo sulla guancia. Coot noc noc noc pcoot, faceva la mamma mentre lo ricopriva di baci. Gli fece segno con la testolina di seguirla fuori da quel rifugio, e Testa di Corvo le obbedì, ma immediatamente lo spettro scomparve com’era apparso, lasciandolo con una caldissima tristezza nel cuore.
Aprì la porta. Trascorsero diversi secondi di silenzio. Seguirono il suono di un accendino e una piccola fiamma, che illuminò un volto solcato da una mostruosa cicatrice cucita con spessi punti di sutura di cuoio, che lo divideva esattamente a metà. Il viso dalla cicatrice esplose in una risata gioiosa, dalle tenebre vennero fuori due braccia nude che lo strinsero a un petto ossuto, come ritrovando un amico perduto da lungo tempo. La sua coscienza vacillava, e un secondo si sentiva pieno d’orrore, l’altro pieno di felicità. L’uomo dalla cicatrice continuava ad abbracciarlo con un tale amore che la bocca di Testa di Corvo divenne una mezza luna di sorriso.
Lo strano compagno lo prese sottobraccio e gli mostrò, alla fioca luce dell’accendino, gli angoli del bagno puliti e brillanti, come a fargli intendere di essersi preso cura di quello spazio in cui era stato confinato. Infine, con due fiammate una più intensa dell’altra, l’accendino rivelò la presenza nella vasca di uno smisurato serpente avvolto in spire. La vista dell’animale terrorizzò Testa di Corvo che tese le braccia verso la porta per scappare, ma l’altro gli prese il volto tra le mani costringendolo a guardare al rettile. Ora scoprì sul viso dell’animale un’espressione umana, vuota di ogni piacere e dolore, ma piena di una noia insostenibile. Sentì tornare la tristezza lasciatagli dall’apparizione del fantasma, e un pianto lunghissimo di lacrime brucianti iniziò a scorrere dai suoi occhi al pavimento, formando presto una larga pozza. L’uomo dalla cicatrice vi scagliò sopra la fiamma, il liquido lacrimale prese fuoco e l’intero bagno fu investito di verdi fiamme.
Si sentì riempire di luce e calore, e udì il compagno lanciare un urlo di gioia. Si voltò verso di lui e lo vide invitarlo a fare lo stesso. Timidamente un fiato uscì dalla gola di Testa di Corvo, e sempre più forte scagliò la voce al soffitto, fino a unirla a quella dell’uomo prima in un canto all’unisono, poi in degli inspiegabili controcanti, come fossero un coro. A questa musica il serpente si rizzò altissimo, liberando dalla gola un’altra potente fiamma che riempì l’intero soffitto. Una forza elettrica attraversò ogni cosa. Ci fu un’esplosione, si sentì la plastica bruciare, e le finestre saltarono dai cardini.
Aprì gli occhi e si ritrovò da solo, illuminato da un riverbero del sole al tramonto, fra il fumo nero di diossina.

*
Il bosco si trovava a pochi metri. I primi alberi s’incontravano dopo una breve salita e subito la vegetazione s’infittiva. La sera imbruniva nella notte mentre, correndo sul terreno duro nell’aria ferma e ancor più diaccia dei faggi tra cui andava smarrendosi, perfetto nella nuova armonia del corpo nudo, il viso artisticamente rimodellato, Testa di Corvo prendeva la via della montagna agitando le braccia come ali, gracchiando Cra! Cra! Cra!
Cadevano i primi fiocchi di neve mentre le ultime luci del giorno si spegnevano in fretta sopra le spoglie cime arboree; la flebile Via Lattea d’inverno scorreva come un fiume; Sirio era quasi un sole, di una luce bianca così intensa da produrre deboli ombre sulla terra. Bruciavano le costellazioni: il Grande Carro trainato da Alioth, e l’Orsa Minore guidata dalla Stella Polare; poi Cefeo, Cassiopea, il Leone, che preannunciava l’arrivo della primavera. E infine il Corvo, l’infausta.
L’infausta costellazione si presenta come un racconto coeso ma spasmodicamente progressivo, trasformativo ma semioticamente stringente, che rimbalza dal fiabesco oscuro a un ombratile bildungsroman per spiaggiarsi su un claustrofobico surrealismo onirico e aprirsi, infine, a un lirismo inaspettato lungi però dal riappacificatorio. Se su Limen Pastiche si propone una costante problematizzazione e messa in crisi dei confini tra generi e media, più rare sono le istanze di sbaragliamento interno, di (solo apparente) tradimento di un supposto ordine endogeno, che diviene però tanto più perturbante quanto più si misura, al contempo, con un andamento non frammentario ma stringentemente monomaniacale, quasi deterministico e fatalistico. Così, il protagonista Testa di Corvo si trova immerso in una spirale, in una traiettoria che traccia, piuttosto che una evoluzione, una contorta e quasi oscena cicloide accorciata: un eterno ritorno, una condanna aprioristica a una chiusura da ringkomposition drammaticamente predeterminata (dalla famiglia, dal nome, dal rapporto con la società).
A costituire la colonna di questa circonvoluzione, a supportarne e sopportarne il peso simbolico, è l’evoluzione delle immagini, delle metafore e degli stimoli che informano il racconto. Nella ricerca di un delicato e sottile equilibrio simbolico, temi e motivi si compenetrano, si fondono e rifondono in nuove e spasmodiche forme: il mondo di plastica che circonda i protagonisti assume, allora, di volta in volta il ruolo di un grottesco signum della follia consumistica dei di Corvo, di un marchio impossibile da grattare via per Testa, di un combustibile su cui immolare la propria follia.
Se nel precedente racconto di Ferone, Il coso del prete, lo svelamento inaspettato ma inevitabile di una realtà abietta irrompe nelle costruzioni mentali del narratore-protagonista, la riaffermazione opprimente della natura di Testa ribadisce l’inespugnabilità della propria predestinazione, il ritorno al punto di partenza, in una impossibile trasfigurazione che però, al contempo, lascia dietro di sé solo le ceneri del mondo che l’hanno innanzitutto dettata: “Testa di Corvo prendeva la via della montagna agitando le braccia come ali, gracchiando Cra! Cra! Cra!”.