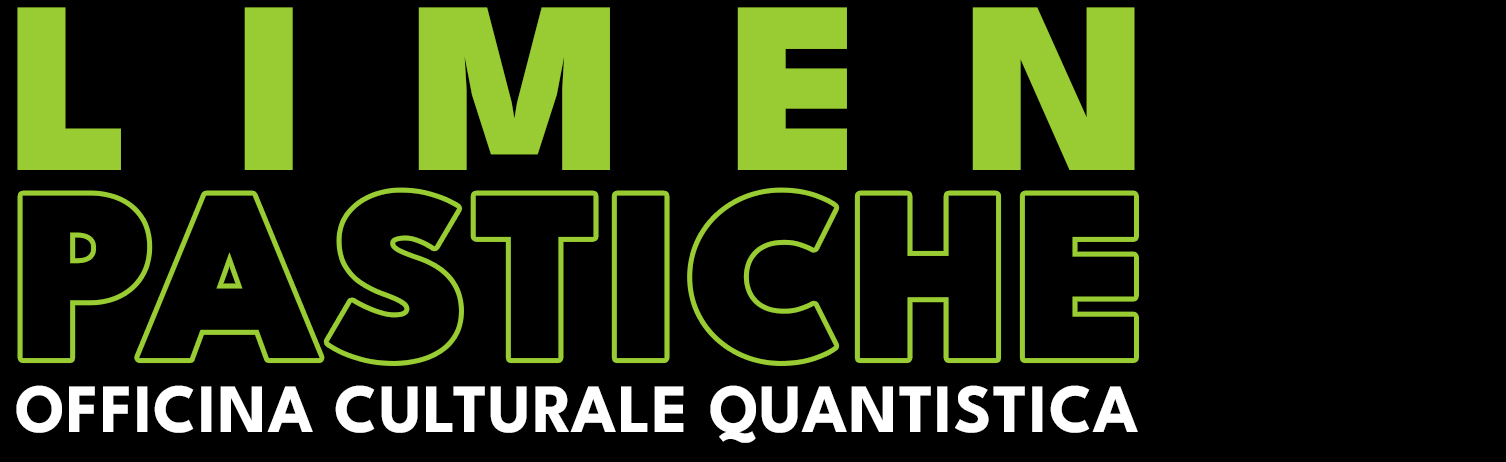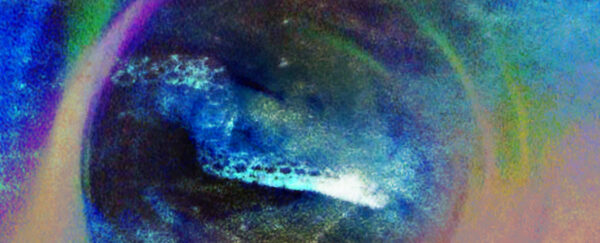Testi di
Simone La Penna
Copertina di
Simone La Penna
Editing di
Jacopo Abballe
Categoria
Corto-circuiti
Narrazioni rotte
Data di pubblicazione
20 Aprile 2023
Breve storia del mio pollice verde amputato
Le serie di stampe mi guardano dalle pareti della stanza. Le ho ricoperte completamente, ormai. Sono 23 serie di 23 stampe ciascuna. Possono sembrare molto simili, tutte queste foto di piante. Alcune serie sono persino sulle stesse specie. Anche volendo continuare a produrne, non sono sicuro che avrei lo spazio in casa dove metterle. Sono serie difficili da sistematizzare in un’unica cornice, anche se le fotografie sono del formato più piccolo concessomi dal negativo. Il problema è il numero: 23 è un numero primo. È nella sua natura resistere a ogni divisione precisa. Ci sarà sempre un eccesso. O uno spazio vuoto. Dipende da come la si guarda.
Vivevo già da solo quando è morto mio padre. È entrato in un ristorante e ha mangiato fino a provocarsi una rottura dell’esofago. Ha ordinato per 23 volte la stessa cosa: agnello al forno con patate e carciofi fritti come contorno. Ha mangiato compostamente dall’inizio alla fine, è il motivo per cui nessuno è intervenuto prima. È riuscito a finire tutte le porzioni, ogni volta impiegando sempre lo stesso tempo; alla fine si è semplicemente lasciato cadere all’indietro sulla sedia. Da quello che ci hanno raccontato, sembrava solo che stesse riprendendo fiato. Il medico legale ha accertato che la prima emorragia interna deve essere iniziata almeno intorno alla ventesima portata. Il cameriere che lo ha servito per tutto il pranzo non aveva modo di saperlo, non gliene faccio una colpa. Era sempre stato un uomo minuto, quasi emaciato, mio padre. Per quello che poteva intuirne, rischiava di sembrargli davvero solo qualcuno molto affamato e molto resistente anche dopo un simile quantitativo di carne. In realtà non credo che nessuno si sarebbe mai potuto accorgere delle sue intenzioni o di quello che l’agnello stava causando al suo corpo. Tendeva a sparire dalla percezione, a sembrare di non esistere. Probabilmente hanno smesso di prestargli attenzione attorno alla quinta ordinazione. A volte succedeva anche a casa, ci dimenticavamo della sua presenza. È una delle poche cose che sento di avere in comune con lui.
Non ho mai pensato a me stesso come una persona sola. Di sicuro non pensavo a me in questo modo quando ero bambino. Erano molti a dirlo, però. Io non ci ho mai creduto, rispondevo semplicemente che ero un bambino serio, figlio di due genitori seri. Seri nel senso di seriosi, non nel senso di coscienziosi, sebbene fossero anche quello. Normalmente, le persone replicavano che non gli sembravamo una famiglia seriosa, gli sembravamo una famiglia triste. Triste nel senso di infelice, non nel senso di patetica o squallida, sebbene fossimo anche quello, forse, soprattutto dall’esterno. A quel punto smettevo di ribattere. Avevano ragione, eravamo infelici, anche se non sapevo o non capivo il perché. Sono cresciuto con questa consapevolezza: eravamo infelici ma non eravamo soli. E nessuno sapeva il perché. E andava bene così. Ho capito che era il contrario solo dopo la morte di mio padre.
È successo mentre ascoltavo l’orazione funebre scritta da mia madre per il funerale. Lo so che sembra strano dire “orazione funebre”, ora come ora. Sarebbe più normale dire “elogio”, o anche solo “discorso”; personalmente, credo che sarebbe ancora più corretto chiamarlo “saggio”, perché alla fine non era niente di diverso da un saggio. Ma è il termine che ha scelto lei, lo ha specificato all’inizio: “Questa è un’orazione funebre, o un epitaffio. Voglio che sia chiamato così e in nessun altro modo”. È stata la prima e unica volta che l’ho sentita usare la parola “voglio”. È stata anche la prima e unica volta che l’ho sentita parlare così a lungo. In un’unica epifania di mezzora ho compreso che non conoscevo davvero né lui né lei. Ho compreso che non sapevo perché lo avesse fatto, e che non lo sapeva nemmeno lei. Ho compreso che non credevo avesse la forza morale e spirituale per suicidarsi in un modo tanto articolato, per architettarlo e metterlo in atto così metodicamente. Ho compreso che lo avevo sempre sottovalutato, inconsciamente. Ho compreso che avevo sempre sottovalutato, inconsciamente, anche mia madre. Non ha mai pianto per la sua morte. Invece è salita sull’altare e ha analizzato sistematicamente la vita di mio padre. Non cercava una spiegazione: aveva da subito abbandonato ogni velleità di razionalizzare la cosa. La sua era un’analisi puramente estetica: sempre nella sua “introduzione” l’ha definita “una lezione sulla semiotica del suo suicidio, un elogio della sua sobrietà, dell’epurazione di ogni possibile ridicolaggine nel suo gesto, della ricerca di una perfezione formale nei suoi più minuti particolari”. Anche il passaggio in cui paragonava la sua morte alla scena della bistecca nei Simpson è stato notevole. Ci ha garantito l’ostracismo definitivo dal resto della nostra famiglia.
Ho compreso che non erano infelici. Erano soli. Nessuno dei due si percepiva più, forse da anni.
Ho compreso che non ero infelice. Ero solo. Non li avevo mai capiti.
Nel suo elogio, mia madre ha raccontato anche del loro incontro. Si erano messi insieme quasi subito dopo essersi conosciuti. Questo perché mia madre era stata l’unica a capire cosa intendesse mio padre quando, all’università, aveva commentato “So it goes” dopo che il loro professore di critica letteraria aveva annunciato in lacrime la morte di Roland Barthes. La citazione è di Vonnegut, Mattatoio n.5, e la ripetevano spesso entrambi, quando moriva qualcuno. Conoscevo già la storia, e avevo letto il romanzo quando avevo quindici anni. Ho sempre pensato che lo facessero senza un briciolo dell’ironia originale di quella frase. Mi sembrava che la loro fosse solo una constatazione di fatto, un semplice e diretto riconoscimento della caducità della carne: “È morta mia nonna” “So it goes”.
Ora non ne sono più così sicuro. Mio padre raccontava spesso una storia, faceva più o meno così: due uomini d’affari portano a mangiare in un ristorante francese un loro collega giapponese appena arrivato in città; alla fine del pranzo, i due uomini d’affari decidono che al posto del dolce vogliono provare il carrello dei formaggi, solo che quando arriva il suddetto carrello il collega giapponese impallidisce e comincia a mangiare con gravità, perché non sa che quelle sul carrello non sono le porzioni effettive e che ovviamente non è obbligato a finire tutte le forme, e al contempo il proprio galateo tradizionale lo costringe almeno a tentare di finire tutto quello che gli viene portato; quindi il collega giapponese si ingozza come un forsennato, perché spera che la sua agonia alimentare possa finire anche solo mostrandosi appagato da quest’ultima porzione devastante, ma prevedibilmente le sue intenzioni non vengono capite dai due uomini d’affari, che invece si danno tanto di gomito e si congratulano con lui perché è davvero una buona forchetta; è solo quando il collega giapponese stramazza con la testa in una forma appena iniziata di Pont-l’Évêque che i due uomini d’affari cominciano a insospettirsi e sono costretti alla fine a chiamare un’ambulanza per fargli fare una lavanda gastrica. Ovviamente, la storia terminava sempre con lui che chiosava “So it goes”, spesso mentre addentava un pezzo di parmigiano. Ovviamente, l’ironia della storia era l’unica parte che gli sfuggiva, o almeno così credevo. Ovviamente, anche questo è stato ricordato da mia madre nella sua orazione. È un altro dei motivi per cui siamo stati ostracizzati: sebbene nessuno lo abbia mai sostenuto apertamente, erano tanti a pensare che avremmo potuto prevederlo, che i segnali c’erano tutti, e che l’insistenza su quella storiella squallida e facilona ne fosse la prova inconfutabile. Forse ha fatto male a ricordarla a tutti così platealmente. Lei ci vedeva della poesia, gli altri del grottesco.
È una storia vera, diceva mio padre. Non ci ho mai creduto molto, e mi sono sempre vergognato troppo per fare una ricerca e controllare. Non credo neanche che fosse il suo modo per chiedere aiuto, in realtà. Come non credo, o non credevo, che centrasse molto l’ironia, in quel racconto. Per come la raccontava, alla fine, somigliava più a un monito contro la poca morigeratezza col cibo. Una storia edificante e con una morale ben precisa. Adesso so che ero io a non capire, che per lui era davvero una battuta. Forse, semplicemente, la sua piccola tragedia umana era che non la sapeva raccontare.
Non lo so, come fa una persona come mio padre a scegliere di suicidarsi in una maniera del genere, se davvero pensa alla morte così freddamente? E come fa una persona come mia madre a metabolizzare la morte citando i Simpson a un funerale? Come ho detto, non li conoscevo, ero solo. “Signora, suo marito si è suicidato a forza di abbacchio e carciofi fritti” “So it goes”.
Nessuno in famiglia era appassionato di giardinaggio, anche se tenevamo alcune piante aromatiche sul balcone. Ma anche di quelle poche non ci interessava molto, il loro destino era quello di morire ogni volta che ci allontanavamo per poco tempo da casa ed essere rimpiazzate al nostro ritorno, senza soluzione di continuità. Anni dopo ho capito perché ogni volta che ne piantavamo di nuove la loro probabilità di sopravvivere era sempre minore: nessuno di noi aveva mai davvero imparato a interrarle. Le usavamo anche poco. Forse per questo ho sempre ritenuto il calendario lunare che tenevamo in casa l’elemento più dissonante della nostra famiglia. Non lo compravamo noi, era un regalo annuale di mia nonna materna. Serviva come indicazione su quando innaffiare, potare, trattare, concimare le nostre misere piante, almeno teoricamente. Praticamente, nessuno lo ha mai seguito. Eravamo tre persone metodiche, per il resto. Era solo che non ci interessavano molto, quelle erbe. Non le sentivamo parte della nostra monotonia; temo ci disturbasse la loro involontaria resistenza, la loro propensione alla crescita. Credo che avrebbero preferito morire il prima possibile, se avessero potuto scegliere, vedendo in che mani erano finite.
È stato solo dopo la morte di mio padre che le nostre piante, che all’epoca erano già da tempo le piante dei miei genitori e adesso erano appena diventate ufficialmente le piante di mia madre, hanno smesso di morire. Non erano rigogliose né in grande salute, almeno all’inizio. Semplicemente sopravvivevano. Mia madre non sembrava curarsi di questo cambiamento, e se è per questo non dava neanche segni di esserne la causa. Semplicemente accadeva, e vista dall’esterno non è detto che la cosa le piacesse. Ma comunque erano lì, e crescevano, per quanto lentamente.
Una volta che sono andato a trovarla c’erano un paio di guanti da giardinaggio sul davanzale di una finestra che affaccia sul suo balcone. Si vedeva che erano stati appena usati, e sembravano essersi già integrati nel loro angolo, sembravano essersi già liberati dell’aura alienante e perturbante che normalmente avrebbero avuto in quella casa. Quando mia madre si è accorta che li stavo osservando, si è limitata a buttarli in uno dei ripiani affollati del mobile del balcone e mi ha invitato a venire a mangiare.
Non ne ha mai fatto parola, né io ho mai voluto aprire il discorso. Non sono sicuro che sappia lei stessa perché abbia iniziato a curare quelle piante. Non è un modo di elaborare il lutto, almeno di questo sono abbastanza sicuro. Ha già elaborato da tempo la morte di mio padre, il giorno del funerale o forse quello prima, quando ha pensato e scritto l’orazione. Lì sull’altare era sola, ma non era infelice. Come mio padre, che è morto solo ma non infelice. All’obitorio aveva ancora il sorriso un po’ provato ma soddisfatto di quando aveva terminato di mangiare. Temo che mia madre non abbia mai compreso quanto puntuali fossero i suoi parallelismi funebri: sembrava davvero il camionista dei Simpson che muore beato dopo aver consumato con garbo la sua bistecca.
Quel giorno sono tornato a casa con in mano un mazzo di erbe aromatiche. Mia madre aveva bisogno di liberarsene, le piante erano cresciute troppo e lei da sola non riusciva ad usarle a sufficienza per contrastarle in questa loro nuova rigogliosità. Anche se non sapevo cosa farmene non ho insistito perché le tenesse. Non aveva neanche un sacchetto dove metterle, ho dovuto portarle strette nel pugno come un mazzo di fiori. A casa non avevo un vaso adatto a contenerle, e ancora meno sapevo come pulirle, eventualmente; al suo posto ho usato un barattolo, mettendocele intere con tutti i rami. Un inquietante bouquet che non rendeva molto più gioioso il mio bilocale. Non sarebbe sparito, non per mano mia. Non sapevo il nome di metà di quelle piante. Non sapevo come usarle, non potevo fare altro che aspettare che appassissero o marcissero o ammuffissero o scegliessero un altro modo ancora per darmi una scusa per buttarle. L’unica cosa che potevo fare nel frattempo era fotografarle.
Sono sempre stato un fotografo mediocre. Lo è la mia attrezzatura e lo sono i miei materiali. Lo sono soprattutto le mie capacità tecniche ed estetiche. Sono mediocri i miei soggetti, sono mediocri le inquadrature che scelgo per riprenderli, sono mediocri le stampe che realizzo. Non ho mai imparato a sfruttare i bianchi puri e i neri pieni, i miei negativi sono distese inconsistenti di grigi indefiniti. Su tutti i miei libri di fotografia si dice che i negativi devono essere brutti, che non devono sembrare attraenti, almeno allo sguardo di un fotografo alle prime armi. Io non sono alle prime armi ma i miei negativi mi appaiono ancora brutti, e come ho detto prima lo sono soprattutto le mie stampe. A volte non trovo differenze tra i due, tra il negativo e la sua stampa. Non è neanche una questione di sfumature, di eleganza nei grigi: le mie fotografie sono torbide, nascono già vecchie sotto l’ingranditore che mi sono trascinato nel bagno del mio appartamento. Anche la scelta di scattare con la pellicola è parte di questa mediocrità, mi sono solo limitato a riutilizzare l’attrezzatura di mio padre. Non è stata una vera scelta, piuttosto la mancanza di una scelta, e l’incapacità di ripudiarla quando ho capito essere quella sbagliata. Sono un fotografo mediocre ma prolifico, e a parte il cibo il mio stipendio, che di per sé non è molto alto, se ne va soprattutto in pellicole di seconda scelta, chimici semi-esausti, carte scadenti e libri usati. Una scelta antieconomica, una scelta banale, una scelta dettata solo da quello che vomitava il garage angusto di famiglia.
L’unica cosa in cui eccello è la costruzione di serie delle mie fotografie. Non che tolga molto alla loro mediocrità: i miei soggetti rimangono alieni a me in primo luogo, fotografo soprattutto quello che non capisco, quello che mi fa paura, e l’alterità di quello che esce dalla mia camera oscura non mi aiuta a dissipare questo senso perturbante. Si limita a frapporre una distanza. Una distanza di grigi.
Quei rami rachitici non li comprendevo. Allora li ho fotografati. Non era quello il loro posto. Quindi li ho resi delle stampe di indecifrabili grigi sovrapposti. Non per eternarli, ma per renderli inanimati. Non per proteggerli dalla loro stessa fragilità, ma per privarli della loro stessa vitalità. Per renderli innocui, anche se le mie stampe non lo sono.
Mi sono fermato alla ventitreesima fotografia, semplicemente perché era finita la pellicola. Quando ho terminato l’incorniciatura della serie ho deciso di appenderla in camera, sulla parete ai piedi del letto. La guardavo mentre aspettavo di addormentarmi. Le mie fotografie sono come credevo che fosse la mia famiglia quando ero bambino: sono infelici, ma almeno non sono sole. Adesso, mentre osservo le altre serie che ricoprono il resto delle pareti, mi chiedo se non sia il contrario anche per loro, se in realtà non sia solo io a non capirle, ma anche loro a non comprendersi a vicenda.
Le mie prime piante sono arrivate solo qualche giorno dopo.
Ho un collega appassionato di cinema e di giardinaggio. Anche nel suo caso sono eredità della sua famiglia. Ma a differenza mia sono eredità che ha scelto, su cui ha controllo. Una volta a settimana viene da me e ci vediamo un film. Di solito non guardiamo più di dieci minuti di seguito, mette spesso in pausa per spiegarmi qualcosa. Non sono un esperto, e non ho imparato a esserlo dopo averlo incontrato. Forse lo fa perché crede di istruirmi, o perché gli piace parlare di cinema con qualcuno che non può interromperlo, o ancora perché pensa che sia la naturale evoluzione delle mie abitudini fotografiche. In realtà io lo faccio per non dargli un dispiacere. Quella settimana aveva scelto La Grande Boufee, un film su quattro uomini che scelgono di mangiare fino a morire. Non credo che mio padre lo conoscesse. Anche lui non era un esperto di cinema, non se n’era mai interessato. Ma non lo posso sapere: non lo conoscevo.
Ho aspettato la fine per dire al mio collega che mio padre era morto nello stesso modo, pochi mesi prima. Era solo una constatazione, non volevo farlo sentire in colpa. Ma lui ci si è sentito comunque. Non aveva capito le mie intenzioni, che erano soprattutto quelle di dirgli che era davvero possibile per qualcuno scegliere quel suicidio, che si può davvero mangiare fino a morire, e che in realtà il processo per qualcuno può essere ancora più sereno di quanto non lo fosse per quei quattro. È stata la prima volta che siamo rimasti in silenzio per più di dieci minuti. Quando il silenzio si è fatto insopportabile, almeno per lui, si è alzato e ha preso i rami dal barattolo, prima di andarsene.
Il giorno dopo mi ha portato tre piccoli vasi a lavoro, pieni di terra e con i rametti che aveva trovato a casa mia. Spuntavano con fierezza dalla terra bagnata, e comunque dimostravano tutta la loro fragilità residua, legati com’erano a delle cannucce di bambù per farli stare in piedi. Mi ha spiegato che erano delle talee, un modo per far crescere una nuova pianta da un solo ramo. Mi ha spiegato anche come curarle, quando innaffiarle e quanto ci avrebbero messo a crescere. Mi ha regalato del concime liquido e dei pezzetti di coccio. Servono per metterli sul fondo dei vasi prima di riempirli di terra, mi ha detto. Ho accettato tutto come avevo accettato i primi rami di mia madre, perché non volevo deluderlo.
Un rametto di rosmarino, un rametto di salvia e un rametto di menta. Nessun “So it goes” per loro.
Prima di tornare a casa sono passato a prendere qualche pellicola. Quando sono rientrato ho cominciato a fotografare le mie nuove talee. Le serie di 23 fotografie sono venute spontanee, solo perché così era la prima. Anche questa è una scelta antieconomica: le pellicole che uso hanno 36 scatti; quel numero primo complica sempre le cose. Quando finivo una serie la appendevo accanto alla precedente; ogni serie rendeva più sola la precedente. Una distanza di grigi anche nella contiguità.
Il mio collega ora viene sempre da me con una nuova pianta, ogni settimana. Di solito è un fiore. Di solito appassisce o marcisce entro una decina di giorni. Mi dice che ci metto troppa acqua, o troppo poca. Mi dice che le metto nei posti sbagliati, che è sbagliata la stessa esposizione del mio appartamento. Prova a disporle lui, prova a trattarle quando viene a casa. Muoiono comunque: “So it goes”. Poi controlla le talee: adesso sono delle piante vere e proprie, e a me fanno paura. Sono cresciute da sole, anche se disattendevo i suoi suggerimenti, anche se le innaffiavo e le concimavo nei periodi sbagliati, anche se potavo male le parti secche, anche se erano esposte male. Gli chiedo spesso se gli sembrino infelici o sole, o entrambe. Mi risponde sempre che secondo lui sono felici e mai sole, che a volte resistono solo perché è così che deve essere. Mi dice che ognuno ha un pollice verde, che il mio semplicemente è amputato. Continuo a fotografarle in tonalità di grigi indistricabili.
È il solo che abbia mai visto le mie serie. Anche le mie fotografie di queste piante non gli sembrano né infelici né sole. Non lo inquieta quello spazio anomalo dove manca la ventiquattresima fotografia. Non capisce mai di quale pianta sia ogni fotografia, ma distingue i grigi. Io non lo so fare.
Ho deciso che farò la ventiquattresima serie, anche se non ho lo spazio dove metterla. Forse la darò a lui. Forse la darò a mia madre. Non lo so. Non so se diventeranno una contiguità di grigi, in mano loro. Le piante di mia madre continuano a crescere, potrei fotografare anche loro. O quelle del mio collega. Forse non la vedrò, la loro solitudine. Forse non mi faranno paura.
Questo racconto, breve nella lunghezza e asciutto nello stile, lega cose tra loro molto diverse in modo insolito: delle piante che appassiscono e uno stomaco che si riempie fino a scoppiare, l’ossessione sistematica di un fotografo dilettante e un’orazione funebre particolarmente fredda e distaccata. Eppure queste situazioni si presentano al lettore in modo talmente spontaneo da farle percepire come foglie dello stesso ramo. Un ramo che l’autore restituisce con lucidità fotografica. Sta dunque a noi capire come guardare questa storia: se segnalare quella solitudine inquietante che vi ritrova il suo protagonista, o se rintracciare la speranza per una vita il cui senso può riscoprirsi nell’amicizia e nell’arte. Il carattere fondamentale di questo racconto è proprio l’ambiguità, suggerita sin dall’inizio – una “breve storia” riportata da un titolo prolisso – e che investe anzitutto lo stesso atto del narrare: c’è di fatto una certa contrapposizione tra ciò che viene raccontato e come lo si racconta, tra il descrivere il silenzio di una famiglia e il dover rompere il silenzio per raccontarlo. Così come la solitudine del protagonista sembra in parte risolta dal suo mettersi in dialogo con il lettore.
Ma cosa ci viene raccontato esattamente? Nient’altro che l’insensatezza dei nostri gesti, il vuoto dell’esistenza, la caducità della carne. La morte mangereccia del padre si fa in questo senso emblematica: non solo si muore in un modo assurdo e grottesco, ma l’evento in sé è impossibilitato a spiegarsi, a risolversi. Si muore soli, in mezzo agli altri. In una delle sue ultime interviste, Marco Ferreri, il regista de La Grande Bouffe, rispose così a un giornalista che lo etichettava come solitario e burbero: “Sì, sono un solitario. Un solitario che vorrebbe morire in un bar, circondato da duemila persone.”